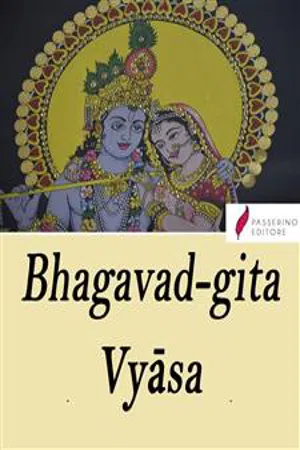Lett. I. str. 1. – Kuru o Kuruidi (Kāuravās) furono chiamati i Bharata dal nome di Kuru, nono discendente di Bharata, e Kuruk-setra o territorio dei Kuru fu detto il paese da loro abitato, ba-gnato dalle acque del Gange superiore e dei fiumi Yamunâ Sarasvatî e Drisadvatî. Questo territorio fu considerato santo, e difatti in esso si formarono e svolsero il Yagiurveda (veda delle formole sacrificali) e i Brâhmana (numerose raccolte di libri contenenti spiegazioni e considerazioni sul complicato rituale del sacrifizio, speculazioni teologiche, leggende di ogni maniera, consigli pratici per i sacerdoti sacrificanti ecc.), e da esso il culto e la cultura brâhmanica si estese a poco a poco a tutta l’India. – Nel Mbh. Kuru o Kuruidi sono chiamati sì i Pânduidi che i Dhritarâstridi, ma più specialmente que-sti come rappresentanti il ramo primogenito dei successori di Kuru.
str. 5. – Kaçi, città in vicinanza dell’odierna Benares.
str. 7. – I brâhmani o sacerdoti costituiscono la prima e la più elevata delle quattro caste del popolo indiano.
str. 12. – Il vecchio avo dei Kuru è Bhîsma, il più anziano di tutta la sua stirpe, cfr. il riassunto del Mbh.
str. 14. – Madhuide (Mâdhava), secondo il Lassen, era chiamato Krisna perchè appartenente ai Madhu, una delle tribù dei Yâdava; secondo altri perchè uccise un gigante o demone di nome Madhu.
str 15. – Irtocrine, in sanscr. hrisîkeça, parola, che i commenta-tori indiani derivano da hrisîka «senso» (però con questo significato non si troverebbe altrove) e îça «signore», e alla quale danno il senso di «signore dei sensi». Probabilmente invece deriva da hris = lat. horreo «rizzarsi» e keça = lat. caesaries.
Pânciagianya è il nome della conchiglia – qui genericamente strumento da fiato – fatta colle ossa del gigante o demone Pancia-giana, ucciso da Krisna.
Vincitor di ricchezze (dhanamgiaya), epiteto eroico dato a Argiuna.
Panciadilupo (vrikodara), appellativo di Bhîma datogli per la sua voracità e ferocia.
Arundinea (pâundra) fatta di pundra o canna saccarifera.
str. 20. – Dalla scimmia sulla bandiera (kapidhvagia). Gli eroi indiani portavano sul loro carro di guerra le loro bandiere, e Argiuna sulla sua aveva l’effigie di scimmia.
str. 21. – Incrollabile (acyuta) è detto Krisna non come eroe, ma proletticamente come dio.
str. 24. – Crinritorto (gudâkeça) da guda «acconciatura, quale usavano i brâhmani, dei capelli raccolti in treccia e disposti a cono sul capo» e keça «capelli». Argiuna portava tale acconciatura in se-gno di religiosità.
str. 30. – Gândîva è l’arco divino che Soma dette a Varuna, Va-runa ad Agnì (al fuoco), Agnì ad Argiuna.
str. 31. – Capelluto (keçava) qui equivale a Irtocrine.
str. 32. – Padrone di buoi o pastore (govinda) è detto Krisna, il quale appena nato fu dai genitori, Vasudeva e Devakî, portato sull’altra riva della Yamunâ per sottrarlo alle insidie dello zio Kamsa, che voleva metterlo a morte, chè una voce dal cielo l’aveva avvisato che l’ottavo figlio di Devakî l’avrebbe ucciso. Là fu affidato al pastore Nanda, e crebbe tra i pastori amoreggiando colle pastorelle. De’ suoi amori con esse canta il Gîtagovinda «il canto del pastore», dramma lirico paragonato spesso al Cantico dei Cantici, e significante, per allegoria, l’amore dell’anima con Dio. – Del resto nel Mbh. Krisna è il conduttore dei Yâdava, popolo di pastori.
str. 35. – Madhucida (Madhusûdana) è detto Krisna dal nome del gigante o demone Madhu, da lui ucciso (cfr. nota a str. 14).
Il trimundio (trâilokȳa) comprende i tre mondi del cielo dell’atmosfera e della terra; secondo altri, del cielo della terra e dell’inferno.
str. 36. – Tormentatore d’uomini (Gianârdana) – appellativo dato a Krisna, incarnazione di Visnu – era probabilmente in origine il nome di un dio di qualche tribù Indiana identificato poi con Visnu-Krisna.
Predoni sono detti i Dhritarâstridi specialmente perchè dopo il tredicenne esilio de’ Pânduidi non vollero loro restituire, contraria-mente ai patti, la parte di regno, che loro spettava.
str. 41. – Vrisnide (Vârsneya) è detto Krisna da Vrisni, uno de’ suoi antenati.
str. 42. – Inferno. Il codice di Manu nomina ben 23 inferni, i quali sono destinati a determinate classi di peccatori, e d’uno di essi si fa la descrizione nell’ultimo libro del Mahâbhârata Lett. II. Su di essi vedi Ferd. Belloni Filippi, il Nâsiketopâkhyânam, in Giorn. d. Soc. Asiat. Ital. vol. XV.
L’offerta di focacce e di acqua si faceva da ognuno ai Mani de’ suoi antenati, i quali, quando fosse venuto meno quell’offerta, spenta la discendenza, cadevano in un inferno coll’ultimo di loro stirpe, che aveva mancato al dovere di procreare figli. Nel Mbh. (I, Lett. 45) si narra che l’asceta Giaratkaru, il quale esercitava gran penitenza, vide dei Mani (pitaras, letteralm. «padri») pendere col capo in giù nell’abisso attaccati a un cespo di erba, cui era rimasto un solo filo, mentre da un buco un topo lo rosicchiava. Dimandatili chi fossero ed offertosi di salvarli, quelli risposero ch’essi erano del-la famiglia brâhmanica dei Yâyâvara, caduti da un mondo puro ed in procinto di precipitare in impuro inferno per mancanza di discen-denti e che il merito della loro penitenza s’era con ciò consumato. «Ben abbiamo un rampollo, Giaratkaru, conoscitore a fondo delle sacre scritture, continente di grande pietà, pel cui fervore nella peni-tenza siamo a mal partito, giacchè egli non ha moglie, nè figli, nè congiunti. Digli in che condizione ci hai visti e che prenda moglie e n’abbia prole. Il cespo d’erba, cui ci vedi attaccati, era il cespo ac-crescitore della nostra famiglia, delle radici, che tu vedi in questa pianta, noi eravamo i filamenti corrosi dal tempo, la radice, che tu vedi mezza rosicchiata, da cui pendiamo, è quell’uno, il quale si è dato alla penitenza. Il topo, che tu vedi, è il tempo, che darà morte a Giaratkaru, la cui penitenza non varrà a salvarci. Caduti che noi sa-remo insieme con gli antichi avi, reciso dal tempo ancor egli cadrà nell’inferno». Giaratkaru allora si diede a conoscere ai suoi antenati e loro promise di ammogliarsi. – L’obbligo di aver figli è tanto im-preteribile, che una donna sterile può essere sostituita dopo otto an-ni, quella, di cui i figli sono tutti morti, dopo dieci, quella, che par-torisce solo femmine, dopo undici (Manu IX, 81), eccetto che, nell’ultimo caso, il marito incarichi la sua figlia di allevargli un ma-schio, che divenga suo e compia in suo onore la cerimonia funebre detta svadhâ.
⁂
Lett. II. str. 2. – Esclude dal cielo. I guerrieri morti valorosa-mente in battaglia vanno nel cielo di Indra (cfr. Visnupur. I, 6, 33, e la nota a str. 31-32).
str. 10. – Bharatide (Bhârata), o discendente di Bharata, è qui detto il vecchio e cieco Dhritarâstra, al quale Sangiaya narra tutte le fasi della battaglia.
str. 11. – Assennate parole sono quelle riguardanti i riti dome-stici.
str. 12. – Io, cioè Krisna, giacchè l’esistenza contingente è opera dell’Illusione, cfr. Bhg. II, 16 e la nota a IV. 6. Solo l’Essere supre-mo esiste veramente, e le esistenze singole ne sono manifestazioni varie.
str. 13. – L’Incorporato è l’Essere supremo in quanto anima e dà vita ad ogni singola persona, e come tale è designato con l’appellativo dehin o çarîrin «che ha corpo» (da deha o çarîra «corpo»). Spesso però si rimane incerti se devesi tradurre Incorpo-rato oppure uomo, anima umana, giacchè dehin e çarîrin e de-havat (letteralm. «fornito di corpo») e dehabhrit (letteralm. «corpo-rigero») nel linguaggio comune valgono anche uomo. Nel nostro poema devesi tradurre Incorporato, nel senso detto di sopra, in Lett. II, 13, in quanto v’è il contrapposto deha «corpo», in II, 22, dove c’è il contrapposto nara «uomo», in II, 18, in quanto l’accompagnano gli aggettivi eterno indefettibile immensura-bile, che non si possono dire se non dell’Essere supremo, in II, 30, perchè ivi chiaramente si riferisce all’Essere supremo; si deve invece tradurre uomo in II, 59, perchè vi si fa distinzione tra uomo asti-nente o meno, in V, 13, perchè c’è l’aggiunto vaçin «padrone della sua volontà», in XVII, 2, per la distinzione che vi si fa tra uomo e uomo, in XIV, 20, dove s’accenna all’uomo come individuo spiri-tuale, che può conseguire l’immortalità, mentre ciò sarebbe ozioso a dirsi dell’Essere supremo, in III, 4, dove del pari sarebbe ozioso a dirsi che l’Essere supremo può raggiungere la perfezione, in III, 40, dove è detto che il dehin è abbacinato e infine in VIII, 4, XII, 5, XIV, 8, dove abbiamo il plurale, e in XIV, 7, dove corrisponde al plurale della strofa seguente. Però in quanto l’anima di ogni uomo è identica coll’Essere supremo, si potrebbe, per non dire si dovrebbe, usando il linguaggio filosofico, tradurre in ogni luogo Incorporato, distinguendo di volta in volta con criterio dove si accenna all’Ente che anima l’esistente e dove all’esistente animato dall’Ente.
str. 26-27. – Uno solo è l’Essere e le esistenze singole sono me-ramente illusorie. L’anima suprema, cioè l’Essere supremo, si mani-festa per via dell’Illusione (mâyâ) nelle anime individuali, le quali, avendo un’esistenza, per quanto illusoria, propria, passano di corpo in corpo finchè si estinguono in Lui.
La credenza nella trasmigrazione delle anime, o metempsicosi, è estranea al Rigveda e se ne incontrano i primi accenni appena nel Çatapatha-Brâhmana (X, 4, 3), ch’è fra i più recenti Brâhmana: essa però doveva essere già profondamente radicata nell’animo degli In-diani al tempo di Buddha, VI sec. av. Cr., tanto che Buddha vi fondò su la sua dottrina, la quale consiste appunto nell’insegnare il modo di sottrarsi alle vicende del morire e del rinascere. Questa credenza è conseguenza logica e naturale delle speculazioni filosofiche del periodo dei Brâhmana, mediante le quali s’era giunto a riconoscere esservi un solo Essere (âtman o brahman) increato e imperituro, origine e essenza di tutte le cose, anima universale del mondo, di cui l’anima individuale è emanazione e con cui l’anima individuale è identica. Ma perchè ciò che non è non può essere mai e ciò ch’è non può cessare di essere (Bhg, II, 16), il mondo sensibile, che è passeggero, è illusione e di periodo in periodo torna in seno all’Essere vero unico eterno per poi diventare di nuovo (Manu I, 51-57). Ne consegue perciò che l’anima individuale non può essere eterna, che non può essere eterno il castigo dei peccatori, nè il pre-mio dei buoni, se questi non hanno conseguito la perfezione, e d’altra parte neppure i perfetti non possono esistere in eterno indivi-dualmente essendo identici coll’Essere supremo; essi quindi trove-ranno la beatitudine nel nirvâna, nell’annientamento cioè della esistenza individuale, nell’unione coll’âtman-brahman. – A questo, ch’è lo scopo supremo, il sommo bene, l’anima individuale giunge solo a traverso a numerosissime esistenze, nel corso delle quali può accostarvisi o scostarsene passando successivamente in altri esseri animati o inanimati e sostando più o meno a lungo quando nel para-diso (svarga) e quando nell’inferno; giacchè l’uomo, che compie atti religiosi per goderne il frutto, giunge al paradiso degli dei, di dove discende, consunto il merito delle buone azioni, per ripigliare la vi-cenda del morire e del rinascere ed essere soggetto anche a discen-dere la scala degli esseri in conformità della sue azioni nelle nuove esistenze, mentre i grandi peccatori, passate numerose serie di anni nelle terribili dimore infernali, sono condannati a rinascere in corpi d’animali o d’uomini d’infima specie; laddove per i peccati minori non c’è inferno, ma l’uomo rinasce erba, insetto, uccello, bruto, animale feroce, demone, lemure, in casta inferiore o barbaro, desti-nato a risalire la scala degli esseri, scontata la colpa, e a rinascere via via in casta superiore in conformità dell’opera sua. Solo chi possiede la vera scienza, riconosce cioè l’identità sua e del mondo con l’Essere supremo ed opera il bene senza proporsene il frutto, con Lui si congiunge cessando il pellegrinaggio della palingenesi (cfr. Manu XII, 53-91).
str. 31-32. – Il guerriero, che, compiendo il suo dovere, muore in battaglia, va nel paradiso di Indra, lo svarga; di cui vedi la descri-zione nell’ultimo libro del Mbh., e dove Yudhisthira trova i suoi nonchè i rivali Dhritarâstridi, le colpe dei quali furono lavate dalla eroica morte.
str. 33. – Contrarrai colpa, perchè dovere del guerriero è di combattere.
str. 39. – Il sistema filosofico sânkhya è da noi conosciuto solo nella sua fase più recente ed in testi recenti, e perciò ci riesce disa-gevole vedere la relazione con esso della dottrina fin qui esposta. Genericamente si potrebbe intendere le parole del testo come se suonassero: questo insegnamento ti fu esposto razionalmente. Su questo sistema cfr. R. Garbe, Die Sânkhya-Philosophie. Eine Dar-stellung des Indischen Rationalismus (Leipzig, 1894). – Anche il si-stema Yoga è da noi conosciuto solo nella sua fase più recente e, se-condo essa, ha poca relazione colla dottrina del Bhg. Yoga letteralm. vale congiungimento, unione, e, secondo il nostro testo, riguarda le pratiche dirette allo scopo di unire l’uomo colla Divinità.
Il vincolo delle azioni (karmabandha) è il legame che l’anima individuale, cioè dell’uomo, contrae nel fare le azioni, giacchè essa, dopo d’avere di esse scontata la pena nell’inferno o goduto il merito nel paradiso (non sempre del resto l’anima dell’uomo va dopo morte nell’inferno o nel paradiso, ma spesso anzi non meritando nè l’uno nè l’altro, rinasce in condizione superiore o inferiore a seconda della vita passata), rinascendo si trova nella condizione e colle disposizioni, che gli procurarono le azioni della vita precedente.
str. 42-44. – Il fiorito detto, cui si accenna, è quello di coloro che proclamano non esservi altra guida che i Veda. E tal detto è chiamato fiorito perchè, come ben dice lo scoliasta indiano, dà fiori belli ma caduchi e non frutti, giacchè (cfr. Bhg. IX, 20-21) quelli che seguono i Veda possono bensì giungere al cielo di Indra, allo svarga, ma dopo di avervi goduto il premio della virtù rinascono a nuova vita mortale. Si dice ancora che i Veda contengono molta varietà di cerimonie per giungere al piacere e al dominio, beni passeggeri, e questo vale specialmente per il Yagiurveda, benchè anche nel Rigveda le preghiere siano rivolte agli dei per ottenere beni materia-li, come vittoria sui nemici, lunga e prospera vita e il cielo dopo la morte, molti e valorosi figli, numerosi armenti, ecc. Nei Veda vera-mente non c’è accenno alla credenza nella trasmigrazione delle anime, però, radicatasi questa credenza nel popolo, ne venne che si credette che le buone azioni fatte per ottenere la beatitudine caduca del cielo procurassero più nobile nascita in una nuova esistenza ter-rena. Qui si riprova l’animo interessato dei credenti nei Veda, che si propongono un frutto alle loro azioni, mentre l’uomo deve, banditi i desiderî, disporsi alla contemplazione, che solo può dare la vera fe-licità, la quale consiste nel congiungimento col Nume.
str. 45. – Le tre qualità (guna), cui qui si accenna e di cui di-scorre ampiamente il Bhg. in Lett. XIII e il Codice di Manu in libro XII, 24-52, sono la bontà (sattva) la passione (ragias) e la tenebra (tamas), e ad essa si riferiscono i Veda, i quali promettono il paradi-so degli dei ai buoni, l’inferno ai malvagi e contengono preghiere per ottenere beni materiali e perciò transitori. L’uomo però, rappre-sentato nel nostro poema da Argiuna, deve divenire esente dalle tre qualità, anche dalla prima, poichè, dovendo mirare alla soppressione della sua esistenza individuale mediante l’unione col Nume, deve svincolarsi da tutte e tre queste qualità, che sono proprie delle cose esistenti (cfr. Manu XII, 24). A ciò egli può giungere coll’essere in-differente alle duplici impressioni dei sensi – p. e. il piacere e il do-lore, il freddo e il caldo, ecc. – donde nasce il desiderio e la ripul-sione (cfr. Bhg. VII, 27).
str. 46. – Seguo in questo luogo l’interpetrazione di P. E. Pavoli-ni, che spiega: «Come quando si può disporre di una massa sovrab-bondante d’acqua, nessuna utilità viene da una piccola cisterna, così a chi è immerso nella contemplazione del Brahman, gioia suprema e infinita, nessuna utilità viene dai Veda, piccolo ricettacolo di gioie limitate e radicate nel Karman (azione)» in Mélange Kern. – Leide, 1903, p. 141 sgg.
str. 50. – Il vero devoto lascia quaggiù le azioni ben fatte, per-chè non ne brama il frutto nè su questa terra nè nel paradiso (svar-ga), giacchè egli deve andare esente anche dalle qualità della bontà, com’è detto sopra a str. 45; tralascia tanto più quelle mal fatte, mos-se dalle altre due qualità inferiori: però non tralascia affatto di agire, perchè oltre alle azioni di libera scelta sonovi quelle inerenti alla propria condizione, le quali non si possono tralasciare (cfr. Bhg. III, 9).
str. 52. – Di ciò che sarà insegnato e ch’è stato insegnato (çrotavyasya çrutasya ca). Traducendo letteralm. si dovrebbe dire: di ciò che sarà udito, e ch’è stato udito, ma çruti propr. «audizione» in fatto di religione è la sacra e rivelata tradizione co-stituita specialmente dai Veda.
La fitta degli errori, cui qui si accenna, è la religione positiva politeistica del volgo, su cui veggasi Bhg. IX, 20-25, la quale è un modo imperfetto di adorare l’Essere supremo, mentre la verità con-siste nel conoscerlo nella sua vera essenza, alla qual cognizione sol-tanto pochi eletti possono giungere mediante la contemplazione.
str. 53. – Insegnamento (çruti), cfr. nota precedente.
str. 66. – Coscienza di sè, nel testo bhâvana. Lassen inter-petrò «sui conscientia», Thomson «reflexion», Lorinser «Sammlung des Geist’s» aggiungendo «am meisten dürfte im Deutschen hier der Ausdruck «Bei-sich sein» entsprechen», K. Tr. Telang «perseverance in the pursuit of self-knowledge», lo scoliasta indiano Çrîdhâra «meditazione (dhyâna)». La versione del Lassen dà un senso più consono al nostro testo, quando per coscienza di sè si intenda il sentimento che ha il devoto della propria identità coll’Essere su-premo, nell’unirsi col quale consiste la felicità – al qual concetto è informato il Bhg. -, laonde egli non essendo più accessibile ai desi-derî terreni ottiene la tranquillità assoluta dei sensi e dell’animo suo.
str. 69. – Il testo intende dire che per il volgo è notte scura quanto si riferisce alle cose divine, note invece a chi ha rinunciato alle cose sensuali, laddove l’asceta considera quasi fitte tenebre le cose sensuali, oltre le quali non assurge la conoscenza del volgo.
str. 70. – Vanno a finire tutti i desiderî, ossia i desideri si spengono, non movono cioè ad operare per soddisfarli.
str. 72. – L’estinzione nel Nume (brahmanirvâna), come risulta da vari passi del Bhg. è la cessazione dell’esistenza indivi-duale, la quale estinzione ha luogo quando l’anima ha acquistato la assoluta e immediata certezza che essa è identica coll’anima univer-sale, coll’Essere assoluto. Allora la morte stessa, quando giunge, nulla aggiunge alla sua felicità, ma toglie solo l’apparenza della dualità. Così l’anima consegue immortalità indefettibile (Bhg. II, 15; XIV, 20, 27), la vera salute (II, 51), che consiste nel non rinascere mai più (V, 17). Ma tale cessazione della esistenza individuale non implica la sua distruzione totale; l’anima penetra nel Nume (IV, 10; VI, 5; XVIII, 55), cioè si estingue nel Nume divenendo Nume (V, 24), anzi coesiste nel Nume col Nume, se vogliamo dare un si-gnificato soggettivo alle parole «anche nel tempo della dipartita, es-sendo divoti, mi conoscono (VII, 30)».
⁂
Lett. III. str. 5. – Le qualità naturali, cfr. nota a II, 45.
str. 6. – Gli organi dell’azione. Manu (II, 89-92) distingue undici organi dei sensi, di cui dieci esterni ed uno interno. Dei dieci esterni i cinque primi, detti organi dell’intelligenza, sono: l’occhio l’orecchio il naso la lingua e la pelle; gli altri cinque, detti organi dell’azione, sono: l’organo della parola le mani i piedi l’ano (l’apparato digerente?) e gli organi genitali. L’undecimo organo, in-terno, è l’animo (manas), che partecipa dell’intelligenza e dell’azione. Visto questo, conclude, sono vinte le due altre cinquine.
str. 9. – Sacrifizio è qualsiasi atto di culto reso agli dei e fatto per la finale emancipazione, cfr. IV, 23-33.
str- 10 – Il Signor delle creature (pragiāpati) trovasi già in-vocato nel filosofico inno 121 del libro X del Rigveda. Egli è il Nume ignoto, la cui potenza è manifesta in tutto il creato, di cui gli dei onorano i comandi; nelle leggende del Yagiurveda ricompare spesso e con contorni sempre meglio delineati e assumendo impor-tanza vieppiù grande. In Mâitr. Samh. I, 93 si dice che egli essendo solo e volendo creare le creature fece il sacrificio della sua stessa persona. Nella leggenda brahmanica posteriore egli è lo stesso Brahmâ.
L’importanza del sacrificio nella religione è straordinaria. Sopra s’è detto come il Signor delle creature c...