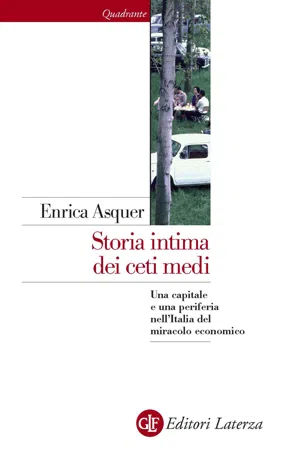IV. I tempi delle donne
1. «Fare la madre»
Ho avuto la Chiara dopo nove mesi meno quattro giorni, cioè mi son sposata il 19 maggio e lei è nata il 14 di febbraio, quindi io non ho mai fatto la sposina come si suol dire, sempre fatto la madre, perché, che mi ricordo io, ero sempre affannata con questa roba e quindi trovo che la pillola abbia dato molto spazio... Poi quelle femministe esagerate no, però che uno possa decidere della propria vita, sì. Voglio due figli perché dopo voglio studiare, voglio due figli perché voglio lavorare, è giusto!1.
Nata a Milano nel 1937, Lorella si era sposata nel 1962 e dopo nove mesi esatti era nata la prima delle sue due figlie. Lavorava come infermiera professionale presso la mutua della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la banca dove era impiegato suo marito. Una «scelta un po’ obbligata» questa: dopo il liceo classico e il diploma di infermiera alla Croce Rossa, avrebbe voluto viaggiare a bordo delle navi, per conoscere il mondo e, insieme, dedicarsi anima e corpo alla sua passione, la medicina. Sposarsi però significava metter su famiglia, darsi una stabilità e assecondare una scadenza improrogabile nei vissuti delle spose degli anni sessanta.
Queste ultime hanno condiviso una fase di transizione, sospesa tra un passato ingombrante e timidi cenni innovativi. Sul piano demografico, i primi segnali del cambiamento comparvero nella seconda metà degli anni sessanta: come è noto, una radicale trasformazione dei modelli riproduttivi avrebbe interrotto il baby boom di inizio decennio, riportando il tasso di fecondità, nell’arco di dieci anni, ai valori dei primi anni cinquanta (2,3 figli per donna) e, di qui, ai minimi europei toccati negli anni novanta (costantemente al di sotto di 1,4 figli per donna)2. A trainare questo nuovo trend sarebbero state principalmente le regioni settentrionali, nelle quali del resto era stato più intenso l’incremento demografico negli anni del miracolo3. Con maggiori censure e un’incomparabile solitudine rispetto alle proprie metaforiche sorelle minori4, fortificate dalla tensione collettiva degli anni settanta e dalla maggiore circolazione di informazioni e di libertà sull’uso dei contraccettivi5, le spose degli anni sessanta furono protagoniste della fase di incubazione di quello straordinario mutamento di sensibilità che avrebbe portato alla conquista da parte delle donne di una sessualità più consapevole, libera e distinta dall’orizzonte procreativo.
Le fatiche e le contraddizioni di questo percorso, ma anche le premesse del suo esito positivo, sono inscritte nei vissuti delle spose degli anni sessanta, a metà strada tra un coinvolgimento intenso nell’esperienza della maternità e la presa di coscienza di un desiderio, intimamente lacerante e socialmente non troppo legittimo, di esistere come soggetti oltre la sfera del materno. Questa difficile elaborazione rimase come eredità preziosa per chi sarebbe venuto dopo.
Nel corso degli anni settanta, Lorella, come molte sue coetanee, non avrebbe direttamente preso parte alla mobilitazione femminista, ma ne avrebbe compreso il senso6:
Enrica Asquer: «Secondo lei c’era bisogno allora di una mobilitazione collettiva su questi temi?».
Lorella: «C’era bisogno allora, perché allora eravamo molto chiuse [...]. Poi forse sono andate un po’ troppo oltre, però le manifestazioni ci volevano per aprire un po’ la testa alla gente, anche per rendere consapevoli le donne che avevano anche dei diritti, non solo dei doveri».
Con questa convinzione, Lorella avrebbe realizzato la sua personale forma di mobilitazione, traendo dalla sua esperienza la forza per esortare le colleghe più giovani e le pazienti a prendersi cura di sé in modo nuovo:
Diciamo che le donne hanno avuto un bell’aiuto dalla pillola eh, perché io ero una di quelle che propendeva o per la pillola o per la spirale, perché anche le ragazze con le quali io ho lavorato eccetera, venivano, si consigliavano e io dicevo «provate, fate gli esami e decidete e fate».
Dopo la seconda figlia, per Lorella prendere in mano la propria vita e far posto a se stessa sono diventati obiettivi importanti per cui lottare ogni giorno. Lotta ancora oggi durante l’intervista, Lorella, mentre la sua nipotina strilla e le impedisce di raccontare. La fatica di bilanciare tutto, di perseguire le passioni individuali, senza far mancare mai la presenza e la cura ai familiari, prima a marito e figlie e oggi anche ai nipoti, è la nota dominante della sua «doppia presenza»7, dentro e fuori di casa, per la famiglia e per se stessa.
Proprio il suo esempio ci dice, infatti, che la trasformazione profonda nella sensibilità delle donne avrebbe implicato la conquista di spazi personali, di libertà nuove nell’esperienza della sessualità e nella vita di coppia e, contestualmente, qualcos’altro: la stessa percezione della maternità mutava radicalmente, divenendo sempre più una scelta, un desiderio libero e intenso, anche se non meno carico di ambivalenze. Una maternità «educativa», più che una «biologica», si presentava altrettanto carica di aspettative sulle «capacità» delle madri; assorbiva emozioni e creava preoccupazioni, insicurezza e fatica, a donne che avevano attraversato la propria adolescenza e giovinezza in quegli anni cinquanta dominati da una «mistica della maternità» senza respiro. Le spose degli anni sessanta, infatti, portavano dentro di sé i segni di una cultura «puerocentrica» che costruiva attorno alle cure materne un mestiere relazionale sempre più ricco e, insieme, disciplinato8. Un mestiere che le faceva sentire innanzitutto madri, insostituibili e totalmente responsabili, madri senza le quali i bambini non sarebbero potuti crescere, madri colpevoli di qualsiasi disagio infantile; madri «per natura», per «destino», ma progressivamente deprivate della sicurezza di una competenza sempre più medicalizzata e professionalizzata9. Il progresso del sapere medico e la crescente visibilità assunta dalla responsabilità educativa materna avevano delle implicazioni ambivalenti e creavano nuove pressioni.
Rispetto a ciò, non è un caso forse che tra le narratrici milanesi di questa ricerca vi sia anche chi, a suo tempo, ha rifiutato la maternità, infrangendo quello che per le donne cagliaritane era ancora un tabù.
Nel condominio di via Rembrandt, le vicine di casa di Lorella, Adriana e Caterina, ad esempio, hanno condiviso negli anni la scelta di rinunciare alla maternità. All’intervista si presentano compatte. La prima, nata a Milano nel 1915, è la narratrice più anziana tra quelle incontrate. Ha vissuto sotto il fascismo, lodandone ordine ed efficienza, ma infrangendone principi cardine come il pro-natalismo10:
Io non ne ho costruito di famiglie! Io sono partita da bambina, a 5 anni dicevo che io non avrei voluto essere nata, dicevo a mia mamma, siccome era morta prima di me una sorellina e allora dicevo: «Ma perché non sono morta io invece?» e lei diceva: «Ma non dire quelle cose lì che il Signore ti castiga!». Mi fan pena i bambini, soprattutto una nazione così squinternata come è adesso. Con della gente così [...]. Ecco io dico: i bambini dovrebbero nascere e morire subito, almeno uno non si preoccupa più, e non ha la responsabilità di portare i figli in un mondo così, che non li merita. È un mondo che non merita, una generazione che cosa porta avanti? Che è tutto uno sfascio, è una cosa veramente ingrata.
Al cuore del discorso di Adriana, il mito della nazione risoluta e disciplinata si associa ad una lunga tradizione di pensiero che ha declinato la maternità ben oltre i confini di una domesticità privata, attribuendo alle madri la responsabilità di un maternage sociale, morale e civile11. Accentuata ma non corrotta dal filtro dell’oggi, questa concezione affiora quasi intatta dalla memoria e dall’esperienza della narratrice: negli anni quaranta, diplomata al conservatorio ma disoccupata per via della guerra, Adriana ha svolto sotto la direzione del Fascio locale compiti di assistenza alle famiglie povere e numerose: «Anche questa – spiega – era già una cosa per tenerci in riga, perché insomma la responsabilità di un popolo è grandissima. Certo, a qualcuno dava fastidio la troppa esigenza, però tutto filava dritto, non ci si poteva lamentare». Nella rievocazione idilliaca dell’ordine fascista e nel contrasto con l’oggi, che le appare dominato da uno «sfascio» complessivo e da un indebolimento del vigore della «nazione», Adriana lascia trapelare sommessamente, dietro la scelta di rinunciare alla maternità, motivazioni del tutto personali che si saldano, tuttavia, con una concezione più ampia ed esigente della responsabilità materna.
Su questo versante, ma con sfumature diverse, le sue convinzioni sono condivise dalla più giovane amica e vicina di casa, Caterina, nata in Puglia nel 1949 e sposa a Milano nel 1973. Con molta chiarezza le sue parole spiegano cosa potesse esserci dietro la rinuncia alla maternità: non solo la fatica del lavoro e della conciliazione dei ruoli, specie con un’attività in proprio da mandare avanti come il suo negozio di parrucchiera, ma anche, più in profondità, un’idealizzazione talmente granitica della maternità da suscitare un senso di inadeguatezza rispetto a quel compito:
No, no non abbiamo figli. È stata una scelta. Prima, appunto venendo da una famiglia numerosa, dissi a mio marito: «Senti per un anno o due, niente figli eh!» [...]. Poi, io ho sempre lavorato in proprio: io volevo fare la mamma a tempo pieno, cioè se io voglio un figlio, non lo voglio dare a lei, a lei, a lei, io me lo trovo grande che io non l’ho conosciuto mio figlio! È stata questa – d’accordo con mio marito – è stata questa la scelta principale. E poi per me è un compito molto, molto difficile, secondo me. Ecco questo è stato: io volevo fare la mamma a tempo pieno, perché io se posso... io non so neanche se posso avere figli, perché non ne abbiam cercati, ecco. Però secondo me la mamma deve essere a tempo pieno. Ecco, il compito troppo difficile... io ho nove nipoti e quasi quasi li ho tenuti tutti quanti io in negozio, perché lavorando in proprio... perché io adoro i bambini, non è che uno non vuole bambini [...]. A me piacciono i bambini, io adoro i bambini, io se dovessi fare qualcosa, farei un nido, un asilo nido, e i bambini che non possono e le persone anziane, le persone indifese, ecco, io sarei la prima a fare qualche cosa12.
Nonostante la rinuncia, o forse proprio alla base di questa, la maternità è stata nei pensieri e nei principi di Caterina un’esperienza totalizzante13, nutrita da una «mistica» per certi versi tradizionale (la famiglia numerosa, il mito della madre a tempo pieno), ma anche rinforzata da quella progressiva e più moderna accentuazione del simbolismo materno che si connetteva alla nuova esperienza di famiglie nucleari con meno figli da curare e amare sempre di più14.
A lungo, il materno avrebbe continuato ad essere un canone cruciale di auto-rappresentazione femminile, esattamente come dimostrano le parole, insieme sofferte e fiere, di un’altra narratrice milanese, sposa «ribelle» degli anni sessanta, ma madre «totale», che ha allevato in solitudine i figli nati da due matrimoni falliti:
Ero considerata da mia madre un po’ una ribelle [...]. Ma non sono ribelle, perché se fossi stata ribelle, non so cos’avrei fatto con tutto quello che m’è capitato a me. Diciamo che ci sono dei momenti, questo me lo dice anche mia figlia, la maggiore, che quando parlo, parlo in maniera fredda [...]. Loro me lo dicono spesso «sei cattiva». Si sono trovati davanti ad una madre che ha dovuto fare il padre anche praticamente, molto difficile, perciò figuriamoci... Fare i genitori non è facile, è già difficile fare la madre anche se uno è portato, perché io per esempio da ragazzina, ogni bambino o bambina piccoli che incontravo, bastava uno sguardo, una cosa, che mi venivan dietro! Praticamente ero portata ad avere questi rapporti con i bambini, con le bambine, perché ero piuttosto dolce con loro. Invece, poi si son trovati una madre che «com’è? Era dolce, adesso è diventata così dura» [...] e loro dicono «ma non ti chiediamo niente». Ma non è vero: volontariamente non chiedono, [ma di fatto] pretendono! E sì, pretendono, senza doverti imporre niente, perché loro non ti impongono le cose, però pretendono...