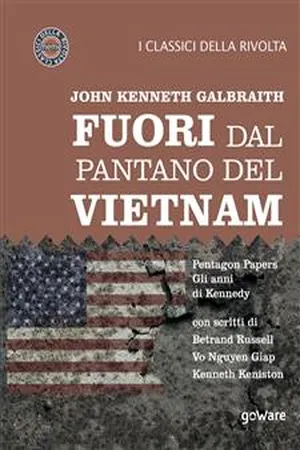![]()
1.
Le nostre esigenze e quelle dei vietnamiti
È mio intento, in questo breve scritto, delineare con concretezza una via di uscita dalla situazione sciagurata e sempre più disastrosa nella quale ci troviamo impantanati nel Vietnam. Sono partito, come è indispensabile faccia chiunque si proponga un compito del genere, da una serie di conclusioni preventive sulla natura di questa guerra, sullo stadio al quale essa è giunta, sul presente stato d’animo dell’opinione pubblica americana. Ho tentato inoltre di elaborare una soluzione che tenesse conto, alla base, di quelle che stimo essere le esigenze vitali minime dei protagonisti ivi comprese, in particolare, le nostre. Dirò anzitutto di queste esigenze.
Cominciamo da ciò che interessa agli Stati Uniti. Qualsiasi soluzione deve risultare accetta, in linea di massima, al popolo degli Stati Uniti o comunque possedere elementi del cui valore il nostro popolo possa, entro un lasso ragionevole di tempo, venir convinto. La cosa può sembrare ovvia; eppure nel dibattito sul Vietnam essa resta per lo più ignorata. La gente, e questo forse è comprensibile, propugna con decisione come unico corso possibile quello che le è personalmente più accetto. Chi continua a volere una vittoria militare non è toccato dalle diverse preferenze di chi giudica troppo alto, in termini di vite umane, di reputazione nazionale e di necessità domestiche, il costo di tale vittoria, né dalle opzioni di chi ne contesta la giustificazione morale. Questa impermeabilità è rafforzata da alcune tendenze che hanno preso piede nella condotta della nostra politica estera. Negli anni della Guerra fredda, in particolare, ci siamo abituati a dare troppa corda a chi si occupa della nostra politica estera e militare, molto di più per esempio di quanta ne concediamo ai responsabili dei problemi del lavoro o dell’agricoltura. Ai comunisti andava la reputazione d’essere assolutamente intrattabili: se la vedessero dunque gli esperti.
Di conseguenza al Dipartimento di Stato e al Pentagono regna oggi una notevole indifferenza per ciò che pensa l’opinione pubblica. Per riflesso abituale si scartano le opinioni esterne perché si vede in esse la conseguenza di una scarsa informazione, o di un eccessivo idealismo, o di una linea “molle”, oppure semplicemente perché danno fastidio. Se occorre esercitare opera di persuasione presso il pubblico si raggiungono cittadini che detengono certe posizioni chiave e li si invita a una seduta informativa non ufficiale, o a un pranzo a quattr’occhi. Agli altri, e specialmente a chi è un pubblico dissenziente, si ha cura di non prestare eccessiva attenzione: sarebbe un segno di debolezza.
Una tendenza parallela è però emersa anche tra i critici della guerra. Come dirò più avanti, pare ormai abbastanza chiaro che il nostro intervento nel Vietnam è nato da un grosso errore di calcolo, forse il più grosso errore di calcolo della nostra storia. Si è tentati di avanzare l’ipotesi che l’errore potrebbe essere corretto semplicemente invertendo il corso dell’azione, come fece il presidente Kennedy nel caso della Baia dei Porci (ignorando, si può aggiungere, le energiche obiezioni di chi tentava di insistere nell’errore originale o di estenderlo con l’invio di nostri aerei o con l’intervento delle nostre truppe). Ma se è quasi certo che i sostenitori della guerra stanno perdendo terreno tra l’opinione pubblica, molti americani sono ancora persuasi che noi siamo in campo per una giusta lotta o che stiamo in qualche modo “salvando” l’Asia sudorientale, o magari le Hawaii. E vi sono molti i quali vedono in gioco l’orgoglio nazionale e sono orripilati dall’idea di una “sconfitta” americana. Anche qui, si tratta di opinioni che non possono essere ignorate. Anche qui emerge la differenza tra quello che si può e quello che si vorrebbe fare: nella ricerca della pace come in altri campi il meglio, se non è nemico del buono, lo è per certo del relativamente migliore.
Qualsiasi soluzione deve anche risultare accetta ai sudvietnamiti. Qui ci sono di aiuto le recenti elezioni, giacché è difficile intenderle se non come un’ampia indicazione a favore di una pace di compromesso con il Fronte di Liberazione Nazionale (che si batte sul terreno nel Sud) e con il governo del Vietnam del Nord ad Hanoi. Se le elezioni fossero state davvero oneste, se cioè i due più forti candidati dell’opposizione, Au Truong Thanh e il generale (Big) Minh, entrambi sostenitori di una soluzione negoziata, non fossero stati esclusi dalla competizione, se dalle urne non fossero stati esclusi i neutralisti o chiunque passasse per filocomunista, se non ci fosse stata censura sulla stampa, se l’esercito e i gruppi delle minoranze non fossero stati sottoposti a forti pressioni perché votassero in blocco per i candidati militari, quasi certamente lo schieramento a favore della pace avrebbe assunto proporzioni ancora più vaste. Resta però il fatto che vi sono in quell’infelice paese alcuni milioni di persone che per una ragione o per l’altra, fede religiosa, convinzione politica, ambizione di potere, ricerca di personali profitti, o timore di essere perseguitati da una spietata polizia militare, si sono unite a noi nel nostro sforzo. Non possiamo, semplicemente, ignorare la loro esistenza: neppure per decisione della maggioranza si affida qualcuno alle sanguinarie attenzioni dei suoi avversari. Qualsiasi soluzione deve tener conto delle esigenze di quella minoranza di sudvietnamiti che temono di vedere salire al potere il Fronte di Liberazione Nazionale e i suoi capi comunisti.
Infine, non occorre dirlo, la soluzione deve essere accetta al nemico, cioè al governo del Vietnam del Nord o al Fronte di Liberazione Nazionale; e se non lo è, deve comunque essere elaborata in modo che la si possa portare avanti anche indipendentemente dal loro consenso. A mio avviso è qui che sostenitori e avversari della guerra hanno commesso tutti il loro grande errore. Molti avversari della guerra, ad esempio, partono dalla convinzione che i dirigenti di Hanoi e del Fronte sono persone più che ragionevoli le quali, purché si dia loro un’occasione, sarebbero ben liete di negoziare. Chi mai chiuderebbe la porta in faccia ad americani e ad altri occidentali chiaramente armati di buona volontà? I sostenitori della soluzione militare, da parte loro, presuppongono nell’avversario un’ancor maggiore capacità di calcolo razionale. Noi dobbiamo soltanto far aumentare fino al punto giusto il costo della guerra, con bombardamenti dall’aria e operazioni di ricerca e distruzione sul terreno e l’altra parte farà i suoi calcoli sullo scarto tra costi e profitti, concluderà che la pace è l’alternativa più vantaggiosa e chiederà di negoziare. La nostra politica, questo è stato ripetuto più e più volte, è di colpire l’avversario fino a fargli capire che gli conviene venire a chiedere la pace.
In realtà nessuno sa a quali condizioni, a eccezione di un nostro immediato ritiro, Hanoi e il Fronte sarebbero disposti a negoziare. A tutt’oggi i discorsi del presidente Johnson o del segretario di Stato non sono stati probabilmente di grande aiuto per capire quali fossero i nostri termini, ma le dichiarazioni di Hanoi non hanno l’aria di potersi rivelare più precise in fatto di chiarimenti. Una soluzione realistica deve di conseguenza essere quanto più possibile indipendente dall’atteggiamento di Hanoi e del Fronte. Non deve essere incompatibile ai fini di una loro risposta positiva, e se questa verrà tanto meglio; ma non deve dipendere da essa, o per lo meno deve ridurne al minimo il potere determinante. Questo complica notevolmente l’elaborazione della nostra politica. Ma ci garantisce anche contro la spiacevole prospettiva di avanzare una proposta ampiamente ragionevole e vedercela respingere da Hanoi perché è uno sporco trucco imperialista. Da queste esigenze, di cui occorre tener conto in una soluzione, passerò ora alle mie conclusioni preventive sul tipo di guerra che combattiamo e sullo stadio al quale essa è giunta; esaminerò successivamente lo stato d’animo dell’opinione pubblica americana oggi.
![]()
2.
I motivi iniziali dell’intervento
Il nostro intervento nella guerra del Vietnam fu il prodotto di una concezione del mondo che, presentatasi con tutti i crismi di una verità ufficiale, si rivelò poi in stridente contraddizione con la realtà. È un fatto storico sul quale non sussistono più divergenze.
La prima versione di questa teoria fu che nel Vietnam noi reagivamo a un tentativo di saggiare il terreno da parte di una cospirazione comunista diretta da una centrale; cioè a quella che il segretario di Stato Dean Rusk ha più volte descritto come “la questione fondamentale” della crisi del nostro tempo:
La non dichiarata decisione di imporre un sistema coercitivo a coloro che ancora non lo subiscono... è la questione posta tra l’impero cino-sovietico e tutti gli altri paesi, siano essi alleati o neutrali; ed è posta in ogni continente.
Noi ci saremmo sentiti minacciati da un comunismo nazionale, da un comunismo non legato a Pechino o a Mosca. Da una quindicina d’anni appoggiavamo il comunismo nazionale del maresciallo Tito in Jugoslavia; oggi, a partire anche dalla più superficiale valutazione della scena mondiale, dobbiamo vivere accettando la sua presenza. Inoltre, noi non reagiamo ogni volta che un governo, parlamentare o d’altro genere, è minacciato da una insurrezione, nemmeno quando questa è incoraggiata o appoggiata dall’esterno. Se così facessimo, buona parte del Medio Oriente, per esempio, sarebbe oggi una guarnigione americana, giacché da anni radio Cairo va lanciando incitamenti alla rivolta in vari paesi della zona e il governo della rau continua a fornire aiuti a numerosi dissidenti in altre terre arabe. Ancora: per difendere la libertà personale e il governo parlamentare non avremmo certo scelto il Vietnam e non, diciamo, la Grecia.
Ci sentimmo invece minacciati, e come noi vedemmo minacciata l’Asia orientale, da questo aspetto del comunismo, da questa cospirazione guidata da una “centrale”. La Cina costituiva un anello intermedio della cospirazione: il segretario Rusk la definì una volta «un governo coloniale russo, un Manciukuò slavo», e parlando davanti a un comitato del Congresso nei primi anni dell’amministrazione Kennedy la disse soggetta a «diretta, servile obbedienza alla politica del blocco [cino-sovietico] così come essa viene decisa a Mosca». Hanoi, e al seguito di Hanoi il Vietcong, era l’estrema punta avanzata di questo imperialistico spiegamento di forze diretto e guidato da una centrale. Fu per spezzare la punta della spinta offensiva di questo impero che noi ci muovemmo militarmente in appoggio di Ngo Dinh Diem e dei suoi successori.
Dal giorno in cui prendemmo questa decisione i fondamenti sui quali essa si fondava sono crollati. Nei rapporti tra Cina e Russia si è verificata una frattura; i due paesi, nelle reciproche comunicazioni, mantengono soltanto, e precariamente, dei rapporti diplomatici e non osservano neppure più le forme della cortesia. Oggi l’affermazione che esse operano in pieno accordo cospirativo non riscuoterebbe maggior credito della voce che noi siamo legati da un complotto imperialistico con il generale de Gaulle. Il segretario di Stato si è ricreduto, e la qualifica di nemico numero uno è passata successivamente da Mosca a Pechino per finire ad Hanoi e recentemente, di tanto in tanto, nuovamente a Pechino. Ma il passaggio ad Hanoi non è mero dettaglio geografico: con esso si ammette che quello che ci preoccupa è un fenomeno diretto non da una centrale esterna, ma da forze locali. Se l’obiettivo ultimo della guerra è situato nel Vietnam, in altri termini, esso è il comunismo nazionale: invece del nemico iniziale noi ne stiamo affrontando un altro che altrove non soltanto tolleriamo ma incoraggiamo.
In verità se le circostanze non fossero così tragiche ci si sentirebbe quasi mossi a simpatia per chi deve difendere questo conflitto, con tutti i cambiamenti che ci sono stati. È risultato che la coalizione nemica, l’impero contro il quale la nostra operazione era stata lanciata, non esisteva. Inoltre, nella sua ricerca di una nuova giustificazione razionalmente accettabile, l’amministrazione si è cacciata in un intrico tale di contraddizioni che nessun avvocato al mondo saprebbe più trovarne il bandolo. Non si...