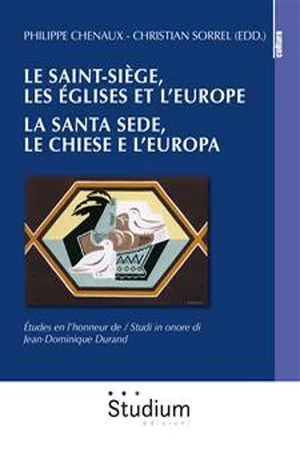
Le Saint-Siège, les eglises et l'Europe. / La Santa Sede, le chiese e l'europa.
Études en l'honneur de Jean-Dominique Durand / Studi in onore di Jean-Dominique Durand
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
Le Saint-Siège, les eglises et l'Europe. / La Santa Sede, le chiese e l'europa.
Études en l'honneur de Jean-Dominique Durand / Studi in onore di Jean-Dominique Durand
About this book
Historien, chrétien, citoyen engagé… Les visages publicsde Jean-Dominique Durand sont divers et, si ce volumed’hommage concerne d’abord sa profession d’historien,le lecteur ne peut pas oublier les autres dimensions del’homme qui se joignent pour dessiner sa personnalitéet porter son itinéraire, sans confusion des objets, maisaussi sans dissociation, en tension féconde. L’Italie, lapapauté, la démocratie chrétienne, l’Europe, ses penseurset ses cultures, le catholicisme français, et surtout sonpôle lyonnais, doté d’une forte identité sociale, les lignesdirectrices de son oeuvre sont fermes, qui n’empêchentpas un renouvellement incessant, débouchant sur unbilan impressionnant. De cette fécondité scientifiquetémoignent les nombreux chercheurs (près de cinquante)qui ont participé à ce volume d’hommage.
Jean-Dominique Durand est Professeur émérite d’Histoire contemporaine àl’Université Jean Moulin – Lyon 3. Il y a fondé à Lyon l’Institut d’Histoire duChristianisme, qu’il a dirigé de 1989 à 1999. Il a enseigné dans des Universitésétrangères, notamment à Rome, à la LUMSA et à l’Université pontificale duLatran. Il a été Conseiller culturel de l’Ambassade de France près le Saint-Siège,et Directeur de l’Institut culturel français de Rome de 1998 à 2002. Il est membrede divers comités scientifiques ou comités de rédaction en France et à l’étranger. Storico, cristiano, cittadino impegnato… I volti pubblici di Jean-Dominique Durandsono molteplici, e se questo volume vuole rendere omaggio in primo luogoalla sua professione di storico, il lettore non può tuttavia dimenticare gli altriaspetti dell’uomo che delineano ulteriormente la sua personalità e che contribuisconoa tracciarne l’itinerario umano e professionale, senza confusioni nécontraddizioni, sempre in tensione feconda. L’Italia, il papato, la DemocraziaCristiana, l’Europa, i suoi pensatori e le sue culture, il cattolicesimo francese
e soprattutto il suo polo lionese, dotato di una forte identità sociale: le lineedirettrici dell’opera di Durand sono solide e al tempo stesso arricchite da unrinnovamento incessante, che porta ad un bilancio impressionante.
Jean-Dominique Durand è Professore Emerito di Storia contemporanea all’Université Jean Moulin-Lyon 3. Ha fondato a Lione l’Istituto di Storia del Cristianesimo,che ha diretto dal 1989 al 1999. Ha insegnato presso numerose università stranierefra cui spiccano, a Roma, la LUMSA e la Pontificia Università Lateranense.Ha ricoperto il ruolo di Consigliere culturale dell’Ambasciata di Francia pressola Santa Sede, e di Direttore dell’Istituto Culturale Francese di Roma dal 1998 al2002. È membro di diversi comitati scientifici e di redazione in Francia e all’estero. En couverture: Gino Severini, Les deux colombes, 1926, Tempera sur carton, 59,5x66,5 cm.Maquette pour un motif décoratif de l’église de Semsales. Cercle d’études Jacques et RaïssaMaritain
Frequently asked questions
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Information
XI. Il mondo cattolico milanese tra pace e guerra (1914-1915), Alfredo Canavero*
Table of contents
- Copertina
- Le Saint-Siège, les eglises et l'Europe. / La Santa Sede, le chiese e l'europa.
- INDICE
- Philippe Chenaux et Christian Sorrel, Hommage
- Oissila Saaidia, Un entretien avec Jean-Dominique Durand
- PARTIE I – URBI ET ORBI
- I. Le pape et le colonel. Un trafic d’indulgences sous le Premier Empire, Paul Chopelin*
- II. Mourir pour Rome et pour le pape. La fabrique d’une hagiographie catholique en France au XIXe siècle, Bruno Dumons*
- III. Mgr Merry del Val et la réforme des études de l’Académie des Nobles ecclésiastiques (1900), Philippe Roy-Lysencourt*
- IV. Un épilogue romain de l’affaire Le Nordez: le recours auprès de Benoît XV en 1915, Augustin Laffay*
- V. Les propositions de reprise des relations entre la France et le Saint-Siège durant la Grande Guerre, Xavier Boniface*
- VI. Une lettre de Charles Maurras à Pie XII (31 juillet 1939), Jacques Prévotat*
- VII. McKinley, Léon XIII et la guerre américaine contre l’Espagne (1898-1903), Blandine Chélini-Pont*
- VIII. «Tisserant l’Américain», Étienne Fouilloux*
- IX. La contribution du Saint-Siège à la solidarité entre les Églises des Amériques, Gilles Routhier*
- X. Le Saint-Siège et l’Algérie: essai de regard sur la longue durée, Marc Agostino*
- XI. Au milieu des inquiétudes. Achille Danset, le BIT, le Saint- Siège et le corporatisme catholique (1934), Aurélien Zaragori*
- XII. Vatican II: la première session de Mgr Guerry, archevêque de Cambrai, Christian Sorrel*
- XIII. La risposta del Card. Montini al dramma di Rolf Hochhuth «Der Stellvertreter», Piero Doria*
- XIV. Paul VI et la mission de l’Église au service de la communauté humaine, Daniel Moulinet*
- XV. Agostino Casaroli uomo della Santa Sede, Roberto Morozzo della Rocca*
- XVI. Le pape, l’acteur et le psychanalyste. Habemus Papam de Nanni Moretti (2011), Denis Pelletier*
- PARTIE II – PARCOURS ECCLÉSIAUX, PARCOURS NATIONAUX
- I. Présence de l’art liturgique français à Saint-Pierre et Saint- Jean de Latran, Bernard Berthod*
- II. Fourvière avant Fourvière. Le projet d’église votive d’Antoine- Marie Chenevard, Philippe Dufieux*
- III. Une catégorie de statues de «grands hommes»: les statues d’ecclésiastiques en France, Jacqueline Lalouette*
- IV. Le prémontré Xavier de Fourvière, chantre de Dieu et de la Provence, Bernard Ardura*
- V. Les fidélités concurrentes du missionnaire, Claude Prudhomme*
- VI. De la religion à l’athéisme et retour: le cas Annie Besant, Régis Ladous*
- VII. Alla vigilia del ripristino dell’arcidiocesi di Atene. Alcuni documenti conservati nell’Archivio di Propaganda Fide, Carlo Pioppi*
- VIII. Des catholiques français contre le «mouvement vers Rome», Jean-Pierre Chantin*
- IX. I santi piemontesi dell’Ottocento e i problemi sociali della prima industrializzazione. Influssi del cattolicesimo francese, Bartolo Gariglio*
- X. La Chiesa e il regicidio (29 luglio 1900), Maurilio Guasco*
- XI. Il mondo cattolico milanese tra pace e guerra (1914-1915), Alfredo Canavero*
- XII. Le cardinal Luçon, archevêque de Reims, ou l’Union sacrée à l’oeuvre, Frédéric Gugelot*
- XIII. La Chiesa di Nicola Monterisi all’epoca del delitto Matteotti. Una riflessione fra storiografia e storia locale, Stefano Trinchese*
- XIV. La pietà e la guerra: San Francesco patrono d’Italia nel secondo conflitto mondiale, Daniele Menozzi*
- XV. Les catholiques bisontins, de l’intransigeantisme au socialisme municipal, Laurent Ducerf*
- XVI. Un instantané des relations entre orthodoxes et catholiques en 1924: la rencontre «amicale» de Mgr Euloge et du père Michel d’Herbigny, Laura Pettinaroli*
- XVII. Ortodossia russa e universalismo, Adriano Roccucci*
- PARTIE III – HORIZONS EUROPÉENS
- I. La résistance conservatrice et catholique contre l’omnipotence de l’État. Une esquisse historique, Emiel Lamberts*
- II. Attirance, rejet et réaction. Catholicisme et socialisme au XIXe siècle, Jan De Maeyer, Hendrik Moeys*
- III. La nostalgie du paradis blanc. L’abbé Journet, les Maritain et La Valsainte, Philippe Chenaux*
- IV. La Jeune République et la construction européenne, Jacques- Olivier Boudon*
- V. Gabriel Marcel en Guerre froide, Michel Fourcade*
- VI. «L’Europe à ne pas faire». Intellectuels catholiques en européisme, Claire Toupin-Guyot*
- VII. Le thomisme militant à l’heure du concile: le cas polonais de Stefan Swiez˙awski, Piotr H. Kosicki*
- VIII. Giorgio La Pira e la «storiografia del profondo», Andrea Riccardi*
- IX. La crise, paradigme du modèle politique italien?, Marc Lazar*
- X. Trois hommes politiques de la Transition espagnole vers la démocratie et leur inspiration chrétienne, Pablo Pérez López*
- XI. Devenir un Juste parmi les nations: Jan Karski, Annette Becker*
- XII. Les «Justes» de France, une mémoire républicaine pour notre temps, Bernard Delpal*
- XIII. Éléments pour une histoire de la place de la liberté religieuse dans la construction européenne, Emmanuel Tawil*
- XIV. Laïcité et droit des femmes. Retour sur le parcours français, Philippe Portier*
- XV. I principi non negoziabili. Una sfida educativa, culturale e politica circa la dignità del vivere e del morire, Enrico dal Covolo*
- XVI. L’esprit européen, Card. Paul Poupard*
- Bibliographie de Jean-Dominique Durand
- Tabula gratulatoria