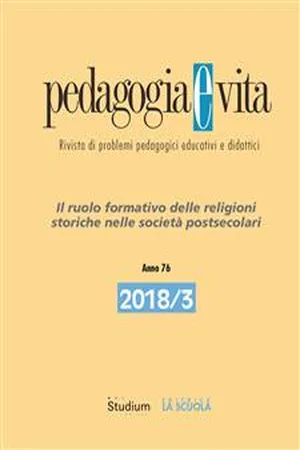
Il ruolo formativo delle religioni storiche nelle società postsecolari
Pedagogia e Vita - Anno 76 (2018/3)
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
Il ruolo formativo delle religioni storiche nelle società postsecolari
Pedagogia e Vita - Anno 76 (2018/3)
About this book
Rivista di problemi pedagogici, educativi e didattici
Editoriale
Fulvio De Giorgi - Secolarizzazione, secolarismo e cristianesimo. Appunti e ipotesi di interpretazione storica
Giuseppe Mari - Religione, laicità, educazione
Pierpaolo Triani - Il nuovo ruolo civico delle religioni nelle società pluralistiche e nel contesto post-secolare
Paolo Luigi Branca - Religiosità, religioni e radicalismi religiosi. Rischi e opportunità in ambito scolastico
Marcello Di Tora - I fondamenti dell'identità islamica e la modernità. Aspetti problematici di un confronto
Silvia Guetta - Ruolo formativo e civico dell'Ebraismo nelle società post-secolari
Livia Romano - Per una educazione universale. La via del Buddismo nelle società post-secolari
Elena Marta - I giovani e la religione oggi nelle società postmoderne
Giorgia Pinelli - Senso religioso e religiosità. L'educazione religiosa ai tempi del multiculturalismo
Lino Prenna - La cultura religiosa nella scuola italiana: oltre la marginalità
Maria Teresa Moscato - Famiglia ed educazione religiosa oggi
Giuseppe Acone - Pensare in pedagogia: sull'orlo dello stesso abisso
Frequently asked questions
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Information
1. Laicità: un concetto recente, ma carico di storia
Table of contents
- Copertina
- Il ruolo formativo delle religioni storiche nelle società postsecolari
- Indice dei contenuti
- Abstracts
- Editoriale
- Secolarizzazione, secolarismo e cristianesimo. Appunti e ipotesi di interpretazione storica
- Religione, laicità, educazione
- 1. Laicità: un concetto recente, ma carico di storia
- 2. La scuola come luogo di apertura alla trascendenza
- 3. Fede, spazio pubblico, educazione
- Il nuovo ruolo civico delle religioni nelle società pluralistiche e nel contesto post-secolare
- 1. La deprivatizzazione delle religioni
- 2. Religioni e vita sociale: il parere dei giovani italiani
- 3. Un nuovo ruolo civico
- 4. Le condizioni ‘interne’ per esercitare un nuovo ruolo civico
- Religiosità, religioni e radicalismi religiosi. Rischi e opportunità in ambito scolastico
- 1. A volte ritornano...
- 2. Tornare al principio
- 3. Il ‘più’ irrinunciabile
- 4. La rilevanza della storia
- 5. Le parti si invertono
- 6. Nuove prospettive
- I fondamenti dell’identità islamica e la modernità. Aspetti problematici di un confronto
- 1. Questioni terminologiche e tratti caratteristici
- 2. Sviluppo di alcuni elementi costitutivi dell’identità islamica fondamenti dell’identità islamica
- 3. Le criticità del sistema giuridico shari‘aitico
- Considerazioni conclusive
- Ruolo formativo e civico dell’ebraismo nelle società postsecolari
- 1. Il dialogo come pratica della post-secolarizzazione
- 2. Ebraismo tra secolarizzazione, ricerca di identità ed espressione laica
- 3. Lo studio è più forte della preghiera
- 4. La ricerca al femminile per la riscoperta dell’ebraismo
- Conclusioni
- Per una educazione universale. La via del buddhismo nelle società post-secolari
- 1. La religione buddhista fra Oriente e Occidente
- 2. Il Buddhismo: storia di una pedagogia millenaria
- 3. La meditazione buddhista come pratica educativa
- 4. La relazione educativa tra maestro e discepolo
- 5. L’educazione buddhista alla convivenza sociale
- I giovani e la religione oggi nelle società postmoderne
- 1. Le caratteristiche della religione dei Millennials
- 2. I percorsi di fede dei giovani
- 3. Percorsi di fede in famiglia
- 4. In conclusione
- Senso religioso e religiosità. L’educazione religiosa ai tempi del multiculturalismo
- Premessa
- 1. Dentro l’educazione: dal modello iniziatico al senso religioso
- 2. Il senso religioso come costante antropologica
- 3. Dal senso religioso alla religiosità: come pensare l’educazione religiosa?
- 4. La trasversalità dell’esperienza religiosa: l’archetipo dei Magi come immagine propositiva
- La cultura religiosa nella scuola italiana: oltre la marginalità
- 1. La scuola, luogo di evangelizzazione?
- 2. Insegnamento della religione e catechesi: distinzione e complementarità
- 3. Nelle finalità della scuola
- 4. Tra società civile e scuola laica
- 5. Assicurata ma facoltativa
- 6. Per una piena scolarizzazione
- 7. Istruzione religiosa per tutti
- 8. Per una democrazia delle diversità
- Famiglia ed educazione religiosa oggi
- Il primato educativo della famiglia
- Gli elementi strutturali generativi della religiosità: alcuni dati
- La preghiera infantile
- Le narrazioni
- Il rito e il senso della festa
- Pensare in pedagogia: sull’orlo dello stesso abisso