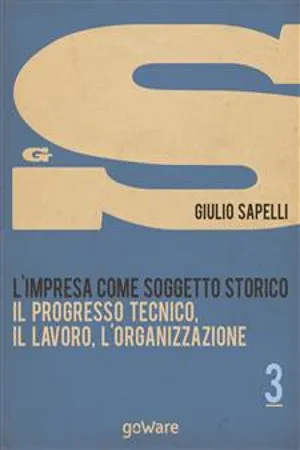
eBook - ePub
L'impresa come soggetto storico. Il progresso tecnico, il lavoro, l'organizzazione – Vol. 3
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
L'impresa come soggetto storico. Il progresso tecnico, il lavoro, l'organizzazione – Vol. 3
About this book
In questo terzo ebook di un classico degli studi sull'impresa in Italia si presenta una serie di saggi storici sull'avvento della cosiddetta "organizzazione scientifica del lavoro" in Italia, con pionieristiche ricerche empiriche, per concludere con la presentazione di un modello teorico del nesso tra progresso tecnico e crescita economica.
Giulio Sapelli digerisce una sterminata letteratura teorica sull'argomento e passa in esame alcuni casi concreti per offrire al lettore un quadro chiaro ed esaustivo.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access L'impresa come soggetto storico. Il progresso tecnico, il lavoro, l'organizzazione – Vol. 3 by Giulio Sapelli in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Business & Business History. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
IV. Modelli della crescita e progresso tecnico. Riflessioni dall’Italia
1. Del modello della crescita italiana e del progresso tecnico
1.1 La tesi: interrelazioni funzionali e produzione di modelli tecnico-organizzativi
Cercherò di dimostrare in questo saggio che l’Italia costituisce un modello specifico di passaggio da una situazione periferica a una di comando relativo nel mondo industriale, modello affermatosi anche grazie a percorsi di interrelazione funzionale delle tecnologie e di produzione di autoctoni modelli tecnico-organizzativi, all’interno di specifici (storici) contesti di selezione. Essi si sono composti in un «parallelogramma di forze» della crescita che comprendono, con le tecnologie, la finanza, l’esportazione di manodopera, la nascita di una diffusa borghesia industriale, il ruolo istituzionale dello stato, a partire, geneticamente, dall’utilizzazione del surplus, accumulato secolarmente in agricoltura.
Sia il vettore che risulta dal parallelogramma, sia le altre forze prima ricordate saranno evocate in questa sede soltanto sullo sfondo di uno scenario che avrà al centro l’interrelazione funzionale tecnologica e la produzione autoctona delle forze tecnico-organizzative su scala discreta, nel contesto del rapporto storico tra sviluppo economico e progresso tecnico.
Spero in questo modo di fornire un contributo più generale alla discussione in corso sulla possibilità di ipotizzare una differente capacità d’innovazione tecnologica ed economica di taluni paesi rispetto ad altri[184], nella convinzione che la risposta positiva a questa domanda racchiuda in sé la via per l’elaborazione di una più comprensiva teoria del cambiamento tecnologico.
Una teoria meno riduzionista di quanto non lo siano le già disponibili non-riduzionistiche teorie antineoclassiche (quanto meno nelle aspirazioni degli autori)[185], e quindi in grado di includere, oltre alla storicità, l’orientamento degli attori collettivi, le istituzioni non di mercato e gli effetti di ricaduta delle loro politiche.
Discutere del «caso italiano» è a questo proposito profondamente istruttivo. Anche se non si riuscirà a rispondere a così ambiziosa sfida si saranno accumulate una serie di congetture utili per colui che avrà la forza di guardare finalmente nella famosa «scatola nera» del progresso tecnico. È mia convinzione che non si può iniziare queste congetture senza far proprio un concetto di paradigma tecnologico ben più ampio di quello già autorevolmente proposto[186]. Questo ampliamento non può tuttavia estendersi sino ad assumere il volto di un modo di produzione[187], quanto, invece, quello più propriamente costruibile, a parer mio, intersecando paradigma tecnologico e versioni più o meno paradigmatiche di forme organizzative delle relazioni socio-tecniche[188]. Più o meno paradigmatiche perché è attributo specifico di diversi paradigmi tecnologici la possibilità-capacità di incorporare, a diversi livelli di esaustività, le forme organizzative. In effetti, questa ipotesi, che fa dell’interrelazione tra tecnologia e organizzazione un connotato distintivo del suo campo teorico, può intendersi come un’interpretazione estensiva dell’assunto di Freeman, allorché in esso si pensa l’innovazione tecnologica come quella forza storico-economica [corsivo mio] che
ha abbassato in termini reali il costo dei beni necessari a sostenere la capacità fisica lavorativa della manodopera e nello stesso tempo ha allargato la gamma dei beni e dei servizi abitualmente considerati necessari componenti del tenore di vita, riducendo così le ore di lavoro. Il ruolo svolto dai nuovi paradigmi tecnico-economici nel compensare le previsioni, altrimenti tenaci, verso la caduta della produttività marginale del capitale, è stato pertanto di grande importanza storica[189].
1.2 Il modello della crescita
Varrà la pena sottolineare che in Italia il «parallelogramma delle forze» della crescita che ha dato vita a un percorso eminentemente discontinuo, dove arretratezza e modernizzazione continuamente convivono, è la manifestazione settoriale di un processo sociale molto più ampio, che ha carattere secolare e preindustriale, quasi una struttura profonda e multifattoriale che neppure la rivoluzione industriale e capitalistica ha interrotto, anzi, ha esaltato.
Non vi è tratto moderno – affermò a suo tempo Maurice Aymard in un contributo sulla transizione del feudalesimo al capitalismo[190] – al quale non corrisponda immediatamente un rovescio arcaico. Il pane (scuro) di grano, divenuto fin dal Quattrocento cibo normale per la maggior parte delle città, grandi e piccole (un’eccezione su scala europea), ma anche quello di castagne, che rimarrà, (fino a ieri), dalla Lunigiana alla Calabria, il destino delle montagne povere. La messa a punto delle tecniche finanziarie più raffinate – dalla lettera di cambio alla fiera di Besançon – che danno all’Italia il dominio del credito a principi e mercanti, e dei movimenti internazionali di capitali, ma anche la pratica, più corrente che mai, alla base, di quei medesimi mercanti o dei loro fattori, delle forme più tradizionali e oppressive dell’usura. La sottomissione dei signori all’autorità cittadina, ma anche lo stretto esercizio da parte di tutti i mercanti, divenuti proprietari fondiari, dei minimi diritti «feudali», cui possono pretendere sulle proprie terre e su coloro che le coltivano.
E io stesso ho ricordato come sia essenziale per comprenderne i caratteri costitutivi, porre al centro dell’analisi le «stabilità relative, interstiziali, ma non destinate a sparire, diffuse e fragili, ma persistenti, come si conviene a un sistema sociale […] dove il premoderno serve al moderno, e l’uno non è comprensibile senza l’altro e tutto procede in questo continuo incrociarsi e trasformarsi dell’eterogeneità funzionale»[191]. Questa continuità nella trasformazione e nell’accrescersi della differenziazione funzionale e sociale del sistema può essere compresa – e può servirci a introdurre il problema che qui ci arrovella – se si richiama pur per brevi accenni lo specialissimo modello di formazione e crescita della società industriale capitalistica italiana.
Luciano Cafagna ha definito tale modello come «caratterizzato da un mixage […] manchesteriano […] [e] gerschenkroniano»[192], ossia un modello aperto, che considera l’Italia nello sviluppo economico internazionale e nella contemporaneità strutturale di un paese late joiner e di paesi first comer. Si importa industrializzazione e tecnologia all’interno del vincolo dell’equilibrio dei conti con l’estero. Si tratta di una via all’industrializzazione che alterna graduali e lente ascese con una fase di rapidissima crescita, quale quella che si realizzò nel secondo dopoguerra, tra il 1951 e il 1964[193]: di una via, insomma, dove le spinte endogene agiscono sin da subito a fianco di potenti attori esogeni, quale fu la lunga accumulazione agraria indotta dal commercio estero, accumulazione secolare che pose le basi di una preindustrializzazione accentrata nelle regioni settentrionali del paese e finanziata dal flusso delle esportazioni primarie. In questa fase della crescita assistiamo alla prima rottura della gradualità. Essa si manifesta nell’accrescimento del fabbisogno di importazioni sostentato prima dall’intervento del capitale estero, sino alla crisi della fine degli anni ottanta dell’Ottocento, poi, nella fase della formazione della base industriale del paese nel primo quinquennio del Novecento[194], dall’apporto di capital...
Table of contents
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Presentazione
- I. Appunti per una storia dell’organizzazione scientifica del lavoro in Italia
- II. La «razionalizzazione della vendita»: alle origini del marketing e della pubblicità in Italia*
- III. L’organizzazione del lavoro all’Alfa Romeo 1930-1951. Contraddizioni e superamento del «modello svizzero»
- IV. Modelli della crescita e progresso tecnico. Riflessioni dall’Italia
- Lista dei nomi citati
- goWare <e-book> team
- Manifesto di goWare