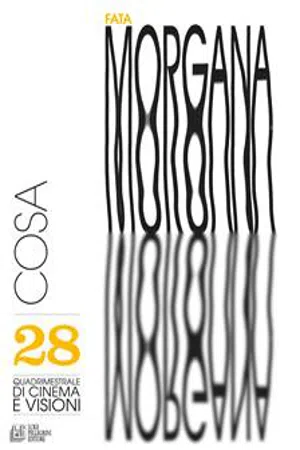eBook - ePub
Fata Morgana 28 - Cosa
About this book
Chiavi, slittini, biciclette, il cinema ha avuto da sempre a che fare con le "cose" che molto spesso sono diventate oggetti, strumenti d'azione, ma molte altre volte hanno assunto una dimensione autonoma, poetica, che li ha trasformate in elementi centrali, insieme ai corpi, del paesaggio del film. Questo numero, nuovo per tema e composizione, è dedicato alle "cose" nel cinema con contributi che vanno da Buñuel a Scorsese, da Antonioni a Bergman, per chiudere con Gravity di Cuarón.
Il volume è aperto da una conversazione con Remo Bodei.
Trusted by 375,005 students
Access to over 1 million titles for a fair monthly price.
Study more efficiently using our study tools.
Information
Topic
ArtSubtopic
PhotographyLe immagini e le cose
Andrea Rabbito
C’è stato un tempo, scrive Michel Foucault ne Le parole e le cose, in cui la «somiglianza ha svolto una parte costruttiva nel sapere della cultura occidentale»[1], e questa centralità riconosciuta alla somiglianza nell’episteme ha permesso che «segni e similitudini si avvolge[ssero] reciprocamente secondo una voluta che non aveva termine»[2]. Più concretamente, in relazione alle caratteristiche proprie del sapere antico, vi era una concezione, riguardante i vari linguaggi, che univa «sul medesimo piano magia ed erudizione»[3], in quanto si riteneva che «il linguaggio [avesse] il valore di segno delle cose»[4], e, ancora più importante, si considerava che «il rapporto con i testi [fosse] di natura identica al rapporto con le cose»[5]. Ecco allora che per questo sapere, che si connota di aspetti magici e anche – in certe fasi storiche sarebbe meglio scrivere soprattutto – spirituali, le cose della natura e i segni dei linguaggi vengono accomunati: il mondo esterno è, in termini metaforici, un libro aperto da leggere e decifrare, così come il linguaggio «richiede […] di essere studiato non diversamente da una cosa della natura»[6]; per questo motivo, ad esempio, «lo studio della grammatica poggia, nel XVI secolo, sulla stessa disposizione epistemologica della scienza della natura o delle discipline esoteriche»[7].
Le radici di questa visione del mondo e del linguaggio, di questa credenza sul rapporto tra le cose presenti nel mondo e i segni creati dall’uomo, vanno individuate, osserva Foucault, in una concezione ancora più remota, per la quale «nella sua forma originaria» il linguaggio, in primo luogo, «fu dato da Dio stesso», e, in secondo luogo, era reputato «un segno delle cose assolutamente certo e trasparente poiché assomigliava ad esse»[8]. Il segno del linguaggio, e quindi il linguaggio stesso, era attendibile perché era perfettamente somigliante al suo referente reale; l’uno duplicava l’altro secondo una visione connotata da questo tipo di «similitudini radicali»[9]. Ma se questa visione, che contraddistinse ad esempio la struttura portante con cui si impose la cultura e la religione ebraica, nel tempo si è modificata e si è smesso di pensare che il linguaggio somigli «immediatamente alle cose che nomina» e che «non è più la natura nella sua visibilità d’origine»[10], è vero anche, però, che non per questo, sempre durante il lungo periodo del sapere fondato sulla somiglianza, il linguaggio è stato reputato «separato dal mondo»[11]; ha continuato, scrive Foucault, «sotto forma diversa, ad essere il luogo delle rivelazioni e ad appartenere allo spazio in cui la verità, a un tempo, si manifesta e si enuncia»[12].
In questo modo è riuscita a rimanere stabile una «indistinzione tra ciò che è veduto e ciò che è letto»[13], perché «le lingue» hanno mantenuto col mondo «un rapporto di analogia»[14]. Le parole e le cose hanno vissuto in una stessa dimensione, all’interno della quale non viene presa in considerazione una distinzione netta tra loro. Formano un’unica realtà grazie alla centralità assunta dalla somiglianza.
Ma questa convivenza dentro un unico spazio ad un certo momento storico è venuta a decadere, a venir meno, ed è calato, fra il linguaggio e il mondo esterno, un muro divisorio che ha scisso nettamente le due realtà e non ha più permesso fra loro quel continuo scambio di riflessi speculari che li univa. «Verso la metà del XVII», scrive Foucault, si verifica la prima grande «discontinuità nell’episteme della cultura occidentale»[15]. A partire dal Seicento, infatti, «ci si domanderà in qual modo un segno può essere legato a ciò che esso significa» decretando in questo modo la «disfatta» di quella «profonda inerenza reciproca di mondo e linguaggio»[16] che costituì la base fondante del pensiero antico. Si verificò dunque il tramonto della «sovranità del Somigliante»[17], e questo ebbe come conseguenza principale il fatto che «cose e parole si separ[arono]» e così «l’occhio [fu] destinato a vedere, e a vedere soltanto; l’orecchio a solamente udire»[18]. La causa di ciò che tratta Foucault, ovvero della «discontinuità epistemologica»[19] – riprendendo l’espressione di Bachelard – che determinò il tramonto della Somiglianza e la separazione tra parole e cose, è individuabile nella nascita e nell’imporsi della modernità.
Proprio l’ingresso del pensiero moderno, che si verifica nel Seicento, determina infatti la messa in discussione e in crisi di ciò che possiamo descrivere, recuperando le parole del personaggio Naphta de La montagna incantata, come l’insieme dei rimanenti resti di quella «paradisiaca condizione iniziale direttamente discesa da Dio»[20]; viene cioè a deflagrarsi il sistema del pensiero antico che era caratterizzato da aspetti di natura e credenza da un lato religiosi e mistici – «ogni scienza» nel Medioevo, evidenzia Husserl, «ha la propria matrice teologica», e «ogni prassi diventa […] guidata dalla teologia»[21] –, dall’altro lato magici ed esoterici – vedi la cabala e l’alchimia.
Nel Seicento l’uomo assimila la lezione che ha appreso dalle varie scoperte scientifiche, geografiche, astronomiche che si sono succedute nel corso del Quattrocento e del Cinquecento e che hanno continuato a imporsi nel secolo del Barocco; e proprio tali scoperte hanno provocato una profonda frattura nell’episteme, hanno determinato «un rimaneggiamento della conoscenza, una riforma dell’essere conoscente»[22], e hanno aperto le porte al pensiero moderno – «noi crediamo», scrive Bachelard, «che il progresso scientifico manifesti sempre una rottura, continue rotture, fra conoscenza comune e conoscenza scientifica, da quando ci si accosta a una scienza evoluta, a una scienza che, per il fatto stesso di queste rotture, porta il segno della modernità»[23]. Queste scoperte hanno dato vita a dei traumi che hanno portato a un cambiamento radicale nell’episteme, e una di queste, una delle principali, ovvero la rivoluzione messa in atto da Copernico, e le sue dirette conseguenze, possono essere sintetizzate, anche questa volta, dalle riflessioni del gesuita del capolavoro di Thomas Mann; Naphta afferma infatti che la «degradazione»[24] dell’epoca moderna è cominciata a partire
Dalla nuova astronomia che del centro dell’universo, dell’angusto teatro in cui Dio e il diavolo lottano ...
Table of contents
- Scardinare l’ovvietà degli oggetti. Conversazione con Remo Bodei
- Fotografie
- La cosa vista dalla cosa. Merleau-Ponty (Lacan) e Antonioni
- Cinema dell’universo. Materia e immagine da Bergson a Deleuze
- Il rovescio delle cose nella pratica di Gianikian e Ricci Lucchi
- L’impronta delle cose.
- Le immagini e le cose
- La ragione di tante Cose
- Le estetiche della visagéité
- Da cosa nasce cosa. L’oggetto nel cinema d’animazione in stop-motion
- “Il dorso delle cose” nel cinema di Pietrangeli
- Action camera. L’occhio dell’Antropocene?
- Balli meccanici e drammi d’oggetti
- Vertov, la merce e il suo arcano
- Raíces. La cosa come rovina precolombiana
- Su il carillon di Estasi di un delitto
- Baudrillard e la cosa fotografica
- Eppure c’è qual-cosa. Breve nota su Uzak di Ceylan
- L’uomo senza passato: presenze vive di oggetti desueti
- Cose ridotte a oggetti: The Wolf of Wall Street
- Gravity: la tangibile concretezza dello spazio
- ABSTRACT IN INGLESE
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn how to download books offline
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 990+ topics, we’ve got you covered! Learn about our mission
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more about Read Aloud
Yes! You can use the Perlego app on both iOS and Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app
Yes, you can access Fata Morgana 28 - Cosa by Aa.Vv. in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Art & Photography. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.