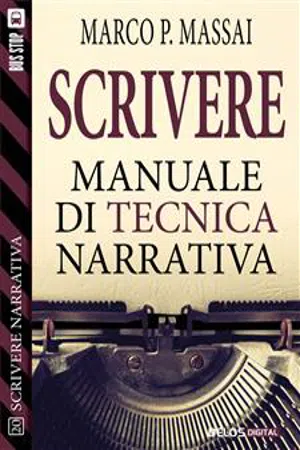![]()
1. L'importanza dello Show, don't tell!
Da più di tre secoli lo Show, don't tell! è una delle tecniche narrative più note e utilizzate. Imparare a carpirne i segreti è un indispensabile e fondamentale passo lungo la strada per diventare veri scrittori. Le radici storiche di questa espressione, conosciuta ai più come una trovata moderna, hollywoodiana…
… Sei righe. Trecento battute, che si leggono in meno di un minuto. Eppure sono state più che sufficienti ad annoiarci. Perché? Perché ho iniziato questo capitolo imponendo dall'alto l'importanza di quanto volevo comunicare, in modo generico e distaccato e senza dettagli concreti né appigli per l'interesse del lettore. L'ho fatto, cioè, raccontando anziché mostrando. Un errore che in un romanzo o in un racconto può risultarci fatale: immaginiamo un cliente che entra in libreria e tra le tante copertine sugli scaffali viene colpito proprio dalla nostra. Si avvicina, prende in mano il testo, lo sfoglia. In questo momento è un potenziale lettore che sta per decidere se meritiamo o meno la sua attenzione, il suo tempo e, in fondo, il suo denaro. Da parte sua è ben disposto nei nostri confronti e cerca un libro che sia in grado di catturarlo. Così apre la prima pagina e… a noi bastano sei righe per annoiarlo e perdere, forse per sempre, la sua fiducia. Sì, perché idea, trama, personaggi… sono cardini fondamentali di un buon testo, ma se non riusciamo a catturare il lettore e a immergerlo nelle nostre storie diventano solo covoni e covoni di pagliuzze: non c'è trave nell'occhio di uno scrittore che sia peggiore del creare attivamente noia.
È qui che entra in gioco lo Show, don't tell! tanto caro agli americani: poche pagine di raccontato possono essere sufficienti ad annoiare il lettore che non avrà, invece, problemi a divorare centinaia di pagine di mostrato.
Scrive Kirk Polking, nel suo Writing A to Z: "È come la differenza tra gli attori che recitano uno spettacolo e il solo drammaturgo, in piedi su un palco vuoto, mentre racconta dettagliatamente lo spettacolo al pubblico". Mostra, non raccontare.
Come sempre accade in narrativa, non siamo di fronte a una regola, a un assioma ferreo da accettare e seguire ciecamente (in narrativa le uniche regole sono quelle che riguardano grammatica e sintassi, e perfino queste sono suscettibili a variazioni nell'arco degli anni), bensì a una tecnica, uno strumento che è indispensabile conoscere a fondo se vogliamo affrontare la scrittura in modo professionale. Citando Franco Forte: "Scrivere buona narrativa è difficile, molto difficile. La narrativa e il processo creativo che porta a realizzare un romanzo sono la disperata ricerca della sintesi all'interno di un oceano di particolari, fra i quali bisogna discernere con cura, con calma e con talento. E per farlo occorre avere a portata di mano anche la classica cassetta degli attrezzi, con dentro tutti gli strumenti di tecnica che si possono apprendere."
In questo capitolo sviscereremo i concetti di mostrato e raccontato, affrontando così non soltanto uno strumento di tecnica di base della scrittura, ma anche un suo aspetto fondamentale e inscindibile: il narrare.
![]()
2. Raccontare, mostrare, descrivere, narrare
Quattro parole che racchiudono, in sostanza, tutto il mestiere dello scrivere. Affrontiamole impostando una prima definizione per ciascuna, partendo dalla fonte più semplice: il dizionario.
Raccontare – Riferire parole e fatti.
Questo è il più semplice esempio di raccontato. Diamo al lettore un'informazione generica e lo facciamo senza riferimenti precisi, senza termini di paragone, senza appigli di alcun genere per la sua immaginazione. Soprattutto, glielo imponiamo: Mario è alto, perché noi abbiamo deciso che le cose stanno così. Due pagine e, statene certi, il lettore avrà dimenticato che Mario sia alto.
Mario è il più alto della classe.
Cambiato qualcosa? Sì, siamo riusciti a peggiorare la situazione: Mario ha una qualità che evidentemente risulta importante per inquadrarlo e noi la buttiamo lì così, sempre imposta dall'alto e generica. Abbiamo aggiunto un termine di paragone, ma non c'è nulla di concreto in questa frase, nulla che possa permettere alla mente del lettore di crearsi un'immagine coinvolgente, memorabile, di Mario.
Proviamo ora con un periodo più complesso:
Comunque io gli sono affezionato e anche se a volte il suo modo di ragionare mi infastidisce, gli voglio bene, perché lui ha delle qualità che gli invidio. Mario è fedele, Mario è onesto, Mario ride e soprattutto Mario ti manda a cagare, chiunque tu sia.
Il brano è un ottimo esempio di raccontato: spieghiamo un sentimento della voce narrante, ma è un'emozione generica, insipida, poi elenchiamo una serie di qualità, sempre generiche e sempre senza che il lettore abbia altro modo di associarle a Mario che non la nostra imposizione dall'alto.
Possiamo quindi già trarre una nostra definizione narrativa del raccontare:
Raccontare è imporre al lettore parole e fatti generici.
Mostrare – Esporre all'attenzione, allo sguardo altrui.
Qui il dizionario aggiunge un dettaglio importante: ci parla di attenzione, di sguardo altrui. Nel termine stesso, mostrare, è già quindi presente un concetto preciso: mostrare attira l'attenzione del lettore. E accidenti, se è poco!
Entrando in aula Mario chinò la testa, per non sbattere la fronte.
Abbiamo imposto, raccontato, l'altezza di Mario? No, l'abbiamo mostrata con un'immagine concreta. Un'immagine semplice, ma che ha molta più possibilità di colpire la fantasia del lettore rispetto al piattissimo "Mario è alto" o "è il più alto della classe" dell'esempio precedente. Abbiamo aggiunto, inoltre, un nuovo aspetto che differenzia il mostrato dal raccontato: la dinamicità. Qui non abbiamo una statua, un personaggio fisso nella sua condizione di alto, ma è proprio da un movimento, in questo caso l'abbassare la testa, che deduciamo la sua altezza.
Vediamo anche per il mostrare un esempio più complesso:
Grant si sentì barcollare per il freddo e il terrore. Premette le mani contro il pannello di metallo della porta per tenerle ferme. Il tirannosauro ruggì di nuovo, ma non attaccò. Drizzò la testa e guardò la Land Cruiser, prima con un occhio, poi con l'altro. (M. Crichton, Jurassic Park)
Non c'è un solo aspetto di questa scena che ci venga imposto dall'alto. Analizziamolo. Grant non "barcolla", non "è barcollante", ma "si sente barcollare". Apparentemente è una differenza da poco, ma è fondamentale perché Crichton ci trascina subito nel mezzo della scena: noi non stiamo guardando Grant, noi siamo Grant. Le mani di Grant stanno tremando, ma l'autore non si limita a raccontarcelo: ci mostra il personaggio mentre le preme contro la portiera per tenerle ferme (usa quindi un'azione, il poggiare le mani, per farcene immaginare un'altra, il tremare). Il tirannosauro non è descritto come enorme, terrificante o feroce, tutte queste qualità sono mostrate tramite le sue azioni: ruggisce, ma non attacca (creando suspence con questa non-azione!), poi drizza la testa, infine non si limita a guardare la macchina, ma lo fa "prima con un occhio, poi con l'altro" mostrandoci la sua feroce bestialità. Senza usare un solo aggettivo Crichton è riuscito a mostrarci (ancora una volta: mostrarci) prima il nostro terrore incontrollabile (nostro perché noi siamo lì, insieme a Grant!), poi tutte le qualità che rendono terrificante il T-Rex, riuscendo nel contempo a distanziarci psicologicamente dalla bestia con quel movimento, tipico degli uccelli, del guardare prima con un occhio, poi con l'altro. Questa è scrittura!
Ecco quindi la nostra definizione:
Mostrare è calare il lettore nella storia con dettagli concreti e dinamici.
Descrivere – Rappresentare con parole cose, fatti, persone, nei particolari che li contraddistinguono.
Una domanda non semplice: descrivere è raccontare, è mostrare, o è un'attività completamente differente?
Cominciamo con un esempio e vediamo come se la cavano Crichton (e Grant) con la descrizione del T-Rex di cui sopra:
Il dinosauro doveva essere da qualche parte tra gli alberi, ma per il momento Grant non riusciva a vedere nulla. Poi capì che stava guardando troppo in basso: la testa dell'animale si ergeva sei metri sopra il livello del suolo, seminascosta dalla sommità delle palme.
Malcolm sussurrò: – Oh, mio Dio, è alta quanto una casa…
Grant fissò l'enorme testa squadrata, lunga un metro e mezzo, con macule marrone rossiccio, e dotata di gigantesche mandibole e zanne. Le fauci si aprirono e si richiusero. Ma l'enorme animale non sbucò dal suo nascondiglio.
La prima cosa da notare è che, pur dovendo descrivere il dinosauro, Crichton ci tiene sempre ben incollati a Grant: i dettagli non ci arrivano dall'alto, ma dalle considerazioni e dagli occhi del personaggio. L'altezza della belva ci viene precisata, ma non imposta: Grant capisce che l'animale è alto (è comunque un momento dinamico, un divenire). Poi abbiamo un dialogo a rinforzare le dimensioni del tirannosauro e solo allora comincia una vera e propria descrizione: breve, mirata (ci descrive solo la parte più terrificante dell'animale, ovvero l'enorme testa) e precisa. Soprattutto, è una descrizione funzionale al testo: quando, pochi capitoli più tardi, leggeremo di Grant nel suo faccia a faccia con il tirannosauro, questo aver indugiato sui dettagli della testa sarà fondamentale per richiamare in noi tutto il terrore causato dalla bestia. Tutto in questo brano è concreto e preciso, anche nella descrizione siamo dunque di fronte a un mostrare.
Ora analizziamo un esempio di descrizione raccontata: abbiamo visto che la frase "Mario è alto" è un raccontare ma è, di certo, anche una descrizione di Mario. È vaga, imprecisa, ma è pur sempre una rappresentazione attuata tramite un particolare che rappresenta Mario, in questo caso l'altezza. Di certo non è un mostrare. Ma "Mario è alto" è narrativa, o è piuttosto una descrizione fine a se stessa, un esempio da manuale? Pensiamo al celebre discorso di S. King nel suo On Writing:
Lo scrittore, anche a migliaia di chilometri di distanza, dice: – Lì c’è una gabbia con un coniglio dentro – e tutti quelli che leggono voilà, vedono la gabbia e il coniglio. Che cos’è, questa, se non telepatia?
È abbastanza chiaro che questa non è una descrizione, dato che non ci viene fornito alcun particolare che contraddistingue la gabbia (e il coniglio) da tutte le altre gabbie (e conigli) del mondo (Eppure noi, la gabbia, la immaginiamo). Se King invece avesse scritto "Lì c'è una gabbia trenta per trenta, con sbarre di acciaio da tre millimetri di diametro, e dentro la gabbia c'è un coniglio nano pezzato grigio e bianco, con le orecchie afflosciate all'indietro" questa sì, sarebbe stata una descrizione raccontata. Ma sarebbe stata narrativa? No! Sarebbe stata una descrizione da manuale, esattamente come "Mario è alto". La descrizione fine a se stessa, infatti, è materia da manualistica: le descrizioni fanno parte della narrativa purché siano armonizzate con il contesto e sfruttate per scopi voluti dall'autore. Per dirla con parole semplici: le descrizioni, come le azioni, in narrativa vanno mostrate. Se si descrive in modo statico, o perché si ha il dubbio che il lettore non abbia ben capito e si vogliono fornire dettagli a tutti i costi, si esce dal contesto narrativo (e si ricade nel fenomeno che viene definito infodumping, letteralmente discarica di informazioni, di cui parleremo a fondo più avanti). Ma se si descrive con dinamismo, per dare sostanza e profondità al contesto in cui introduciamo il lettore, allora le cose cambiano.
La nostra definizione per la descrizione quindi potrebbe diventare:
Descrivere raccontando è manualistica. Nel processo narrativo la descrizione è insita nel mostrare.
Se, invece, leggiamo qualcosa del genere:
In una caverna viveva uno hobbit. Non era una caverna brutta, sporca, umida, piena di resti di vermi e di trasudo fetido, e neanche una caverna arida, spoglia, sabbiosa, con dentro niente per sedersi o da mangiare: era una caverna hobbit, cioè comodissima.
Siamo di fronte a un mostrare? A un raccontare? Un descrivere? Abbiamo stabilito che raccontare è imporre al lettore parole e fatti generici e l'inizio di questo incipit è di certo un'imposizione dall'alto. In più termini generici come brutta, sporca sembrerebbero proprio rientrare nel raccontato. D'altra parte, se mostrare è calare il lettore nella storia con dettagli concreti e dinamici… i resti di vermi e il trasudo fetido sono abbastanza concreti da mostrarci il concetto di squallore senza imporcelo. A complicare la nostra analisi si aggiunge il fatto che questo incipit è più una non-descrizione che una descrizione, dato che ci descrive come non era quella caverna. Sembrerebbe quindi un guazzabuglio confuso, un tentativo maldestro di mischiare raccontato e mostrato, eppure… rimaniamo forse perplessi durante la lettura? Incespichiamo? Assolutamente no. Leggendo riusciamo a figurarci come possa essere questa caverna hobbit: possiamo senza sforzi immaginare, crearci una nostra caverna hobbit, nonostante Tolkien ci abbia fornito soltanto informazioni su come non sia una caverna hobbit. Come è possibile tutto questo? È presto detto: "Cioè comodissima". Due parole, e per di più decisamente semplici! Due parole (nel testo in lingua originale sono tre: "That means comfort", ma il succo non cambia) che da sole ci dipingono l'intera atmosfera. Siamo tornati al coniglio di King: se vengono preparate bene, se il lettore viene indirizzato sui giusti binari, allo Scrittore possono bastare due parole per creare la magia dello scrivere. E questo non è né mostrare, né raccontare: è narrare. E non troveremo in alcun dizionario una sintesi di questa magia, che rappresenta per noi il punto di arrivo di un cammino meravigliosamente complesso: imparare a narrare è, in definitiva, imparare a scrivere.
Ecco un altro esempio in grado di mostrarci la differenza tra descrivere, mostrare e narrare.
È lunedì 16 gennaio 2012, sono passati tre giorni dal naufragio della nave da crociera Concordia all'Isola del Giglio. Durante un servizio televisivo il giornalista ci descrive i fatti: illustra le cause supposte dell'incidente, aggiorna la conta delle vittime, riporta parola per parola le ultime dichiarazioni del presidente della Costa Crociere. Descrive, appunto. Poi passa il microfono a una signora anziana, la madre di un maître di sala che lavorava sulla nave. Lei annaspa, tutta presa dall'emozione: "Mio figlio mi ha telefonato subito, quando la costiera lo ha sbarcato! E mi diceva: mamma, mamma rientra in casa che fa freddo!" Poi la signora comincia ad ansimare e aggiunge: "È rimasto a casa solo un giorno! Eh, perché aveva i vestiti per lavorare, ma quelli son sottili e qua è freddo freddo". Infine spara un: "E il cuore andava tanto che non ci sarebbe entrata nemmeno una lenticchia".
Nemmeno una lenticchia: la distanza tra descrivere e mostrare è tutta qui. Possiamo descrivere per un intero servizio giornalistico (o per un intero manuale), possiamo raccontare per duecento pagine spiegando ogni dettaglio, ma la potenza e la magia di una sola ...