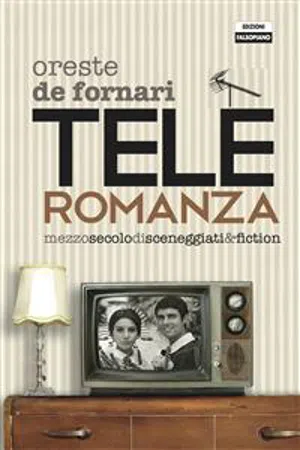![]()
Recitazione fin troppo neoclassica. Con la scusa che devono interpretare personaggi molto bravi a nascondere le emozioni, certi attori fanno anche a meno di recitare. (Però l’inflessione balcanica di Veronica Lazar ben si addice al clima cosmopolita del castello). D’altronde è comune, fra i giovani registi degli anni Sessanta, prendere troppo sul serio certe boutades sull’inutilità degli attori pronunciate da Antonioni, Hitchcock o Rossellini; i quali poi usavano quasi sempre ottime attrici e talvolta le sposavano.
Il più eccentrico e il più d’autore di questi eccentrici sceneggiati d’autore, è senz’altro Orlando furioso (1975) di Luca Ronconi, scomplessata apoteosi del teatro filmato, ispirata al leggendario spettacolo happening del 1969.
Allora, in piazza, scambi di parti e di posizioni fra attori e pubblico, spettatori che spingono le macchine, si sparpagliano per seguire azioni simultanee su piattaforme mobili… sei anni dopo in tv, nessun tentativo di parafrasi, ma ancora versi, recitazione stilizzata e macchine sceniche in vista. Il tutto filologicamente dentro un vero palazzo cinquecentesco, il palazzo Farnese di Caprarola, per cui la salita al monte avviene su cavalli da giostra che salgono per uno scalone, il fiume è un corridoio allagato, la luna è in solaio… lo sceneggiato popolare come festa rinascimentale. Per una volta nessuno si è chiesto: «Il contadino cosa capirà?» e forse qualcuno ha suggerito: «Dategli brioches».
In effetti il «contadino», secondo il ragionamento appena un po’ snobistico che si usava fare in questi casi, dovrebbe avere tale nostalgia di teatro dei pupi, cantastorie e simili, da accogliere con gratitudine uno spettacolo dove gli attori anziché parlare declamano, anziché camminare si muovono su carrelli invisibili, anziché colpirsi con la spada si sfiorano.
Il miracolismo di Ronconi è comunque pari al suo (relativo) ermetismo. Gran profusione di prospettive, trompe-l’oeil, effetti acquario (la fotografia è di Vittorio Storaro), mostri meccanici da teatro per ragazzi, parodie quasi rivistaiole, quali l’assolo stridulo e gutturale di Olimpia-Mariangela Melato, dissacrazioni acrobatiche (e apocrife) come il finale in chiesa, dove il paladino Ruggiero ammazza il saraceno Rodomonte con la benedizione del vescovo, facendolo schizzare in aria in un’iperbole da cartoon.
Perché qui il magico trova sempre modo di imporsi, nonostante ironia e straniamento. Ruggiero insegue Angelica in un salone del palazzo, ma bastano un’inquadratura dall’alto e un tappeto di foglie, per evocare il bosco e sospendere momentaneamente l’incredulità. L’ippogrifo che incombe dall’alto è finto, ma è veramente di latta… e se un argano si rompesse? La festa rischia di trasformarsi in un luna park degli orrori.
Non sapremmo dire se stiamo assistendo a un rito teatrale o vivendo un’illusione televisiva. Il dubbio talvolta è delizioso. Quando Ottavia Piccolo-Angelica viene rapita da Sacripante-Giacomo Piperno, invece di opporre resistenza, gli salta sulle spalle e assume una posa plastica tipo ratto di Proserpina: come in un balletto. È Angelica a comportarsi con tale aggraziata incoerenza, o è Ottavia Piccolo che spunta dietro Angelica? Per un attimo lo scollamento attrice-personaggio è evidente, il verosimile vacilla (che sia questo lo specifico televisivo?).
E alla fine di ogni puntata, mentre scorrono i titoli, gran rovesciamento di prospettiva e rivediamo gli episodi principali con i retroscena (tecnici al lavoro, riflettori, macchina da presa…), un po’ alla maniera di Godard. Forse una nouvelle vague televisiva è esistita davvero.
Quasifilm
Un tempo kolossal era sinonimo di tabù, in televisione. Si narra che il direttore dei programmi Pugliese, il quale seguiva le prove di Ottocento dal suo ufficio, in bassa frequenza (uno status symbol che Darryl Zanuck gli avrebbe invidiato), davanti alla scena del ballo alle Tuileries - ufficiali in alta uniforme, diplomatici con feluca, dame in crinolina - abbia perso le staffe. «Cinquecento figuranti!» tuonò nel telefono al regista Majano. «Pazzo, ti sei messo in testa di rovinarci!»; ma si ingannava, i figuranti erano solo duecento, pur sembrando molti di più. Il vecchio direttore non poteva immaginare che di lì a pochi anni migliaia di figuranti avvolti nel peplo sarebbero transitati sugli schermi della domenica sera.
Come si è visto, con Odissea, prodotta da De Laurentiis nel 1968, la Rai apre al cinema, al cinema in grande: fatte le proporzioni si potrebbe dire al kolossal. Ma cos’è esattamente un kolossal? Un film, di solito in costume, dove, come suol dirsi, si vedono i soldi, i tanti soldi investiti. Un’operazione industriale, un business, ma anche, nel gergo degli etnologi, un potlac, uno di quegli sprechi rituali con cui certe tribù di indiani ostentavano la propria forza, per abbattere l’orgoglio dei rivali e propiziarsi il favore degli dèi: in termini moderni, un’operazione di immagine.
I soldi però, e la loro esibizione, non sono tutto: Via col vento è passato alla storia più per i lampi nello sguardo di Vivien Leigh che per i bagliori dell’incendio di Atlanta. La regola vale anche in tv. E poiché l’obiettivo dei piccoli kolossal Rai è di entrare nel mercato internazionale e possibilmente in quello americano, conviene intanto vedere come sono fatte le prime grandi miniserie americane.
Di colossale hanno soprattutto il senso del tempo: racconti ciclici, saghe familiari, dove si vedono passare gli anni, i decenni. Non proprio saghe ottocentesche, puritane, come a Hollywood, piuttosto storie di emarginati e perseguitati (Radici, Olocausto), o anche di vincitori, ma rilette in chiave progressista (Alla conquista del West). Un modo per salvare pedagogia e intrattenimento, unire vecchi valori e nuovi doveri, senza osare troppo.
Per esempio Radici fa un lungo inventario di angherie ai danni dei neri - fustigazioni, amputazioni, violenze carnali - ma non sospetta mai che avessero a che fare con la logica del profitto (tra l’altro i salariati del Nord non se la passavano tanto meglio degli schiavi del Sud).
Non si tratta, come ha scritto qualcuno, di un Via col vento dall’altra parte della barricata, perché Rossella O’Hara si imponeva come eroina senza rinunciare a compromessi e colpi bassi, mentre i neri del teleromanzo sono tutti molto perbene, come se dovessero meritare la benevolenza dello spettatore bianco. Un antirazzismo alla Sidney Poitier e anche più ottimista, con carriere dall’ago al milione, dove i garzoni di falegname diventano industriali del legno e gli steward ferroviari vincono cattedre all’università. Ai margini ogni tanto qualcuno inciampa e finisce male, ma questo non riguarda comunque la famiglia protagonista. E lo stile naturalmente è più scialbo che in Via col vento.
Non molto diversa la formula di Olocausto. Anche qui gli oppressi sono talmente miti e generosi da non meritare la loro sorte. Stessa morale di quei film americani dove linciaggi e sedia elettrica vengono deprecati solo perché colpiscono vittime innocenti. Ogni tanto si sfugge al cliché. Per esempio il funzionario delle SS non è il solito tipo del nazista fanatico, ma un giurista disoccupato che su istigazione della moglie si iscrive al partito e fa una rapida carriera come pianificatore dei campi di sterminio. Dà l’impressione di una lettura a freddo, razionale, del fenomeno. Eppure si esce dalle dieci ore di Olocausto senza aver capito non solo in difesa di quali interessi è nato il nazismo, ma neanche su quali istinti popolari ha fatto leva.
Alla conquista del West è ispirato alla variante revisionista del western. Ritroviamo indiani vittime di sopraffazioni, reduci di guerra diventati fuorilegge per colpa della società, prostitute di buon cuore, eccetera. Gli eroi, i componenti della famiglia Macahan, sono sempre dalla parte del bene, e danno una mano a indiani e quaccheri perseguitati, anche se evitano di contaminarsi: ospitano una coppia di mormoni, ma la ragazza Macahan rifiuta in extremis di diventare la terza moglie del mormone poligamo; lo zio si allea agli indiani in guerra e intralcia l’inseguimento delle giacche blu, ma senza versare una goccia di sangue yankee. Una ben cauta lezione di tolleranza.
Vera novità, l’impianto a mosaico che alterna le avventure dei vari familiari: quella dello zio è appena terminata, mentre il nipote è a metà strada e le tre donne sono all’inizio… Così non dobbiamo aspettare troppo la conclusione di un episodio e al tempo stesso veniamo sollecitati a non perdere le puntate successive. Grazie alle puntate e al mosaico, tutti sono necessari e nessuno è indispensabile. Verso la metà dello sceneggiato capita che la madre, interpretata da Eva Marie Saint, esca di scena con un debole pretesto (muore fuori campo salvando la figlia da un incendio) e venga rimpiazzata da una zia con circa la stessa età e le stesse funzioni (l’attrice aveva altri impegni, la sua popolarità era in declino, le sue pretese eccessive…). Un po’ come nei vecchi feuilleton letterari, dove l’autore faceva morire e resuscitare i personaggi a seconda delle simpatie del pubblico.
Meno seriali e apparentemente più originali, le miniserie tratte dai modern classics di Fitzgerald, Hemingway… Una delle prime è stata Da qui all’eternità, diretto da Buzz Kulik, dal romanzo di James Jones, che sembrava imbrattare la linda immagine della caserma-scuola di vita di tanti film hollywoodiani, trasformandola in una specie di Peyton Place, popolata da sergenti sadici, ufficiali arrivisti, reclute nevrotizzate, mogli adultere. Che bisogno c’era di rifarlo, dopo la versione cinematografica di Zinnemann del 1953 (con Montgomery Clift, Deborah Kerr, Burt Lancaster…)?
Per aggiungere i colori e dire quel poco che non si era potuto dire allora. Per cui il bordello è un bordello, e non un circolo ricreativo, il soldato in castigo pulisce le latrine, il sergente seduce la moglie del capitano senza tanti complimenti: «Perché è venuto qui, sergente?». «Per andare a letto con lei». Al contrario nello Zinnemann il desiderio si leggeva nelle esitazioni e nelle occhiate timide fra i due, frutto di sapiente drammaturgia; il pudore come antidoto alla piattezza.
Allora le autorità militari avevano acconsentito a collaborare a patto che non si vedesse quel che succede al soldato Maggio (Frank Sinatra) quando entra nella compagnia di disciplina. Infatti, dopo l’inquadratura del sergentaccio (Ernest Borgnine) che lo accoglie, seduto alla scrivania, con un sfollagente in mano, non si vede più nulla e si può immaginare tutto. Nella miniserie; come già nel romanzo, entriamo nel quasi-lager per assistere alle solite angherie e seguire il crollo nervoso del soldato.
Poche concessioni al rosa. Nel finale non ci sono più le ghirlande gettate in mare con relativa leggenda hawaiana stile fontana di Trevi, presente invece nel romanzo. Ma forse mettere in sordina il melodramma a favore del realismo, facendo tutti più disillusi, fa sembrare ancora più melodrammatica la situazione, il gran raduno di perdenti e di biechi prima dell’uragano. Almeno Zinnemann, che dava alla storia un sapore romantico, finiva per mettersi dalla parte degli irregolari e dei loro sogni di rivolta, anche a rischio di sembrare ingenuo dieci o vent’anni dopo.
In quanto al lato kolossal si nota, come già in Radici e negli altri, meno teatro, più velocità che nei vecchi sceneggiati italiani, ma anche una certa moderazione nei costi e nessuna voglia di far concorrenza a Hollywood.
La Rai invece, non senza dimostrare un certo strabismo provinciale, sembra confondere la tv americana con Hollywood e adotta nei primi tempi soggetti di argomento biblico o mitologico. Un modo per guardare al futuro internazionale e al tempo stesso risalire alle fonti della cultura umanistica, conciliando spettacolarità e classicismo, Cecil B. DeMille e Vincenzo Monti. (Ricordate Prosopopea di Pericle, dove il busto dell’ateniese si metteva a parlare? I primi kolossal Rai si distingueranno per un che di gessoso, di prosopopeico appunto.)
Quanto poi sia difficile far parlare gli eroi antichi, e le statue, lo sa chi ha letto o ha visto Il disprezzo, dove regista, produttore e sceneggiatore litigano in continuazione sul modo migliore di rifare l’Odissea, se aggiornarla o lasciarla così.
Qualche proposito ...