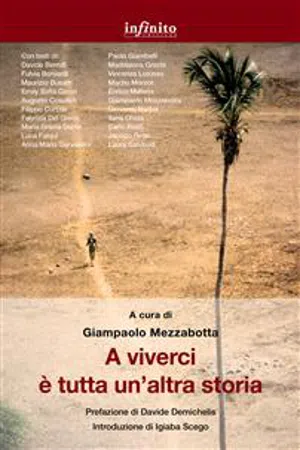di Marzio Marzot
Per andare da Brazzaville a Ouesso puoi scegliere l’automobile, un fuoristrada: 849 chilometri, due giorni di tragitto, principalmente in terra battuta, impraticabile con la pioggia. Oppure il battello: una settimana/dieci giorni per risalire il fiume Sangha, se non ci sono incidenti; un servizio che si pratica confusamente due volte al mese. Oppure il treno, che da tutti è considerato un gesto di puro masochismo. Scartato. Infine l’aereo: un volo a settimana – apparentemente la scelta più semplice, in realtà sarà un miracolo arrivare, dato lo stato dell’aereo, del pilota e della pista d’atterraggio.
Siamo dunque partiti con l’aereo, e con due ore di ritardo, giusto per aspettare il pilota che si sentiva ancora lo stomaco distrutto dall’eccessiva bevuta della sera prima. Nell’attesa, sulla pista, in ordinata fila sotto al sole, guardavamo con preoccupazione i motori del nostro aereo, un bimotore: quello di destra era diverso da quello di sinistra. Diversa la marca, diverse le dimensioni… Aspettando pazientemente di salire sulla scaletta, gocce di olio nero ci cadevano pigramente addosso. Il viaggio fu reso nauseante dall’odore dolciastro di selvaggina, penetrante, violento, misto a vomito, di cui era impregnata la moquette azzurro-marroncina. Molti i sedili divelti, tutti i finestrini incrinati e completamente opachi. Infine l’atterraggio: un disastro, in due tempi, eterni… su una pista di cemento abbandonata e costellata di lunghe crepe, buche, ciuffi d’erba e macchie d’olio.
Poi abbiamo saputo che il nostro volo è stato l’ultimo di quel velivolo, prima di un lungo periodo di riposo o di revisione generale o di rottamazione definitiva.
Dopo circa un’ora di volo, sopra un oceano verde senza fine – 13mila ettari di foresta primordiale – siamo arrivati a Ouesso, capoluogo della regione Sangha, 10mila abitanti, sulla riva desta del grande fiume Sangha, al confine con il Camerun: un approccio difficile ampiamente ripagato da un’accoglienza calorosa. La nostra piccola comitiva, interessata alla raccolta del miele praticata dai pigmei nella foresta equatoriale, era stata preannunciata e le autorità locali erano lì, gentilmente a nostra disposizione. Ed è subito sosta intorno a un tavolino di un bar: birra Ngok, quella del coccodrillo, cachauète, le arachidi tostate, e tante chiacchiere, spiritose e intelligenti, come spesso sanno fare i congolesi. Non a caso un proverbio locale dice: “La parola è il coltello, le gambe la verdura”, per indicare chiaramente chi dei due è il più forte. In Congo la percentuale di laureati è sopra la media africana, la cultura è rispettata, ma l’inefficienza è diffusa: qui vige la dialettica, non l’organizzazione (parola di Norbert).
Nel corso della piacevole permanenza a Ouesso, nei tempi morti (che sono stati tanti poiché c’è sempre qualcuno che inspiegabilmente sparisce), ci siamo ritrovati senza eccezione intorno a un tavolino di un bar, sotto gli alberi carichi di grandi foglie umide e verdissime, al riparo dal sole implacabile. Le chiacchiere alimentate dalla birra non avevano mai fine, alternando alle solite cacahuète abbrustolite le saporite termiti tostate al sole, con un po’ di sale e vari bicchierini di Ngolò ngolò, il distillato brucia budella ricavato in zona dal mais.
Norbert, giovanissimo tecnico della Direzione agricola, ricordava i suoi studi danteschi e chiedeva se Verona fosse davvero così bella, così degna della storia di Paolo e Francesca, piccolo, perdonabile lapsus storico-letterario.
Confesso che risulta un po’ curioso sentire parlare di Dante nel bel mezzo della foresta primordiale, ma Norbert è un vero intellettuale e si accalora a confessarci del piacere fisico di quando riusciva a risolvere un’equazione complessa, era come avere un’erezione, anzi, aveva proprio un’erezione.
Félicien, direttore regionale dell’Agricoltura, ci illustrava la zona, il fiume Sangha, pieno di “porcherie”, che lui chiamava “les affreux de la rivière”: ippopotami, coccodrilli, sanguisughe, pesci lampreda, boa, zanzare cariche di malaria, karà, l’insetto caustico , eccetera. Le storie di lamprede che mordevano il sedere ai viaggiatori in canoa, di boa che insistevano a tirarti sott’acqua, erano divertenti, tragicomiche.
Auguste François, un albino, notabile della zona, affetto dalla gotta per il troppo mangiare cacciagione a colazione, pranzo e cena, tutti i santi giorni di tutto l’anno, era indignato da quel vergognoso can-can che i bianchi stanno facendo attorno all’Aids: “Le Sida! Je dis que c’est une mise-en-scène, tutta una montatura! Io l’ho avuto già due volte e sono sempre guarito!”.
Firmin, detto Kiroké, cioè uomo semplice e accogliente, confessa d’essere fermamente deciso a sposarsi solo dopo i trentasei anni. Intanto sta bene attento: è prudentissimo. Sa cosa vogliono le ragazzine, e lui non ci casca. Guai! Se lui s’innamora cade dans le chaos technique. E tutto è perduto.
Il prefetto quella mattina non c’era: “Vi prega di scusarlo. Attualmente è un po’ occupato a togliere una barricata…”. Ma il giorno dopo gentilmente recupera, invitandoci a casa sua per cena, tutta rigorosamente a base di cacciagione, dal potamocero – sorta di cinghiale – all’antilope, passando per il pipistrello e il riccio. E tutto mirabilmente cucinato alla brace o in umido. Davvero una cena molto saporita.
Quella sera abbiamo fatto tardi, coinvolti in racconti favolosi, anche sul suo insediamento come nuovo prefetto, costellato da episodi magici, soprattutto gestiti dal vecchio Kailukò, veggente severo d’oltre novant’anni e protettore del villaggio; molti i fenomeni inspiegabili di sue divinazioni e molte le mirabolanti apparizioni notturne: un cerchio di ibù – piccoli erbivori della foresta – bianchi attorno alla casa del nuovo prefetto come benvenuto e segno di accettazione. Un cacciatore che rientrava alle cinque di mattina stava per sparare agli ibù, ma dal nulla è apparso il vecchio veggente Kailukò: “Fermati! Sono lì a protezione! Non commettere sacrilegio!”.
Quei racconti, alla tremolante luce della lampada a petrolio, ci penetravano nel profondo, facendo breccia nei nostri cuori scettici di occidentali. Abitualmente non siamo propensi a credere ai fantasmi, ma di magia e mistero è, in effetti, intrisa la notte equatoriale. Ritornando nel buio, alla sola luce delle stelle brillantissime, verso quella specie di albergo dove alloggiavamo, ci sembrava che sotto quel cielo, sotto quegli alberi, immersi in quell’aria umida e brulicante di vita – che ci faceva pensare al brodo primordiale – tutto era credibile, tutto era possibile. Norbert parte con un’ode alla vita, al Congo, alla foresta pluviale incontaminata, che definisce come l’utero della madre terra, umido, molle, tiepido, dove tutto può nascere, e se nasce poi cresce, poiché tutto qui cresce. Miliardi di batteri impazziti, improvvise evoluzioni biologiche, dinosauri superstiti… era qui il paradiso terrestre.
Il prefetto, comunque, aveva confermato che i pigmei rimasti in quella zona sono non più di 30mila. Appartengono al gruppo M’Baka, cacciatori nomadi, ma sempre più spesso sedentarizzati intorno ai villaggi bantu, ai confini delle piantagioni, vicino alle segherie o lungo la nazionale, pronti a commerciare la selvaggina con i passeggeri dei camion stracarichi che fanno servizio tra Ouesso e la capitale. In qualche modo le loro tradizioni si stanno perdendo, i matrimoni misti si fanno sempre più frequenti, la lingua si mescola con i dialetti locali. Le cerimonie d’iniziazione sono già derivate da quelle dei Bantu. I loro piccoli villaggi, di quaranta/cinquanta persone, sono composti di capanne in legno e fango, non più quei precari igloo di rami e foglie, semplici ma perfettamente impermeabili anche alle più forti piogge. Le donne, come sempre, raccolgono i prodotti della foresta e come novità coltivano, anche se solo pochi metri quadrati di manioca. Gli uomini spesso offrono piccoli servizi occasionali e manovalanza di tipo feudale ai “grandi neri”, che ancora con difficoltà tralasciano la loro mentalità di sentirsi superiori e padroni. Comunque, la maggioranza dei pigmei non dimentica di essere per tradizione dedita soprattutto alla caccia. Usano le reti per catturare antilopi e potamoceri, mentre con l’arco e le frecce, e sempre più spesso con la balestra, cacciano uccelli, scimmie, pangolini, topi e pipistrelli. Pescano pesci con la fiocina e raccolgono il miele selvatico prodotto dalle api, che qua chiamano na gnou gnou.
Ecco, di là dai drammatici problemi che coinvolgono e condannano all’estinzione questo pacifico e allegro popolo, era la raccolta del miele che questa volta dovevamo documentare, facendo risaltare il fatto che i pigmei, quando raccolgono il miele, non distruggono la famiglia delle api ma prelevano solo i favi, a differenza dei contadini che utilizzano il veleno delle foglie di manioca, abbattono l’albero che ospita l’alveare e poi bruciano tutto, ammazzando ogni volta migliaia di api, distruggendo la famiglia e provocando incendi.
Ancora qualche giorno per organizzare la spedizione e poi, finalmente, si parte.
La zona scelta è nei pressi di Keita, un piccolissimo villaggio sulla statale N.2, 25 chilometri verso sud. La strada è in terra battuta, aggredita da ogni lato dalla vegetazione che tende a ricoprire tutto, a cancellare quella cicatrice di laterite rossa fiammante che avevamo intravisto dall’aereo. È una vegetazione che si fa prepotentemente largo a gomitate: ciuffi fitti d’erba alta anche due metri, fili d’erba che tagliano come coltelli affilati, rampicanti che strisciano sul terreno come serpenti, tanti fiori, alcuni davvero “impudichi”, come ci fanno notare sghignazzando i nostri accompagnatori; e poi safoutier dai frutti dolcissimi, talì dai fiori talmente velenosi che anche il miele che se ne ricava è mortale per l’uomo, e poi acacie in fiore di ogni tipo. Molti alberi da un lato perdono le foglie, come in autunno, mentre dall’altra buttano i germogli e fioriscono, come in primavera. “Sono schizofrenici, è l’anarchia!”, sentenzia Norbert, spiegando così come sia difficile governare questo Paese.
Arrivati all’altezza del villaggio fermiamo il fuoristrada in uno spiazzo e ci inoltriamo verso il gruppo principale di capanne. La zona è stata di recente disboscata ma la vegetazione è ricresciuta in poco tempo oltre i tre metri d’altezza. Da un cespuglio di erba giallo-verde spunta un pigmeo, uno “vero”, come si vedono in certi reportage fotografici del National Geographic: il piccolo corpo asciutto e muscoloso, non molto scuro, lucido di olio di palma, un gonnellino di fibre vegetali, un grande coltello con la lama elegante a forma di foglia allungata, il bastone intagliato con cura, corde di liana a tracolla. Gli occhi mobilissimi, miti ma vivaci. Bisognerà fotografarlo, per dimostrare che siamo davvero stati nella foresta equatoriale, tra i pigmei. Ne incontriamo altri, quasi solo anziani, donne e bambini. Gli uomini validi saranno a caccia. O a ubriacarsi: l’alcolismo è la nuova piaga sociale.
Mentre stiamo seduti all’ombra di una tettoia di frasche, al centro del villaggio, ci viene a salutare anche un ragazzo. Regge tre balestre in mano. Le chiama M’Padi. La tentazione è troppo forte e ne compro una per ricordo. È un capolavoro di precisione, tutta in legno, perni e grilletto compresi; le frecce lunghe e sottili, alcune con la punta in metallo, sono imbevute di veleno micidiale. Ci assicurano che bastano poche frecce avvelenate per abbattere un elefante, e la scimmia, colpita sui rami, quando cade a terra è già morta .
Poi altri vengono timidamente a offrirci in vendita altri oggetti: un teschio d’orango, due pelli di vipera enormi , una scimmia morta e affumicata (buonissima in umido, ma inquietante per quanto assomiglia al corpo di un bambino). Non incoraggiamo questo tipo di trofei e loro se ne vanno senza insistere.
Ricordando le mie letture sui pigmei, penso che mi piacerebbe moltissimo fermarmi qualche giorno in compagnia di questo popolo, dedito alla “bella vita”, mai in guerra con nessuno da quando esistono, in perfetta armonia con la natura e profondo e insuperato conoscitore della foresta. Mi piacerebbe moltissimo partecipare a una loro caccia comunitaria, o assistere a una festa, sedere intorno al fuoco tutta la notte, ascoltare i loro ritmi complessi e i loro canti, quei canti polifonici intessuti di suoni misteriosi che hanno affascinato musicisti di tutto il mondo. Ma capisco che non è il caso. Non sarà questa l’occasione in cui potrò ascoltare il canto mobandi, dedicato alla raccolta del miele, di cui conosco a memoria alcune frasi. Da un lato, i pigmei sono molto riservati e, pur avendo rapporti facili con gli stranieri, le loro tradizioni sono custodite con molta gelosia. Bisognerebbe fermarsi a lungo, entrare in profonda amicizia, come hanno fatto Turnbull, Cradick e soprattutto Louis Sarno . Dall’altra, questo villaggio “fisso” è già una prova della corruzione delle loro tradizioni. Qui, forse, dopo anni di contatti con i “grandi neri”, si è già consumato quel violento processo di deculturazione di cui ci aveva parlato il prefetto.
Incontriamo presto anche il responsabile del villaggio. Non è un capo vero e proprio, poiché tra i pigmei la gerarchia è molto elastica e vige un profondo senso democratico. C’è solo un anziano a cui si fa riferimento e che è considerato come un “vecchio padre”.
Attraverso l’interprete gli spieghiamo il nostro progetto. “Non c’è problema”, è la risposta. Per domani si organizzerà una raccolta di miele nella foresta. E gli occhi intelligenti del “vecchio padre” ci assicurano che tutto è sotto controllo.
Rientriamo a Ouesso. Ceniamo al solito bar, comprando lungo la strada i gustosi pescetti alla brace dalla graziosa madame Annà. Ma il prezzo del pesce è anche oggi aumentato. Chiediamo spiegazioni: “Insomma, qual è il prezzo del pesce?”. Gli occhi di madame Annà non sanno mentire e la sua risposta è semplice: “Il pesce va da 250 franchi all’infinito…”.
Rischiando l’infinito, torneremo spesso da lei. Del resto le alternative non erano molte: o scimmia o ver palmiste. La scimmia assomiglia troppo a un bambino abbrustolito, per incontrare il mio gradimento, e la larva della palma è troppo bianca, grassa, succulenta, dolciastra, nauseabonda . Proveremo una sola volta anche un altro posto dove si vendeva cibo cucinato, ma a parte il fatto deprecabile che lì i pipistrelli in umido non erano ben scuoiati, e ciuffi di pelo galleggiavano nel rosso olio di palma, anche la visita tra i fornelli di un mamba verde ( Dendroaspis angusticeps), uno dei serpenti più velenosi al mondo, ci ha dissuaso da ulteriori frequentazioni.
La prima notte trascorre calda e lenta, cadenzata da improvvisi scrosci di pioggia violenta e accompagnata fino a un’ora prima dell’alba da canti funebri, lamenti confusi, rapidi scoppi di grida e tamburi instancabili. Meglio che a Brazzaville, dove a punteggiare la nottata erano le aspre raffiche di mitra e i tonfi cupi dei mortai. Al mattino incontriamo la spiegazione a tanto trambusto: giovani donne con il viso impastato di bianco caolino, in segno di lutto.
Fatto rifornimento miracoloso di benzina, cibo, acqua e le indispensabili cacahuète, finalmente partiamo. Al villaggio Keita siamo attesi da tre giovani raccoglitori di miele e un vecchio, molto arzillo, con una rada barbetta bianca e poche rughe, e due occhi pungenti come spilli ripieni di un’allegria contagiosa. È lui il nostro attore principale, il protagonista.
Ci addentriamo nella foresta, impressionante per quanto buia, umida e fitta, dove ogni suono è ovattato e ogni foglia sembra nascondere un agguato. Sopra di noi i “giganti” della foresta, il mogano sapelli dai tronchi drittissimi, tra i 40 e i 60 metri d’altezza. Qui nessun uomo, dalla nascita del mondo, ha mai tagliato questi tronchi.
Procediamo lungo un sentiero aperto dai machete che recidono di netto gli arbusti teneri e sugosi. Trecento metri stancano più di un chilometro e siamo subito tutti in un bagno di sudore. Ci accorgiamo che le nostre vere guide sono tre bambini comandati da una bambina, sette anni forse e occhi grandissimi. Sono loro che hanno visto le api e le hanno seguite fino all’alb...