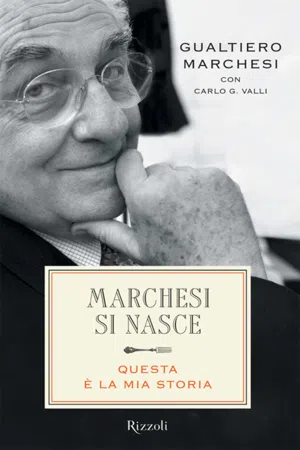![]()
PRIMA PARTE
![]()
1
IL MARCHESINO, L’ULTIMO NATO
Nel 2008 nasce a Milano il Marchesino.
Chi se lo aspettava, dopo quindici anni, di ritornare nella mia città pur continuando a gestire il ristorante dell’Albereta a Erbusco? Forse nemmeno io.
Quando chiusi il Bonvesin de la Riva, non avrei certo immaginato di inaugurare, un giorno, un ristorante nei locali dello storico Biffi, proprio in piazza della Scala, anzi proprio nel palazzo del Piermarini, il santuario della musica.
Musica e cucina, le passioni della mia vita, praticamente sotto lo stesso tetto: una gioia immensa.
Sembra la celebrazione di un destino felice e appassionato.
Dalla vita ho avuto tutto quello che potevo desiderare: successo, notorietà, riconoscimenti sinceri, una laurea honoris causa e una famiglia fantastica.
Avevo avverato il mio sogno di creare una cucina nuova, ma sotto sotto covavo un antico desiderio: legare il mio nome a Milano.
Siccome non vi è limite all’ambizione umana, quando scherzavo con gli amici che mi spronavano a rientrare a Milano, provocatoriamente dicevo loro che solo tre posti della città avrebbero potuto convincermi: il Duomo, La Scala e il Castello Sforzesco! Beh, il Duomo era davvero fuori dalla mia portata, per il Castello non sapevo proprio come arrivarci, mentre il mio approdo alla Scala fu quasi naturale.
La direzione del Teatro bandiva un concorso per affidare la gestione del ristorante e del bar che per lunghi anni erano stati la sede dell’indimenticabile Biffi Scala, quasi un’istituzione. Sentivo che dovevo battermi per aggiudicarmi questa inaspettata opportunità, e alla fine vinsi.
Il 7 maggio inauguro «Il Marchesino al Teatro alla Scala».
Segna il mio ritorno a Milano.
Oggi posso dire con grande soddisfazione di aver trasformato in realtà anche l’ultima delle mie più fantasiose, quasi utopiche, aspirazioni.
La vita moderna impone una cucina salutare, dietetica, convinta e compatibile. Questa tendenza mi offre la possibilità, in un ambiente come quello della Scala, di puntare sul gourmet, la persona di gusto e di palato che ama assaporare piatti all’insegna di un’armoniosa semplicità, più che sul gourmand, il goloso. Mi dà modo di offrire sapori di cose buone, momenti gastronomici interessanti uniti al più assoluto relax. Evito sia gli appesantimenti che rallentano la ripresa del lavoro, sia gli eccessi di sbrigatività e approssimazione.
Provo spesso la tentazione di mettere nella carta tre «panini» dedicati agli edifici più imponenti della città, così come da giovane avevo inventato il Grattacielo, un panino a cinque piani di imbottiture che preparavo per tutt’altro genere di commensali nel ristorante dei miei genitori. Tuttavia «pane e companatico» è una specialità che mi piace gustare da cliente. Io voglio continuare a occuparmi di cucina e, sfogliando i menu del vecchio Tantalo, sogno di ridare ai milanesi il minestrone più buono di Milano, come quello che cucinavano lì.
Con l’occhio attento alla tradizione, mi sembra di onorare in qualche modo un personaggio come Alfredo Valli, che alla Scala aveva cucinato per Maria Callas e Onassis in un piccolo angolo di cucina che mi ricordava molto la tavola calda e fredda del Mercato dove feci il mio apprendistato giovanile. Alfredo lo conobbi a Lecco a un concorso gastronomico che aveva vinto preparando una costoletta alla milanese, e dopo qualche tempo lo ritrovai con piacere al ristorante della Scala. La sua cucina non era attrezzata come quella del Marchesino: era poco più grande di un angolo cottura dal quale l’Alfredo riusciva a intrattenere i clienti, parlare con loro amabilmente e consigliarli come fosse un amico. In lui avevo ritrovato quella cura nel gestire il rapporto con l’avventore che avevo imparato al Mercato, il ristorante albergo, ma anche tavola calda e fredda, gestito dai miei genitori dove tutto ha avuto inizio.
Dopo aver selezionato centinaia di prosciutti, inventato altrettanti piatti, aperto cinque ristoranti, ottenuto tutto il firmamento delle stelle Michelin, e averlo poi rifiutato, ora sono qui per ricostruire la mia vita di cuoco, per guardare al passato, per cercare di condensare la mia «lezione» e spiegarne i principi. Sono qui per raccontare al lettore i ricordi di una vita vissuta con grande entusiasmo, piacere e curiosità, ma soprattutto con una passione mai sopita per il lavoro. Ho sempre ambito, fin da piccolo, a realizzare qualcosa di veramente speciale. Ognuno di noi dovrebbe desiderare di lasciare un piccolo segno.
Bene, anche oggi che posso dire di aver raggiunto un altro traguardo speciale, torno a confrontarmi senza tregua con la mia storia, tanto da temere di sbandare. Per fortuna ritrovo sempre la mia strada e la perseguo con tenacia, fino quasi a farmi male.
Nel raccontarmi, parlerò della mia cucina assunta come forma d’arte che non può prescindere dalla conoscenza del mestiere per librarsi al di sopra della consuetudine. E poiché il mio vero obiettivo vuole essere l’arte, è necessario che io mi rinnovi continuamente e che abbia la sfacciataggine di giocare sempre una carta nuova, anche se comporta dei rischi.
Gli eventi riportati alla memoria non sono solo episodi, aneddoti, grandi e piccoli, importanti o meno. Sono testimonianze dirette, incontri di persone, scambi di idee e meditazioni di gastronomia, per dirla alla Brillat-Savarin.
I ricordi sono presenze che non si cancellano, sono un quadro di vita.
E questo è il mio quadro.
![]()
2
MILANESE DI PORTA VITTORIA
Sono stato scodellato in una capace casseruola di rame imbottita di panni morbidi. Nulla di strano: era il 19 marzo del 1930 e allora i parti in casa erano la norma. Solo che la camera nella quale venni al mondo era una stanza del Mercato, l’albergo ristorante gestito dai miei genitori che stava proprio di fronte al mercato ortofrutticolo di via Cadore. Non mi meraviglierei quindi se mia madre fra una poppata per me e un risotto alla milanese per i clienti, usasse come culla proprio una di quelle pentole di rame di cui era piena la cucina.
L’Albergo Mercato si trovava in via Bezzecca, angolo via Cadore. Era stato fondato da mio padre Giuseppe e dal cognato cuoco nel 1927. Quando la società si sciolse e lo zio preferì andare all’estero, i miei genitori, improvvisando un mestiere che ancora conoscevano poco, subentrarono interamente alla società e per trentanove anni il Mercato fu l’attività di famiglia.
Nei secoli la gente di quel posto si è dedicata all’agricoltura, alla pesca, a cavare sabbia e ghiaia dal fiume e ad allevare bachi da seta. Anche gli zoccolai di San Zenone sono molto noti, ma l’attività a cui lega la sua fama, ironia della sorte, è proprio quella dei cuochi e dei dottori, tanto che un modo di dire tipico recita quel ca fa’ el doutor l’è rovinàa del cog (quel che fa il dottore viene vanificato dal cuoco).
A San Zenone, dove l’unica lingua che si usava era il dialetto, tutti conoscevano tutti, e tutti si occupavano di tutti, in primo luogo dei bambini e degli anziani, come fossimo una grande famiglia allargata. Il punto di ritrovo di quella piccola comunità era la via centrale dove c’era l’osteria della Carolina, la classica ostessa dei vecchi tempi, gioviale e accogliente, che non negava le sue attenzioni a nessuno degli avventori. Per me, devo ammettere, aveva un debole e forse io ne approfittavo un po’ perché davanti alla sua famosa frittata la Carolina non mi imponeva limiti e, se lo desideravo, correva persino nel pollaio e mi portava le uova delle sue grasse galline. Mi permetteva di mangiarne anche sei: le bucavo con uno spillo e poi le succhiavo avidamente. Il tutto, naturalmente, era accompagnato dal vino rosso, perché Carolina a me non negava davvero nulla.
L’attrazione principale di quel paese era tuttavia il grande fiume che in ogni stagione adagiava la sua cortina nebbiosa sul paesaggio rigoglioso e umido, scandendo con lo scorrere delle sue acque il ritmo della comunità. Rappresentava il luogo di fantastiche avventure, giochi e sfide senza fine. La prova numero uno consisteva nella traversata a nuoto, andata e ritorno. Erano inutili i tentativi delle mamme e delle nonne di dissuaderci con terribili storie legate a crampi, risucchi in improvvisi vortici, pericoli mortali dovuti alle correnti. L’amico-nemico fiume ci ammaliava e noi non potevamo starne lontani.
Io amavo fare delle escursioni su barchette che portavo come fossi un gondoliere veneziano manovrandole con un lungo remo e l’arpione per mantenere la direzione sotto riva. Ogni volta era una sfida: quei miseri gusci poco si adattavano alla mia ricercata tecnica di navigazione, ma mio zio Enrico Martinotti, geometra addetto al controllo del ponte in chiatte sul Po, forse convinto dalla mia passione, aveva progettato e disegnato una barca tutta per me. L’aveva fatta realizzare a Pavia e quando fu pronta, organizzai con i miei fedeli compagni d’avventura una gita per recuperarla. C’erano l’amico fraterno Aldo Calvi, che diventerà poi uno stimato pittore e che frequenterò anche da adulto, e suo cugino Anselmo. Insieme raggiungemmo Pavia e visto che non c’erano macchine, tanto meno carrelli da agganciarvi, per ritornare a casa con il mio nuovo gioiello era necessario sfidare la corrente del fiume. Non era impresa facile per cui ci procurammo delle provviste di cibo per affrontare la giornata e un certo numero di bottiglie di vino per brindare al traguardo finale dove ci aspettavano gli amici. Varammo la barca e partimmo dopo aver caricato il vettovagliamento. Per tenere le bottiglie in fresco le avevamo immerse nell’acqua legandole alla barca con delle cordicine. Alla fine la corrente fu la difficoltà minore di quel viaggio. Era estate e il sole delle ore più calde ci fu fatale. Dopo ore di navigazione eravamo irrimediabilmente ustionati e, giunti sotto il ponte dell’Olona dove ci aspettavano gli amici, eravamo rossi come peperoni. Per lenire le ustioni ci venne la splendida idea di spalmarci sulla pelle i pomodori che, simpaticamente, gli amici ci avevano tirato. Eravamo davvero ridotti male, ma ce l’avevamo fatta: il fiume era stato risalito e non mancava che brindare per festeggiare la barca nuova e l’impresa. Fu davvero amara la sorpresa quando ritirammo le corde e ci accorgemmo che erano rimasti solo i colli. Durante la faticosa risalita, le bottiglie si erano frantumate sbattendo contro i sassi del greto del fiume. Anche quella non era stata una buona idea e con il nostro vino, alla fine, aveva festeggiato solo il Po.
Con i miei compagni non avevamo mai più tentato un’avventura simile. Tuttavia ci vantavamo di essere arrivati, altre volte, fino alla foce del Po. Dopo averci visti rossi come peperoni, non erano più molti gli amici del paese che credevano ai nostri racconti un po’ troppo coloriti. Fra di loro c’era però un ragazzino un po’ credulone che in genere escludevamo dalle nostre gite in barca, perché lui, rispetto a noi, non possedeva il «fisico adatto». Stufo delle nostre vanterie, per riscattarsi e dimostrare il suo coraggio, un giorno si procurò una grossa camera d’aria, quella dei camion, e dopo essersela infilata si immerse nel fiume e cominciò a nuotare. Fu davvero incredibile, ma riuscì a percorrere tutto il Po sino alla foce. Il gesto fu a tal punto avventuroso che ne parlarono anche i giornali locali. Noi ci sentimmo dei veri pivelli e, per un po’ di tempo, lo scorno subito ci impedì di spararle grosse come era nostra abitudine.
Quando scoppiò la guerra l’albergo ristorante dei miei genitori fu requisito e con tutta la famiglia fummo sfollati a San Zenone dove rimanemmo fino alla Liberazione. Passai dalla città al paese, dall’istituto Gonzaga alla scuola di Stradella. Nella prima, frequentata dai figli delle famiglie bene di Milano, nelle ore di ginnastica potevo scegliere se giocare a pallamano oppure armeggiare con il fioretto, disciplina in cui vinsi addirittura una medaglia d’argento. Dopo il trasferimento a San Zenone il mio sport principale divenne un altro. Non che la scuola di Stradella ne offrisse un’ampia scelta, ma uno in particolare, era fondamentale. Poiché la mensa non esisteva, ogni giorno, mattina e pomeriggio, percorrevo dodici chilometri per andare e dodici chilometri per ritornare da scuola. In tutto quarantotto chilometri a cavallo della mia Bianchi, cambio Campagnolo, che in breve tempo mi fecero diventare un campione di ciclismo. Alla fine della guerra ero così allenato che a Milano, appena tornato, fui sfidato in una corsa da un ragazzo iscritto a una prestigiosa associazione di atletica. Ebbene, senza neanche tanta fatica, stracciai il piccolo campioncino che non poteva darsi pace di tutte quelle ore spese ad allenarsi. Ero così esaltato che mi iscrissi anch’io alla stessa società, ma la mia passione per l’atletica durò pochissimo.
Le pedalate per andare a scuola nonostante fossero lunghe avevano il loro fascino e le loro sorprese. Costeggiando il fiume, nelle prime ore del mattino spesso scoprivo lo zio Enrico su una piccola barca condotta da un amico, acquattato sul fondo e abbracciato a una vecchia spingarda che dava la caccia alle anatre selvatiche. L’operazione si svolgeva nel massimo silenzio e con la massima precisione. Il primo colpo doveva essere quello buono altrimenti, al rumore dello scoppio, tutti i volatili sarebbero spariti sott’acqua per riaffiorare duecento metri più in là, dando luogo a una battuta di caccia senza fine. Vedere lo zio sacramentare perché l’appostamento nella nebbia era stato vano era un divertimento che rendeva il viaggio in bici più leggero anche quando il freddo e l’umidità erano particolarmente duri.
Non era appassionato soltanto di caccia, ma anche di pesca, e una volta fu protagonista di una cattura leggendaria. Lo zio era solito sistemare delle ancore con attaccate delle anguille come esca. Una notte, mentre stava dormendo, lo svegliarono per dirgli che c’erano dei movimenti strani nel fiume. Forse erano storioni. Non glielo ripeterono un’altra volta che lo zio Enrico era già sulla sua barchetta. Uno storione aveva abboccato e dopo aver raggiunto il posto dove il pesce si dimenava come impazzito, slegò l’ancora per legarla alla barca. Lo storione cominciò a tirare, lo fece per ore senza tregua, ma alla fine vinse lo zio che si portò a casa un animale di cui a San Zenone parlano ancora oggi. Pesava centosessanta chili e appeso al portico di casa era stato sistemato con la coda piegata che strisciava per terra tanto era lungo.
L’isolotto in mezzo al Po, che in estate era il luogo designato delle nostre battaglie con stormi di tafani e zanzare che tentavano di divorarci, durante la guerra divenne per me lo scenario di qualcosa di terribile. Neanche le piene del grande fiume mi avevano spaventato tanto quanto il primo bombardamento aereo. Per evitare che i tedeschi distruggessero le vie di comunicazione, il ponte fatto di barche era stato disgregato e la chiatte a due a due erano state sparpagliate lungo il fiume. Quando sentimmo il rombo dei motori, era omai molto tardi per ritornare a riva. Io e mio cugino, più giovane di due anni, stavamo raggiungendo l’isolotto quando le picchiate dei terribili stuka ci colsero nel mezzo di quelle chiatte obiettivo delle bombe. Non riuscimmo più a procedere oltre e non ci restò che allungarci supini con le mani sulla testa e aspettare la fine. Furono i dieci minuti più lunghi della mia vita e ricordo ancora che impressione strana mi fece, alcuni anni dopo, incrociare al Kulm di St. Moritz, dove facevo uno stage, Wilhelm Messerschmitt, uno dei principali progettisti e costruttori al servizio dell’aviazione militare tedesca.
Per fortuna arrivò la fine della guerra e con quella anche il ritorno degli amici che riuscirono a scamparla. Potei riabbracciare Anselmo, un caro amico di famiglia che arrivò a bordo di un pullman nella piazza principale creando lo scompiglio generale nel paese. Avevo solo dodici anni, ma il ricordo di quell’abbraccio è ancora molto forte. Sarebbe meglio invece dimenticare il sapore che ti lasciavano in bocca le pessime sigarette che rubavo a mio padre. La scelta era fra le Africa e le Milit, meglio note a tutti come Merda italiana lavorata in tubetti. Sarà che non erano buonissime, sarà che fare gli ammericani era già un vezzo che ci permettevamo per darci delle arie, ma mi capitò spesso di barattare anche venti sigarette italiane con dieci Players Medium Navy Cut. Era indubbiamente uno scambio svantaggioso, però vuoi mettere la figura che ci facevo…
![]()
3
EL VINT DEL VUL DE LA VULADA
I miei genitori avevano faticato a riprendere il lavoro. Lo stabile del Mercato, con il suo ristorante e le sue quaranta stanze, era stato completamente requisito dall’Ufficio dell’Annonaria. Con la guerra la famiglia aveva in pratica perso la sua attività, e poiché i miei genitori non erano i proprietari dell’immobile, ma semplici concessionari, non potevano avanzare nessun diritto o fare recriminazioni. Toccò armarsi di molta pazienza e aspettare. Poco dopo il rientro fu concessa la disponibilità di un piano, poi un altro ancora, e dopo alcuni mesi i miei genitori ritornarono a lavorare a pieno ritmo.
Tutti ci riappropriammo della nostra vita: papà e mamma a lavorare al ristorante, io con gli amici a correre per le strade di Milano. Pur essendo un grandissimo lavoratore, c’era un posto per il quale mio padre avrebbe rinunciato volentieri al Mercato: il loggione della Scala. Amava così tanto la lirica e il melodramma che, se avesse potuto, avrebbe passato tutta la vita in quel luogo per non perdere una sola romanza o addirittura una sola parola di un libretto la cui esecuzione era vissuta con un trasporto eccezionale. Il giudizio che riservava agli artisti, che conosceva uno per uno, era esperto e severo. Faceva una distinzione tra tenori «di grazia» e tenori, diciamo così, «normali». Per lui un tenore di grazia era il conte di Almaviva quando, nel Barbiere di Siviglia, interpretava con intonazione quasi femminea la romanza «Ecco ridente in cielo / spunta la bella aurora / e tu non sorgi ancora / e puoi dormir così?». Ma il suo appr...