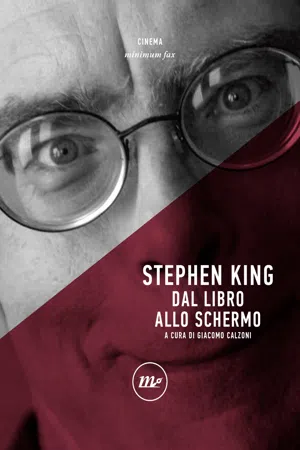![]()
2000-2020. STEPHEN KING TRA COMPLEX TV E PRESTIGE DRAMA, LA METÀ OSCURA DELL’ERA POST NETWORK
DI MATTEO BERARDINI
A metà strada tra fantascienza e ricerca scientifica vi è un concetto, quello di singolarità tecnologica, con cui scrittori e scienziati si riferiscono a quel momento della Storia nel quale il progresso raggiungerà caratteristiche e velocità tali da cambiare radicalmente ogni aspetto dell’esperienza umana. La singolarità prevede un prima e un dopo, un preciso punto dello spazio-tempo in cui convergono diverse linee di sviluppo, interlacciate tra loro e foriere di nuovi orizzonti. L’idea viene formalizzata negli anni Ottanta dallo scrittore e matematico Vernor Vinge, la cui proposta teorica si concentra soprattutto sull’impatto suscitato dall’intelligenza artificiale, nella cui crescita esponenziale viene individuato il fattore primario del cambiamento. Senza addentrarsi nelle maglie della futurologia, rubiamo il concetto di singolarità tecnologica e portiamolo qui, nel nostro presente, o meglio nel vicino passato degli anni a metà tra i Novanta e i Duemila, perché quest’idea di un radicale prima/dopo, di un evolversi contemporaneo di più fattori che nel loro sviluppo portano un determinato settore dell’esperienza umana a un cambiamento ontologico onnicomprensivo, ben si presta a descrivere quanto accade allo scenario televisivo e seriale contemporaneo, rivoluzionato nelle sue pratiche di creazione, finanziamento, produzione e impiego all’interno della nuova dimensione del consumo culturale. Everything, everytime, everywhere: sono queste le tre keyword dello sviluppo dell’industria culturale al tempo del tardocapitalismo, un nuovo orizzonte in cui il consumo si reinventa nei termini di immediatezza d’uso e abbondanza dell’offerta, trasformando il consumatore in abbonato, il possesso in accesso.
Ma andiamo con ordine. Questo saggio non si incentra sull’evoluzione della televisione e delle sue forme di narrazione seriale affermatesi nel nuovo millennio; tantomeno sul contesto culturale che è sia genesi che oggetto di tali innovazioni strutturali. Tuttavia, se è vero che «business e cultura sono all’opera contemporaneamente», non possiamo ricostruire e sondare la serialità kinghiana prodotta dalla tv americana degli anni Duemila senza collocare questo percorso all’interno della più generale epoca di trasformazione che l’intero apparato televisivo, anzitutto americano, sta vivendo da vent’anni a questa parte. Quello che va da The Dead Zone (2003-2009) a The Outsider (2020) non è un excursus temporale da sondare con spirito museale e prassi enciclopedica, men che meno un catalogo di titoli-monadi da isolare nella loro specificità testuale; piuttosto, quel che abbiamo di fronte è un particolare racconto di formazione che ha nel medium tv il suo protagonista, nelle innovazioni tecnologiche e industriali il suo motore narrativo e nell’universo kinghiano il suo orizzonte di crescita e sviluppo. Si tratterà quindi di far dialogare scrittura ed evoluzione televisiva, analisi letteraria e ricostruzione diacronica, scoprendo di volta in volta come un determinato racconto o romanzo viene adattato dalle griglie mediali di un dato momento storico. Ma ogni tragitto ha bisogno di mappa, bussola e binocolo; per questo tracceremo qui alcune coordinate generali che useremo come strumenti per orientarci nel corso del nostro viaggio.
La complessità strutturale cui è andata incontro la televisione dal finire degli anni Novanta in poi – e che ancora oggi è attiva ed esercita forze di innovazione dagli esiti non del tutto prevedibili – riguarda tutte le parti coinvolte, dal ruolo dello spettatore al lavoro dei creativi, dall’organizzazione finanziaria alla gestione produttiva, e ognuno di questi fattori ha ricadute concrete sull’esito finale. Fare televisione oggi, anzitutto negli Stati Uniti ma via via sempre più anche negli altri paesi e mercati, significa qualcosa di diverso rispetto ai primi anni Duemila, e tale scarto si farà evidente e sempre più significativo lungo la nostra storia, che prende piede proprio con l’avvio della nuova fase.
A proposito di fasi, dovendo inquadrare l’evoluzione del medium televisivo dentro una prospettiva cronologica, va notato in primo luogo come per molti studiosi la storia della televisione americana, e di riflesso della televisione occidentale, si possa dividere in tre epoche, a cui vengono date accezioni diverse in base ai singoli aspetti via via messi in evidenza. Tra i modelli più interessanti possiamo sicuramente citare quelli proposti da John Ellis, che si concentra sull’entità della ricezione suddividendo la storia sociale della tv in tre età: quella della scarsità (scarcity), quella della disponibilità (availability) e infine quella dell’abbondanza (plenty); da Rogers, Epstein e Reeves, che guardano in particolare al supporto tecnologico enfatizzandone le ricadute, e parlano quindi di network era, cable era e digital era; da Brett Martin, che invece recupera la canonica definizione di seconda Golden Age formulata da Robert Thompson e parla di terza Golden Age, sottolineando l’evoluzione tematica e lo spessore acquisito dalla scrittura seriale; una simile attenzione di tipo strutturalista ritorna quindi in Jason Mittell, che identifica la terza fase di questo sviluppo come l’era della complex tv, ovvero di una serialità dotata di complessità linguistica e testuale senza precedenti (e questo termine, complessità, sarà uno degli elementi chiave del nostro percorso).
Nel ripercorrere gli ultimi vent’anni di tv kinghiana faremo ricorso ad alcuni di questi modelli, guarderemo alle categorie testuali di prestige drama e tv complessa, ma il punto di riferimento principale sarà quello offerto da Amanda Lotz, che nel suo fondamentale Post Network parla di una «tv rivoluzionata» e propone una suddivisione storica che unisce prospettive industriali e culturali scandendo le tre fasi come era dei network, era multi-canale e appunto era post network. In particolare, tramite la Lotz, ci preme sottolineare un concetto: tutti gli aspetti che siamo abituati ad associare all’idea di televisione sono dovuti a caratteristiche tecnologiche, produttive ed economiche che sono storicamente determinate, e oggi che questi elementi sono in piena trasformazione non possiamo usare le loro forme precedenti per determinare cosa sia televisione e cosa no. Il fatto di guardare Castle Rock, uno show creato da un’entità over-the-top come Hulu, su tv, tablet o cellulare, usufruendo di possibilità impensabili fino a pochi anni fa, non cambia la natura televisiva dello show, e tuttavia – ed è il punto fondamentale – ha un impatto diretto tanto sulle caratteristiche testuali del prodotto quanto su quelle industriali, senza dimenticare le ricadute sullo spettatore dettate dalle nuove prassi e possibilità di consumo («l’onnipotenza della rete ha permesso ai fan di prendere parte a una forma di intelligenza collettiva che produce informazioni, interpretazioni e discussioni sulle serie più stimolanti», scrive Mittell, e questo è particolarmente vero per serie complesse come la Castle Rock prodotta da J.J. Abrams). Tali effetti sono la manifestazione concreta della rivoluzione televisiva che stiamo vivendo in questo momento storico.
Come dice la Lotz,
durante i primi anni di vita del mezzo si sviluppò una certa idea di cosa fosse la televisione, di cosa avrebbe potuto essere, un’idea che discendeva dalle specifiche pratiche industriali che ne hanno governato i processi produttivi per gran parte della sua storia. Le modifiche nei processi di produzione [...] hanno creato nuovi modi di usare la tv che ora mettono alla prova la comprensione di base del medium. Negli ultimi vent’anni i mutamenti in questo mezzo hanno forzato l’evoluzione dei processi produttivi, e le svariate modalità di fruizione televisiva esistenti oggi sono rispecchiate e rese possibili dagli enormi cambiamenti nel modo in cui la tv viene realizzata, finanziata e distribuita.
A quest’insieme di cambiamenti la Lotz dà quindi il nome di era post network, storicizzando una fase avviata da poco e ancora ampiamente in fieri ma di cui possiamo individuare il tema chiave: lo scardinamento dell’impianto generalista. La televisione americana infatti nasce mutuando le logiche industriali e comunicative dell’esperienza radiofonica, e assumendo pertanto una forma broadcasting caratterizzata dalla presenza asimmetrica di poche emittenti impegnate a comunicare a tutta la platea nazionale, la quale viene bersagliata con contenuti che siano il più possibile generici e popolari. L’era post network invece scaturisce proprio dall’indebolimento di questo paradigma; un’apertura di mercato iniziata negli anni Ottanta (la fase multicanale, nello schema della Lotz), resa possibile dall’esplodere della tecnologia via cavo e la cui logica industriale è adesso quella del cosiddetto narrowcasting, cioè una televisione differenziata e indirizzata a pubblici specifici, divisi per età, profilo sociodemografico e interessi. Si moltiplicano così i canali e gli show pensati per parlare con maggior efficacia a un numero minore di spettatori; si differenziano le produzioni; una nuova forma di tessuto seriale coltiva la fedeltà del pubblico e diventa più duttile, adattandosi a spettatori suddivisi in nicchie coinvolte in un rapporto diretto con l’emittente. È in quest’ottica che rientra lo slogan che meglio riassume lo spirito iniziale dell’era post network, quel «It’s not tv, it’s HBO» con cui la regina della cable television americana riassumeva dalla seconda metà degli anni Novanta le sue nuove ambizioni industriali, definendo la riconoscibilità del proprio brand (a HBO dobbiamo, a partire dall’esperimento di Oz e dai successi di Sex and the City e I Soprano, la prima grande innovazione seriale della terza Golden Age).
Non dimentichiamo però il monito della Lotz: «Business e cultura sono all’opera contemporaneamente», e quindi all’evolversi del sistema tecnologico-industriale corrispondono sinergicamente trasformazioni linguistiche. La serialità americana – e a seguire occidentale – dell’era post network fiorisce assorbendo gli stilemi stilistici e testuali del cinema, di cui mutua tecniche e ambizioni narrative; lievitano i budget e si inspessiscono le produzioni, mentre nuove modalità distributive permettono un ricorso più libero ai formati, al rapporto coi generi, alla complessità testuale. Lo spettatore diventa più consapevole della natura stratificata e mutevole di ciò che ha di fronte, sa di esserne destinatario privilegiato, in un dialogo sempre più serrato tra nicchie di pubblico e canali dall’identità specifica. La televisione diventa le televisioni, i canali diventano piattaforme dotate di archivi e flussi interattivi, l’impianto estetico e la scrittura si liberano dei limiti precedenti e lo spettatore risponde rilanciando il gioco della nuova frontiera dell’intrattenimento, la serialità post network.
A lungo la tv generalista americana ha cercato di trasformare Stephen King nel nuovo Rod Serling, un personaggio che non fosse solo creatore di un serbatoio infinito di racconti del fantastico ma anche presentatore televisivo di quelle stesse storie. Ideatore del rivoluzionario serial sci-fi Ai confini della realtà, Serling infatti non si limitava a scrivere gran parte degli episodi ma chiudeva ogni puntata anticipando il contenuto della successiva, in un rapporto diretto, affabulatorio e ironico con il suo pubblico basato anzitutto sulla riconoscibilità dell’autore, reso personaggio televisivo. Secondo diversi executives dei network americani, Stephen King era l’occasione d’oro per riportare agli anni Settanta e Ottanta quel tipo di narrazione seriale: un appuntamento spaventoso davanti al focolare catodico in cui a farla da padrona sarebbe stata la scrivania dello scrittore e il suo word processor. Peccato che proprio allo stesso periodo risalgano diverse interviste in cui il Re, senza peli sulla lingua, definiva la tv generalista «la tomba dell’horror». E come dargli torto? Una televisione incentrata sull’obiettivo di raggiungere quanti più spettatori possibile, disposta a sacrificare nella maggior parte dei casi ambizione, innovazione e coraggio per garantirsi numeri plenari e sponsor compiaciuti; una televisione chirurgicamente fedele alla censura e costretta a recuperare sequenze tagliate e coesione interna (priva di interruzioni pubblicitarie) solo nelle edizioni in VHS; una televisione attenta a evitare scandali, innocua, fedele al rassicurante orizzonte del già visto; una televisione del genere, che spazio poteva offrire all’orrore quotidiano, sotterraneo e privo di compromessi di Stephen King? Uno scrittore che già al cinema – in un medium sicuramente più libero nella gestione dei tempi narrativi e dei contenuti – trova per lo più adattamenti dal respiro evenemenziale, trasposizioni fedeli al soggetto di partenza, ai protagonisti, alle svolte di trama, all’interno delle quali però si perde la grande capacità del Re di restituire l’interiorità dei suoi personaggi, di costruire psicologie familiari e complesse messe alla prova da una routine che si svela densa di orrori.
King è scrittore subdolo e attento alle sue voci, ci inonda di dettagli ma intanto si avvicina alla gola del lettore come una fiera nella giungla, attraverso un io narrante o un discorso indiretto libero che preparano il terreno all’irrompere dell’irrazionale, del terrore e della follia. Come Richard Matheson, suo grande maestro in questa gestione quotidiana della suspense assieme a Ray Bradbury, King parte sempre dall’orizzonte del visibile e del conosciuto, ed è lì che innesca i suoi dispositivi, perché sa che per il lettore è proprio il punto di vista più familiare, quindi prevedibile e confortevole, il luogo ideale e più pericoloso per subire l’insorgere del macabro. Un tipo di scrittura simile, che fatica a trasformarsi in cinema (nonostante i suoi romanzi siano popolati di immagini, appunto concrete e quotidiane, estremamente vivide e potenti) cosa può trovare nella tv generalista degli anni Settanta, Ottanta e per molti aspetti ancora dei Novanta, se non la «tomba dell’horror»? Certo, non siamo di fronte a un paradigma e non mancano le eccezioni importanti (su tutte Le notti di Salem di Tobe Hooper per il network CBS) ma appare evidente come, a questo punto, il terreno ideale per una pratica di adattamento ad ampio spettro, non strettamente autoriale, fedele al testo originario e alle logiche di genere, possa essere proprio la televisione rivoluzionata dell’era post network. Libera dai precedenti limiti creativi e industriali, la serialità contemporanea è infatti l’industria culturale che offre le migliori condizioni per quest’esercizio di transcodificazione, sia dal punto di vista più generale della letteratura trasformata in miniserie (format estremamente efficace che ha dato e continuerà a dare i suoi frutti) sia dal punto di vista del singolo autore, Stephen King, molti dei cui romanzi si prestano effettivamente a rivivere all’interno di narrazioni audiovisive espanse, complesse, mature dal punto di vista visivo e libere di rivolgersi a specifici settori di pubblico. Raccontare la storia che va da The Dead Zone a The Outsider significa quindi ripercorrere il farsi atto, graduale e comunque affetto da tanti passi falsi, di questa potenza di racconto e visione, significa seguire una strada in cui la serialità acquista via via consapevolezza, capacità, coraggio, mentre il pubblico si fa con lei più attento, esigente, conscio di potersi finalmente immergere in un flusso audiovisivo che non sostituisce certo la bellezza originaria della prosa ma riesce a farne rivivere schegge in forme diverse.
1. The Dead Zone (2002-2007)
Quale dono Dio ti ha concesso, Johnny.
Tra i libri preferiti dallo stesso King, La zona morta (1979) è un romanzo che riveste un’importanza particolare nella carriera del Re. Anzitutto è il primo dei suoi lavori a scalare la classifica dei be...