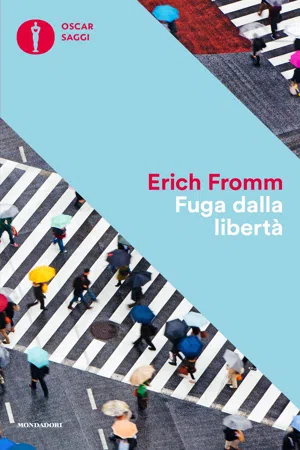
eBook - ePub
Fuga dalla libertà
Erich Fromm, Cesare Mannucci
This is a test
Compartir libro
- 272 páginas
- Italian
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Fuga dalla libertà
Erich Fromm, Cesare Mannucci
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
L'uomo di oggi ha raggiunto la libertà, ma non riesce a usarla per realizzare completamente se stesso; al contrario, proprio la libertà sembra averlo reso fragile e impotente. Applicata al totalitarismo fascista, la tesi di Fromm dimostra tutta la sua efficacia. Molti infatti, di fronte alle responsabilità che accompagnano il godimento della libertà, preferiscono fuggire verso le dittature o si chiudono nel conformismo della società di massa. Di contro a questa tendenza, Fuga dalla libertà indica la via per continuare nella realizzazione degli ideali di individualità e di pienezza umana.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cancelo mi suscripción?
¿Cómo descargo los libros?
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
¿En qué se diferencian los planes de precios?
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
¿Qué es Perlego?
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
¿Perlego ofrece la función de texto a voz?
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¿Es Fuga dalla libertà un PDF/ePUB en línea?
Sí, puedes acceder a Fuga dalla libertà de Erich Fromm, Cesare Mannucci en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Psychology y Personality in Psychology. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
PsychologyCategoría
Personality in Psychology1
Libertà: un problema psicologico?
La storia moderna europea e americana si incentra nello sforzo di conquistare la libertà dalle catene politiche, economiche e spirituali che hanno avvinto gli uomini. Le battaglie per la libertà sono state combattute dagli oppressi, da coloro che aspiravano a nuove libertà, contro quelli che avevano privilegi da difendere. Combattendo per la propria liberazione dalla tirannia, ogni classe credeva di combattere per la libertà in sé, e così poteva fare appello a un ideale, al desiderio di libertà radicato in tutti gli oppressi. Tuttavia, nella battaglia lunga e praticamente continua per la libertà, le classi che in un determinato momento storico combattevano contro l’oppressione si mettevano dalla parte dei nemici della libertà allorché la vittoria era assicurata e c’erano nuovi privilegi da difendere.
Nonostante i molti rovesci, la libertà ha vinto delle battaglie. In queste battaglie molti sono morti con la convinzione che morire nella lotta contro l’oppressione fosse meglio che vivere senza libertà. Una morte di questo genere era la suprema affermazione della loro individualità. La storia pareva dimostrare che l’uomo era in grado di governarsi, di prendere decisioni autonome e di pensare e sentire come meglio credeva. La piena espressione delle potenzialità dell’individuo sembrava essere la meta a cui si stava rapidamente avvicinando lo sviluppo sociale. I principi del liberalismo economico, della democrazia politica, dell’autonomia religiosa e dell’individualismo nella vita personale, esprimevano il desiderio di libertà e al tempo stesso sembravano avvicinare gli uomini alla sua realizzazione. Una dopo l’altra, le catene cadevano. L’uomo aveva rovesciato il dominio della natura diventandone il dominatore; aveva rovesciato il dominio della Chiesa e il dominio dello Stato assolutistico. L’abolizione del dominio esterno pareva la condizione necessaria e sufficiente per raggiungere la meta desiderata: la libertà dell’individuo.
La Grande Guerra fu considerata da molti l’ultima lotta e nella sua conclusione si vide la vittoria definitiva della libertà. Le vecchie democrazie apparivano rafforzate, e nuove democrazie sostituivano le vecchie monarchie. Ma erano passati solo pochi anni quando emersero nuovi sistemi che negavano tutto ciò che gli uomini credevano di aver conquistato in secoli di lotta. Infatti l’essenza di questi nuovi sistemi, che si impadronirono efficacemente dell’intera vita sociale e personale dell’individuo, era la sottomissione di tutti, salvo un pugno di uomini, a un’autorità sulla quale non avevano alcun controllo.
Dapprima molti si confortarono col pensiero che la vittoria del sistema autoritario era dovuta alla follia di pochi individui, e che questa loro follia li avrebbe condotti a tempo debito alla rovina. Altri ritenevano con sufficienza che il popolo italiano, o quello tedesco, non avessero avuto abbastanza tempo per educarsi alla democrazia, e che perciò si poteva attendere tranquillamente il momento in cui avrebbero raggiunto la maturità politica delle democrazie occidentali. Un’altra comune illusione, forse la più pericolosa di tutte, era la credenza che gli uomini come Hitler avessero conquistato il potere sull’immenso apparato statale soltanto con la furberia e l’inganno, che essi e i loro satelliti governassero in virtù della pura e semplice forza; che l’intera popolazione fosse solo l’oggetto privo di volontà del tradimento e del terrore. Durante gli anni trascorsi da allora fino a oggi, la fallacia di queste tesi è diventata manifesta. Siamo stati costretti a riconoscere che in Germania milioni di persone erano ansiose di cedere la loro libertà quanto i loro padri lo erano stati di combattere per conquistarla; che invece di volere la libertà, cercavano modi di evaderne; che altri milioni di persone erano indifferenti e non credevano che valesse la pena di combattere e morire per difendere la libertà. Riconosciamo inoltre che la crisi della democrazia non è problema peculiarmente italiano o tedesco, ma è problema di ogni Stato moderno. E non importa quali simboli scelgano i nemici della libertà umana: si può minacciarla attaccandola in nome del fascismo dichiarato1 come sotto la copertura dell’etichetta dell’antifascismo. Questa verità è stata formulata da John Dewey tanto bene che mi piace esprimere il pensiero con le sue parole: «La vera minaccia per la nostra democrazia» egli afferma «non è l’esistenza di Stati totalitari stranieri. È l’esistenza, nei nostri atteggiamenti personali e nelle nostre istituzioni, di condizioni che in paesi stranieri hanno dato la vittoria all’autorità esterna, alla disciplina, all’uniformità e alla sottomissione al Capo. E quindi il campo di battaglia è anche qui: in noi stessi e nelle nostre istituzioni».2
Se vogliamo combattere il fascismo dobbiamo comprenderlo: l’ottimismo non ci aiuterà. E la recitazione di formule ottimistiche si dimostrerà inadeguata e inutile come il rituale di una danza indiana della pioggia.
Oltre al problema delle condizioni economiche e sociali che aprirono la strada al fascismo, c’è un problema umano che dobbiamo comprendere. Scopo di questo libro è analizzare quei fattori dinamici della struttura di carattere dell’uomo moderno che nei paesi fascisti gli hanno fatto desiderare di rinunciare alla libertà, e che sono così diffusi anche nella nostra popolazione. Quando consideriamo l’aspetto umano della libertà, il desiderio di sottomissione e la brama di potere, sorgono impellenti queste domande: che cos’è la libertà come esperienza umana? Il desiderio della libertà è qualcosa di immanente alla natura umana? È un’esperienza identica, che prescinde dal tipo di civiltà in cui vive la persona, o è qualcosa che varia a seconda del grado di individualismo raggiunto da una particolare società? La libertà è solo l’assenza di pressioni esterne o è anche la presenza di qualcosa? E se è così, di che cosa? Quali sono nella società i fattori sociali ed economici che promuovono l’impegno a favore della libertà? La libertà può diventare un peso troppo pesante da portare, qualcosa da cui l’individuo cerchi di fuggire? E allora perché la libertà è per molti una meta preziosa e per altri una minaccia?
Non c’è anche, forse, oltre a un desiderio innato di libertà, un desiderio istintivo di sottomissione? E se non c’è, come possiamo spiegare l’attrazione che oggi ha per molti la sottomissione al capo? È sempre sottomissione a un’autorità manifesta, o c’è anche sottomissione ad autorità interiorizzate, come il dovere o la coscienza a costrizioni interne o ad autorità anonime come l’opinione pubblica? C’è una soddisfazione occulta nel sottomettersi, e qual è la sua essenza?
Che cos’è che crea negli uomini una brama insaziabile di potere? È la forza della loro energia vitale, o è una fondamentale debolezza e incapacità di vivere la vita spontaneamente e con amore? Quali sono le condizioni psicologiche che rafforzano questi impulsi? Quali sono le condizioni sociali su cui queste condizioni psicologiche a loro volta si fondano?
L’analisi dell’aspetto umano della libertà e dell’autoritarismo ci obbliga a considerare un problema generale, e precisamente quello del ruolo che i fattori psicologici svolgono come forze attive del processo sociale; e questo a sua volta porta al problema dell’interazione dei fattori psicologici, economici e ideologici nel processo sociale. Ogni tentativo di comprendere l’attrazione che il fascismo esercita su grandi nazioni ci costringe a riconoscere il ruolo dei fattori psicologici. Infatti ci occupiamo qui di un sistema politico che fondamentalmente non fa appello alle forze razionali dell’egoismo, ma che desta e mobilita nell’uomo forze diaboliche di cui non avevamo nemmeno sospettato l’esistenza o che perlomeno credevamo scomparse già molto tempo fa. Negli ultimi secoli l’immagine consueta dell’uomo era quella di un essere razionale, le cui azioni venivano determinate dall’interesse egoistico e dalla capacità di agire in conformità a esso. Anche gli scrittori come Hobbes, che vedevano nella brama di potere e nell’ostilità le forze motrici dell’uomo, spiegavano l’esistenza di queste forze come il logico risultato dell’egoismo: dato che gli uomini sono eguali e hanno perciò lo stesso desiderio di felicità, e dato che non c’è sufficiente ricchezza per soddisfarli tutti nella stessa misura, si combattono necessariamente a vicenda e vogliono il potere per assicurarsi il godimento futuro di quello che già hanno. Ma l’immagine di Hobbes apparve a un certo punto sorpassata. Come la classe media riuscì a spezzare il potere dei vecchi reggitori politici e religiosi, e gli uomini riuscirono a dominare la natura, e milioni di individui diventarono economicamente indipendenti, sempre più ci si persuase che il mondo era razionale e che l’uomo era fondamentalmente un essere razionale. Le forze oscure e diaboliche della natura umana venivano relegate nel Medioevo e in periodi ancora più remoti della storia, e venivano spiegate con l’ignoranza o con le abili macchinazioni di re e di preti ingannatori.
Si guardava a questi periodi come si può guardare a un vulcano che da molto tempo abbia cessato di costituire una minaccia. Ci si sentiva sicuri e fiduciosi che le conquiste della democrazia moderna avessero spazzato via tutte le forze sinistre; il mondo sembrava luminoso e sicuro come le strade bene illuminate di una città moderna. Si consideravano le guerre come le ultime reliquie dei tempi antichi e si pensava che bastasse una sola guerra per porre fine a tutte le guerre; si consideravano le crisi economiche come incidenti, anche se questi incidenti continuavano a ripetersi con una certa regolarità.
Quando il fascismo arrivò al potere, la maggior parte della gente era impreparata, sia teoricamente che praticamente. Non riusciva a credere che l’uomo potesse manifestare tali disposizioni al male, una tale brama di potere, un tale sprezzo per i diritti dei deboli, o una tale sete di sottomissione. Soltanto pochi avevano avvertito il rombo del vulcano che precede l’eruzione. Nietzsche aveva turbato il compiaciuto ottimismo del diciannovesimo secolo; e altrettanto aveva fatto Marx, in modo diverso. Un altro avvertimento era venuto qualche tempo dopo da Freud. Naturalmente questi, e la maggioranza dei suoi discepoli, aveva solo un’idea molto ingenua di ciò che avviene nella società, e quasi tutte le sue applicazioni della psicologia ai problemi sociali erano costruzioni fuorvianti; tuttavia, dedicando la sua attenzione ai fenomeni delle disfunzioni emotive e mentali degli individui, egli ci ha condotto alla cima del vulcano e ci ha fatto guardare nel cratere in ebollizione.
Freud si è spinto più avanti di tutti nel dirigere l’attenzione verso l’osservazione e l’analisi delle forze irrazionali e inconscie che determinano in parte il comportamento umano. Egli e i suoi seguaci della psicologia moderna non solo hanno scoperto il settore irrazionale e inconscio della natura umana, l’esistenza del quale era stata trascurata dal razionalismo moderno; ma hanno anche dimostrato che questi fenomeni irrazionali seguivano certe leggi e perciò potevano essere compresi razionalmente. Egli ci ha insegnato a capire il linguaggio dei sogni e dei sintomi fisici, nonché gli elementi irrazionali del comportamento umano. Egli ha scoperto che queste irrazionalità, così come l’intera struttura di carattere dell’individuo, erano reazioni alle influenze esercitate dal mondo esterno e particolarmente alle influenze subite nella prima infanzia.
Ma Freud era talmente imbevuto dello spirito della sua cultura che non riuscì ad andare al di là di certi limiti che essa gli poneva. Questi stessi limiti diventarono limitazioni anche ai fini della comprensione dell’individuo malato; e ostacolarono la sua comprensione dell’individuo normale e dei fenomeni irrazionali operanti nella vita sociale.
Dato che questo libro mette in rilievo il ruolo dei fattori psicologici nel processo sociale, e dato che questa analisi si fonda su alcune delle scoperte fondamentali di Freud – particolarmente su quelle concernenti il funzionamento delle forze inconscie nel carattere dell’uomo e la loro dipendenza da influenze esterne – penso che gioverà al lettore conoscere sin dall’inizio alcuni dei principi generali del nostro metodo, e anche le principali differenze tra questo metodo e i classici concetti freudiani.3
Freud accettava l’idea tradizionale di una fondamentale dicotomia tra l’uomo e la società, nonché la dottrina tradizionale della malvagità della natura umana. L’uomo, per lui, è fondamentalmente antisociale. La società deve addomesticarlo, deve consentire qualche soddisfazione diretta degli impulsi biologici, che in quanto tali sono inestirpabili; ma per la massima parte la società deve raffinare e abilmente frenare gli impulsi basilari dell’uomo. Per effetto di questa soppressione di impulsi naturali da parte della società accade qualcosa di miracoloso: gli impulsi soppressi si trasformano in aspirazioni culturalmente preziose e diventano la base umana della civiltà. Freud ha scelto la parola sublimazione per questa strana trasformazione della soppressione in comportamento civile. Se la soppressione è maggiore della capacità di sublimazione, gli individui diventano nevrotici ed è necessario consentire l’attenuazione della soppressione. In genere, però, c’è un rapporto inverso tra la soddisfazione degli impulsi umani e la civiltà; quanto maggiore è la soppressione, tanto maggiore la civiltà (e il pericolo di disturbi nevrotici). Nella teoria di Freud il rapporto tra l’individuo e la società è essenzialmente statico: l’individuo resta virtualmente lo stesso e si trasforma solo nella misura in cui la società esercita una pressione maggiore sui suoi impulsi naturali (e quindi lo costringe a una maggiore sublimazione) o consente una maggiore soddisfazione degli impulsi (e quindi sacrifica la civiltà).
Al pari dei cosiddetti istinti fondamentali dell’uomo postulati dagli psicologi precedenti, la concezione della natura umana di Freud rispecchiava fondamentalmente i più importanti impulsi riscontrabili nell’uomo moderno. Per Freud l’«uomo» era rappresentato dall’individuo della sua civiltà, e quelle passioni e ansietà che sono caratteristiche dell’uomo nella società moderna gli apparivano come forze eterne radicate nella costituzione biologica dell’uomo.
Potremmo dare molti esempi di ciò (come, ad esempio, la base sociale dell’ostilità diffusa negli uomini d’oggi, il complesso di Edipo, il cosiddetto complesso di castrazione nelle donne): ma vorrei dare solo un altro esempio, che è particolarmente importante perché riguarda l’intero concetto dell’uomo come essere sociale. Freud considera sempre l’individuo nei suoi rapporti con gli altri; tuttavia questi rapporti, come li vede Freud, somigliano ai rapporti economici con gli altri, caratteristici dell’individuo nella società capitalistica. Ogni persona lavora per se stessa, individualisticamente, a suo rischio, e non preminentemente in collaborazione con altre. Ma non è un Robinson Crusoe; ha bisogno degli altri, come clienti, come dipendenti o come datori di lavoro. Deve comprare e vendere, dare e prendere. Il mercato, sia esso di merci o di manodopera, regola questi rapporti. Così l’individuo, solo e autosufficiente, entra in rapporti economici con altri come mezzi per un fine solo: vendere e comprare. Il concetto freudiano dei rapporti umani è fondamentalmente lo stesso: l’individuo appare fornito di una serie completa di impulsi biologici prestabiliti, che richiedono d’esser soddisfatti. Per poterli soddisfare, l’individuo entra in rapporti con altri «oggetti». Perciò gli altri individui sono mezzi da usare per il nostro fine, la soddisfazione di aspirazioni che a loro volta hanno origine nell’individuo prima che questi entri in contatto con altri. Il campo dei rapporti umani nel senso di Freud assomiglia al mercato: è uno scambio di soddisfazioni di bisogni fisiologici, in cui il rapporto con l’altro individuo è sempre un mezzo a un fine e non è mai un fine in sé.
Al contrario, l’analisi esposta in questo libro si fonda sul presupposto che il problema-chiave della psicologia è quello dello specifico genere di rapporto che l’individuo ha col mondo, e non quello della soddisfazione o frustrazione di questo o quel bisogno istintivo per se stesso; inoltre sul presupposto che il rapporto fra l’uomo e la società non è statico. Non è che da una parte abbiamo un individuo dotato dalla natura di certi impulsi, e dall’altra una società in qualche modo separata da lui, che soddisfi o frustri queste tendenze innate. Pur essendoci bisogni comuni agli uomini, come la fame, la sete, il sesso, quegli impulsi che provocano le differenze nei caratteri degli individui, come l’amore e l’odio, la brama di potere e la sete di sottomissione, il godimento del piacere dei sensi e la paura dello stesso, sono tutti prodotti del processo sociale. Le inclinazioni più belle dell’uomo, come le più brutte, non fanno parte di una natura umana fissa e biologicamente prestabilita, ma derivano dal processo sociale che crea l’uomo. In altre parole, la società non ha soltanto una funzione soppressiva – pur avendo certamente anche questa – ma ha anche una funzione creativa. La natura dell’uomo, le sue passioni e ansietà, sono un prodotto della civiltà; anzi, l’uomo stesso è la più importante creazione e conquista dello sforzo continuo dell’umanità, la cui narrazione chiamiamo storia.
È proprio il compito della psicologia sociale comprendere questo processo della creazione dell’uomo nella storia. Perché da un’epoca storica a un’altra avvengono certi evidenti mutamenti nel carattere dell’uomo? Perché lo spirito del Rinascimento è diverso da quello del Medioevo? Perché la struttura del carattere dell’uomo nel capitalismo monopolistico è diversa da quella del diciannovesimo secolo? La psicologia sociale deve spiegare perché sorgono nuove capacità e nuove passioni, cattive o buone. Scopriamo quindi, ad esempio, che dal Rinascimento fino a oggi gli uomini sono stati mossi da un bruciante desiderio di fama, mentre nella società medioevale questa spinta, che oggi sembra così naturale, si manifestava poco.4 Nello stesso periodo gli uomini acquistarono un sentimento della bellezza della natura che prima non possedevano.5 E ancora, nei paesi dell’Europa settentrionale, l’uomo dal sedicesimo secolo in poi ha manifestato una voglia di lavorare che precedentemente mancava nell’uomo ...