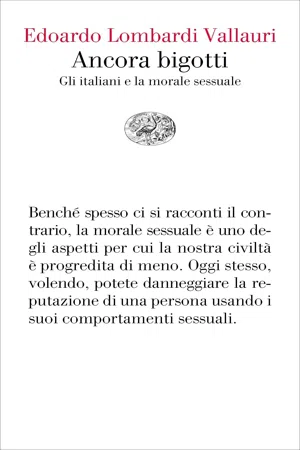Il ruolo della natura e quello dei sacerdoti.
Dal punto di vista della sopravvivenza della specie l’istinto di accoppiarsi con altri individui è ovviamente indispensabile, ma non è detto che sia sufficiente. Perché sia utile bisogna che il risultato dell’accoppiamento, cioè la prole, sopravviva. E perché sopravviva bisogna che i genitori se ne occupino. I genitori se ne occupano con molto piú impegno se sono certi che sia prole loro. Questo accade sempre per la madre, ma il padre, per essere sicuro che un figlio sia suo, deve avere un buon controllo sugli accoppiamenti della madre.
Come scrive Jared Diamond, uno dei fattori piú importanti che determinano il grado e i modi dell’attaccamento degli individui alla famiglia nelle specie animali è «la convinzione di essere effettivamente il padre […] dell’embrione o dell’uovo di cui si tratta», perché
se ti appresti a investire tempo, sforzo e alimenti per far crescere un uovo o un embrione fecondato, prima ti conviene essere maledettamente sicuro che è prole tua. […] I maschi cercano di fecondare le compagne degli altri maschi, lasciando che lo sfortunato cornuto si prenda cura della loro prole senza saperlo. Quindi hanno buone ragioni per diventare paranoici sul comportamento delle loro compagne. […] C’è il rischio che senza saperlo i loro sforzi trasmettano i geni di un rivale. Questo fatto biologico è la causa che soggiace a una serie di pratiche odiose con cui gli uomini di varie società hanno cercato di aumentare la loro certezza di paternità, riducendo le opportunità per la moglie di accedere a sesso con altri uomini2.
Ecco dunque il movente principale per l’enfasi che la nostra civiltà ha posto a piú riprese sulla «virtú» della donna, intesa tout court come totale assenza di vita sessuale, con l’eccezione delle pratiche necessarie ad assicurare eredi al suo unico uomo. Ed ecco dunque il motivo dell’attenzione maniacale con cui per gran parte della storia dell’Occidente si sono colpevolizzati perfino comportamenti che solo da lontano alludono a una possibilità sessuale, come sguardi, parole rivolte a uomini, momenti in cui una donna rimanga sola con un uomo, visibilità di caviglie, e cosí via: perché vietando ogni forma di vitalità e di libertà sessuale sul nascere, si riducono al minimo le probabilità che si arrivi a un atto completo. Gli scafandri di stoffa del mondo islamico sono l’equivalente.
L’evoluzione ha messo a punto una varietà di sistemi perché il maschio sia certo di essere il padre dei nuovi nati. Nei mammiferi3 è decisivo il meccanismo dell’estro, cioè il fatto che la femmina «va in calore» in un preciso periodo ciclico durante il quale è feconda e disponibile all’accoppiamento, mentre nel resto del tempo no. Per avvertire i maschi essa secerne feromoni di tipo sessuale che, percepiti olfattivamente, attivano il loro desiderio di accoppiarsi con lei. Ebbene, nei mammiferi non umani questa limitatezza nel tempo del periodo fecondo e la segnalazione al maschio di approfittarne, perché la femmina è disponibile all’atto sessuale solo in quel periodo, fanno sí che il maschio che coglie l’attimo per accoppiarsi con essa sia poi certo della propria paternità sulla prossima prole di quella femmina.
La nostra specie, però, a un certo punto della sua evoluzione perse l’estro4. Cioè, le donne divennero disponibili all’accoppiamento in qualsiasi momento del loro ciclo riproduttivo, e non vi fu piú alcun segno chiaro del loro trovarsi in un periodo fecondo o infecondo. In altre parole, uomini e donne cominciarono ad accoppiarsi in modo indipendente dalla condizione fertile o meno della donna. Da allora, ciò che anche noi percepiamo, al pari degli animali, come desiderio sessuale non è legato alla fecondità della femmina, ma è relativamente costante negli individui di entrambi i sessi. Ebbene, con la perdita dell’estro, in un gruppo di mammiferi umani che avessero assecondato liberamente e senza limitazioni il desiderio sessuale, diventava difficile essere certi della paternità della prole. Di conseguenza i maschi sarebbero diventati poco inclini a proteggere la crescita dei nuovi nati, non ritenendoli figli loro. A questo rischio pose rimedio quella forma di organizzazione sociale che è la monogamia, e piú in generale una serie di limiti all’esercizio dell’attività sessuale. Il divieto di accoppiarsi con individui diversi da uno solo e sempre lo stesso reintroduce la garanzia sulla paternità della prole. Insomma, la monogamia era piuttosto necessaria, e i gruppi umani l’hanno largamente adottata. Lo stesso effetto di certezza della paternità lo produce la poliginia (l’accoppiamento di un solo uomo con molte donne), che non a caso nelle società umane è molto piú diffusa della poliandria (l’accoppiamento di una sola donna con molti uomini), poiché quest’ultima non dà certezza del padre. Si ritiene inoltre che la molto maggiore diffusione della monogamia rispetto alla poliginia sia dovuta essenzialmente a cause economiche: non è facile che un singolo uomo possa provvedere a molte donne e alle loro proli.
A partire dalla seconda metà del XX secolo in questo quadro si è prodotto un cambiamento epocale, che lo altera in modo decisivo5: la diffusione generalizzata dei metodi contraccettivi, intesa sia come conoscenza dei meccanismi riproduttivi, che consente di avere comportamenti sessuali non fecondi, sia come insieme di metodi artificiali che limitano o quasi escludono la possibilità del concepimento. Questa fa sí che gli esseri umani contemporanei possano accoppiarsi senza riprodursi. Quindi è possibile ed è diventato comune assecondare il desiderio sessuale senza creare incertezza sulla paternità della prole che ne risulterebbe. Un individuo femmina può, oggettivamente, accoppiarsi con non importa quanti maschi senza che vengano al mondo «figli di nessuno».
Tuttavia le prime società umane, date le condizioni dette sopra, per garantire la cura e la protezione della prole da parte dei maschi, e quindi sopravvivere come popolazioni, dovevano dotarsi di una regolazione dei comportamenti sessuali. Lo hanno fatto sviluppando la morale sessuale, cioè un insieme di precetti che stabilivano il comportamento accettato degli individui e sottoponendo a sanzioni di varia natura chi li violava. All’interno delle comunità umane ci sono stati anche particolari individui che, piú degli altri, si sono incaricati di definire e far rispettare questi precetti.
Chi siano stati questi individui è dipeso dal progressivo strutturarsi dei gruppi sociali. Finché la specie ha vissuto di caccia e raccolta, il lavoro di una giornata bastava a malapena a sfamarsi. Quindi tutti gli individui lavoravano concretamente per non morire di fame, come gli animali selvatici. Poi siamo usciti dal Pleistocene, abbiamo iniziato ad allevare animali e a coltivare la terra. Il cibo prodotto ha cominciato a essere piú abbondante del fabbisogno di chi lo produceva, che quindi ha iniziato ad avere tempo e forze da dedicare ad altro. Si sono sviluppate attività produttive non di cibo, ma di altri beni. Alcuni individui si sono messi a fabbricare abiti, suppellettili, armi, che barattavano col cibo prodotto dagli altri. Cioè, nuovi tipi di beni e di ricchezze si sono resi disponibili su scala maggiore. La specializzazione è andata avanti: oltre a chi produceva cibo e a chi fabbricava oggetti, alcuni si sono dedicati a quel particolare tipo di servizio che è il trasporto e commercio dei beni prodotti. Altri all’attività militare, finalizzata alla difesa o all’espansione della comunità. Alcuni si sono specializzati nel comandare, cioè nel prendere decisioni per l’intera collettività, e altri nella gestione del soprannaturale e della morale.
Uno dei servizi principali erogati da questi ultimi, cioè dalla compagine sacerdotale, è stato appunto quello di emanare regole utili all’ordine sociale. Per farle rispettare il sistema piú comune è stato promettere ai trasgressori punizioni nell’aldilà, attribuendo la natura delle regole morali a una specifica preferenza della divinità per alcuni comportamenti rispetto ad altri. In cambio di questo servizio i sacerdoti si sono ritrovati depositari del potere di condannare e di assolvere che, se ben gestito, rappresenta una buona fonte di sostentamento. Infatti la comunità e i singoli devolvono volentieri una parte della loro ricchezza a chi sembra costituire la fonte delle istruzioni per garantirsi un migliore destino perenne; tanto piú se si presenta anche come intermediario privilegiato per dialogare con le forze soprannaturali da cui questo destino dipende. In particolare il senso di colpa, e quindi il timore di essere in qualche modo sfavoriti presso il dio o addirittura dannati, può rendere gli uomini inclini a trattare molto bene coloro che promettono di porvi rimedio. Un modo efficace per indurre il senso di colpa in quasi tutti gli individui di una comunità è emanare proibizioni che riguardino le pulsioni elementari, cioè quelle che tutti hanno e a cui è difficile resistere: infatti quasi tutte le religioni sono caratterizzate da divieti sull’alimentazione e sul sesso.
Nel corso della storia le proibizioni sessuali hanno assunto forme anche molto diverse a seconda delle diverse religioni storiche. Per esempio, nel cristianesimo la colpevolizzazione del sesso ha ricevuto una spinta importante dall’insegnamento di san Paolo, che (semplificando molto) ha accresciuto in questa religione di origine ebraica la svalutazione del corpo rispetto allo spirito, sposandola a quella che era nata nel mondo greco a partire dalla filosofia di Platone6. Nel pensiero cristiano il divario di dignità fra l’anima e il corpo ha raggiunto livelli estremi, che hanno condizionato e continuano a condizionare pesantemente il nostro sistema di valori. Un altro passaggio importante nella storia della sessuofobia cristiana è stato l’insegnamento di sant’Agostino, uomo prima appassionato di sesso e poi suo energico nemico. E certamente vi ha contribuito molto la civiltà monastica medievale, che per secoli mantenne il quasi monopolio della cultura e dell’influenza sulle coscienze fra mura chiuse abitate da celibi che avevano fatto voto di castità. In ogni caso, al di là delle concrete strade che tutto questo ha preso via via nella storia7, ogni insegnamento atto a colpevolizzare il sesso aveva nella Chiesa alte probabilità di prevalere su insegnamenti piú libertari, anche perché aumentava i mezzi a disposizione del clero per influire sulle persone attraverso il senso di colpa, la minaccia della dannazione, la correzione e la promessa della salvezza mediante il perdono offerto dai sacerdoti stessi.
Si potrebbe pensare che con l’avvento della contraccezione molte proibizioni sessuali, in quanto legate alla monogamia come mezzo per garantire la certezza della paternità, abbiano perduto il loro senso, e che quindi le persone non abbiano piú motivo di subirle; tanto piú che l’organizzazione economico-sociale nella nostra civiltà ha portato alla scelta, praticamente generalizzata, di restringere il numero dei figli – e quindi degli accoppiamenti fertili – a un numero molto limitato per ciascuna donna, a differenza di quanto avveniva per le nostre progenitrici primitive. Insomma, la nostra società gode da tempo delle premesse necessarie per abbandonare le proibizioni sessuali che erano utili in passato.
Di fatto oggi molti, dichiarandosi consapevoli che la morale del passato non ha piú senso, sostengono di «non dare piú retta ai preti» quando si tratta di sesso; e certamente ritengono di non dargli retta. Ma vedremo tra poche pagine quanto tutti noi gli diamo ancora retta senza saperlo, cioè quante delle regole di comportamento che non mettiamo in discussione hanno come fonte le proibizioni della religione. Molti poi pensano, almeno in questo paese, che sia stata la Chiesa stessa ad attenuare le sue posizioni in materia di sesso. Sarà dunque utile elencare qui rapidamente alcuni dei punti del Catechismo della Chiesa Cattolica che papa Wojtyła ha voluto pubblicare in versione aggiornata e adattata alla modernità nel 19928, da allora ristampato e ripubblicato per iniziativa sua e poi sempre ristampato sotto i papi successivi. Nel capitolo sul Sesto Comandamento (Parte III, sez. II, cap. II, art. VI), si trovano fra le altre cose la seguente idea e prescrizione sulla castità (il numero indica che si tratta del 2348esimo articolo del Catechismo):
II. LA VOCAZIONE ALLA CASTITÀ.
2348 Ogni battezzato è chiamato alla castità. Il cristiano si è «rivestito di Cristo» (Galati 3,27), modello di ogni castità. Tutti i credenti in Cristo sono chiamati a condurre una vita casta secondo il loro particolare stato di vita. Al momento del Battesimo il cristiano si è impegnato a vivere la sua affettività nella castità.
Sempre nella sezione intitolata La vocazione alla castità, per capire che cosa questa sia, si possono leggere alcuni degli articoli che riguardano le sue violazioni. Torneremo tra poco sul fatto che espressioni come «gravemente disordinato», «colpa grave» e insomma ogni apparizione dell’aggettivo «grave» sono i termini attuali per quello che una volta si chiamava «peccato mortale», e che secondo l’insegnamento della Chiesa continua a mandare all’inferno. Le violazioni della castità sono cose come il desiderio sessuale, la masturbazione, il fare sesso con un non-coniuge, la pornografia, la prostituzione e lo stupro.
LE OFFESE ALLA CAST...