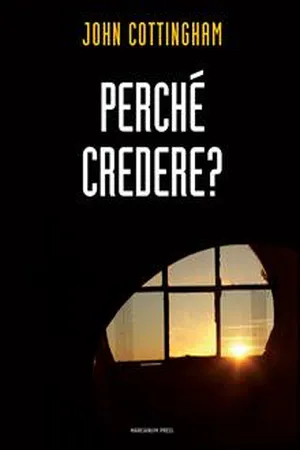
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Perché credere?
Informazioni su questo libro
In questo libro John Cottingham fa vedere che ogni essere umano possiede impulsi e aspirazioni che il credo religioso può adeguatamente soddisfare, implicando un impegno della persona nell'integrità della sua vita emozionale, intellettuale e pratica.
Uno studio dei fenomeni della vita religiosa rigorosamente argomentato, ma accessibile a tutti, in cui l'autore mostra, in modo convincente, come il credere non sia affatto in conflitto con la comprensione scientifica del mondo.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
CAPITOLO 1
LA FEDE E I SUOI BENEFICI
La parola di vita viene offerta a un uomo ed egli ha fede in essa. Perché?… Perché l’uomo ama la vita e il suo amore è forte anche se la testimonianza è debole.
John Henry Newman1
1. Come la fede influenza la nostra vita
In qualità di partecipante ad una trasmissione televisiva intitolata Il Genio di Charles Darwin, l’illustre biologo e ateo militante Richard Dawkins fu ripreso mentre portava un gruppo di ragazzi della scuola secondaria su una spiaggia a Dorset dove erano stati trovati dei fossili che supportavano la teoria di Darwin sull’evoluzione della specie. Dopo avergli mostrato l’evidenza, si voltò verso di loro con fare trionfante e disse: «Ecco qua! Ora credete ancora in Dio?». La maggior parte di loro era troppo rispettosa per sfidarlo direttamente, ma alcuni insistevano che avrebbero continuato a pregare.2 L’ipotesi di Dawkin sembrava essere che le loro credenze religiose fossero il risultato di una accettazione irriflessiva di ciò che avevano assorbito nella loro prima infanzia, cioè un ingenuo racconto sovrannaturale di come si era sviluppata la vita sulla terra. Ma gli studenti, dotati di maggior discernimento del loro eminente inquisitore, non sembravano avvertire che la loro dedizione religiosa resistesse o cadesse di fronte alla verità o meno della teoria darwiniana. Pregare era, dichiaratamente, qualcosa che gli era stato insegnato nei primi anni di vita, ma era qualcosa di cui, diventando giovani adulti, molti di loro sentivano ancora come un forte bisogno. E, né le domande scientifiche sollevate da Darwin riguardo allo sviluppo della vita, né il fatto indubitabile del genio scientifico di Darwin, sembrava scuoterli dai loro principi.
Ci sono fondamenti (che Dawkins, a suo merito, altrove riconosce)3 per dire che gli impulsi religiosi – alla preghiera e al culto, per esempio – sono profondamente radicati nella vita della nostra specie. Per qualche ragione, la maggior parte degli esseri umani nel corso della nostra storia fino ad oggi, ha sentito una forte attrazione verso queste attività. Gli uomini sentono il bisogno di condurre le loro vite nella fede, nella speranza e nella fiducia. Naturalmente la fiducia può qualche volta essere malriposta. Ma gli esseri umani non si trovano nella posizione di giudici eminenti che siedono sui loro troni e che sono capaci di garantire la rettitudine di ogni nostra azione e di ogni nostro impegno. Noi siamo, al contrario, esseri dipendenti, “animali razionali dipendenti”, per citare Alasdair MacIntyre,4 intrappolati in un complicato legame di richieste e circostanze che non abbiamo creato e che, ci piaccia o no, determinano le condizioni secondo le quali noi dobbiamo condurre le nostre vite. C’è molto, persino nella nostra esistenza ordinaria, quotidiana, in cui dobbiamo confidare; altrimenti saremmo paralizzati dall’indecisione, incapaci di raggiungere ogni tipo di progresso nei nostri progetti e piani ordinari.
Quel senso di dipendenza è sicuramente uno dei segni distintivi della nostra natura umana. Poiché il nostro potere di controllare l’ambiente, e persino il funzionamento dei nostri stessi corpi, è incredibilmente aumentato con il progredire della scienza moderna, possiamo tendere a ignorare o mascherare la dipendenza pervasiva della condizione umana. Inoltre, possiamo perfino indulgere nel sogno dell’autonomia e della auto-sufficienza, pensando che abbiamo in qualche modo il completo “dominio” sulla realtà, o che possiamo totalmente controllare le condizioni per la nostra realizzazione. A qualcuno potrebbe sembrare che non c’è nulla di sbagliato in questo; ma l’autonomia, di fatto, può significare due cose: una di grande valore, l’altra fortemente discutibile. Noi certamente possiamo e dovremmo avere l’obiettivo di condurre le nostre vite senza la minaccia dell’interferenza o dell’oppressione, sia della tirannia esterna che proviene dal dominio politico ingiustificato, sia della tirannia interna che proviene dai desideri confusi e disordinati, o dalla mancanza di maturità e consapevolezza di sé. Desiderare di essere liberi da tutto questo significa aspirare ad un’autonomia legittima e benefica. Ma c’è una seconda, più sospetta idea di autonomia che implica la fantasia per cui in qualche modo possiamo creare i nostri valori personali grazie a un atto di volontà divino – come se la vita fosse una “tabula rasa” sulla quale possiamo scrivere ogni agenda che scegliamo. Friedrich Nietzsche, proclamando la “morte di Dio”, aveva in mente un “nuovo filosofo” con uno spirito «forte abbastanza per rivalutare e invertire i valori eterni».5 Ma tale nozione sembra dare adito ad una confusione radicale. Non posso far sì che qualcosa di valore, semplicemente perché la scelgo o la voglio (come se potessi rendere nutriente il carbone semplicemente decidendo di mangiarlo); in più questa idea mette il carro davanti ai buoi poiché, in verità, le mie scelte o le azioni della volontà possono essere considerate degne di valore solamente nella misura in cui i loro oggetti hanno già un valore indipendente.
Che ci sia o meno un Dio, gli esseri umani non si creano da soli, forse è un’ovvia ma comunque salutare verità.6 Siamo il prodotto di un’affascinante (forse persino misterioso) schieramento di cause che operano da molto tempo prima che noi venissimo in scena e continueranno ad operare per molto tempo dopo che ce ne saremo andati. Già questo basta a produrre un senso di vertigine, di stupore quando contempliamo la nostra fragilità e sembriamo insignificanti di fronte allo sfondo infinito di spazio e tempo – «l’eterno silenzio di quegli infiniti spazi» che terrorizzava Pascal.7 Allo stesso modo è difficile accettare, come fecero gli esistenzialisti del ventesimo secolo, che le nostre vite sono assurde o che siamo liberi di inventare tutti i valori che scegliamo; forse la maggior parte degli esseri umani sono attirati in una direzione opposta. Nella nostra lotta per la vita, sembra che siamo obbligati a riconoscere, presto o tardi, che la nostra bontà umana, il nostro fiorire e la nostra realizzazione dipendono dall’orientare noi stessi verso valori che non abbiamo creato. L’amore, la compassione, la pietà, la verità, la giustizia, il coraggio, la sopportazione, la fedeltà, appartengono al nucleo delle virtù chiave che tutte le grandi religioni del mondo (e le culture secolari che ne sono derivate) riconoscono e che suscitano la nostra adesione religiosa, che ci piaccia o no. Possiamo provare ad andare contro di esse, vivere le nostre vite senza fare riferimento ad esse, ma questi sforzi sono sempre alla fine controproducenti e causa di miseria e frustrazione piuttosto che di umana prosperità.
Questi fatti sono già, se pensiamo ad essi, molto evidenti ed importanti. Siamo creature dipendenti e vulnerabili che hanno bisogno, per la loro realizzazione, di orientarsi verso valori certi e duraturi. Se riflettiamo su questo punto e lo leghiamo alla consapevolezza del fatto ovvio della nostra debolezza e alla notoria difficoltà dell’esperienza umana nel perseguire con fermezza il bene al quale aspira, allora si è colpiti dalla misura in cui la fede religiosa offre un rifugio per le nostre aspirazioni. Il teismo, nella sua forma tradizionale che si trova nelle tre grandi fedi abramitiche, riguarda l’idea della lotta tra le nostre aspirazioni e il nostro destino ultimo. In questo quadro, il potere creativo che in definitiva ci ha formato è esso stesso la fonte dei valori che ci troviamo a dover riconoscere e ha fatto la nostra natura in modo tale che noi possiamo trovare piena realizzazione soltanto nel ricercare questi valori. Con le parole più citate di sant’Agostino potremmo dire: «Ci hai fatti per te e il nostro cuore non si darà pace finché non troverà riposo in te».8 La reazione naturale a questo pensiero – per cui riconosciamo con gioia quella forza creativa di bontà e ci rivolgiamo ad essa per ricavare la forza nella nostra battaglia – è così basilare che si presenta essa stessa al credente come un modo fondamentale e necessario di affrontare la vita. Non è una questione di ipotesi scientifiche circa i precisi meccanismi micro o macro che hanno dato vita al nostro pianeta o alle nostre specie, ma piuttosto un impulso necessario alla fiducia, qualcosa che, come William Wordsworth aveva espresso nella sua poesia, ha origine dai momenti di vivida consapevolezza della bellezza e della bontà del mondo e del nostro posto in esso. È un impulso così profondo che sentiamo che né una speculazione intellettuale astratta, né il lavoro duro o il dolore della nostra ordinaria esistenza,
prevarrà contro di noi, o disturberà la nostra fede incrollabile
che tutto ciò che scorgiamo è pieno di benedizioni.9
Pochi hanno avuto sostenitori più eloquenti dei benefici che può dare la fede: il senso di sollevamento verso un’apertura alla bellezza e alla bontà e la fiducia che le nostre migliori e più profonde aspirazioni nella vita non stanno agitandosi arbitrariamente nell’oscurità, ma sono parte della ricerca di «Dio, che è la nostra casa».10 Descrivere Dio come la nostra “casa” significa concepire Lui come la forza ultima dalla quale abbiamo origine e il punto di ritorno verso il quale la nostra inquietudine ci conduce – la meta finale dove si trova la nostra vera pace. Naturalmente, la fredda luce della ragione può obbligarci a voltare le spalle a tutto ciò – e questo è un problema che non abbiamo ancora iniziato a considerare. Ma abbiamo bisogno di essere consapevoli di ciò che rifiuteremmo.
2. In che modo funziona la fede
Nei momenti di crisi personale – malattia, lutto, ansietà acuta –, qualche volta si sente la gente proferire frasi del tipo “Vorrei poter credere in Dio”. Dicendo ciò, il non credente sta implicitamente riconoscendo che la fede religiosa potrebbe apportare alcuni benefici – conforto, forse, o consolazione, o un senso di sicurezza o di speranza. Ma dire “vorrei poter” logicamente implica “ma sfortunatamente non posso”. Ci possono essere benefici; i benefici possono persino essere facilmente riconosciuti; ma questo non è abbastanza per convertire un non credente in un credente.
Qualche volta, pensare ai benefici derivanti dal fare qualcosa è proprio ciò che basta per spingere le persone in una certa direzione. Perché dovrei andare in vacanza? Perché sei affaticato e hai bisogno di tempo per rilassarti. Perché andare in palestra? Perché l’esercizio fa bene alla salute e ti farà stare meglio. Concentrarsi sui benefici può essere, e spesso è, persuasivo nel far cambiare opinione a qualcuno. Ma la fede religiosa, per quanto rechi giovamento al credente, non sembra funzionare in questo modo. Posso prenotare una vacanza sollevando il telefono. Posso iscrivermi in palestra cliccando su internet. Ma non posso, pare, decidere di essere credente allo stesso modo.
Perché no? Ci sono molti esempi di credenze che non sono in grado di formare con la volontà, per quanto potrei volerlo.11 Quando sollevo la tazza del tè verde sulla scrivania e mi accorgo che è diventata fredda, non posso decidere di credere che è ancora calda. Una volta che sorseggio spiacevolmente il liquido freddo, la credenza che è diventato freddo si forma automaticamente da sé nella mia mente – per quanto mi piacerebbe credere che sia ancora calda, per quanto piacevole potrebbe essere per me pensare che io non mi debba alzare e mettere di nuovo a scaldare il bollitore. Credere, di solito, sembra essere qualcosa che accade involontariamente, come arrossire o contrarre le pupille. Supponiamo che qualcuno mi offra centinaia di sterline per arrossire entro cinque secondi, o trasporto gratuito a vita se potessi contrarre le pupille. Per quanto grandi siano i benefici, potrei essere costretto a dire: «Spiacente, proprio non lo posso fare».
Ma riflettendoci, potrei trovare un modo per arrossire. Non sarò in grado di farlo a comando, ma potrei adottare una tecnica indiretta – per esempio pensare a un episodio particolarmente imbarazzante e umiliante della mia vita. Questo potrebbe farmi arrossire e poi potrei reclamare il denaro. In questo modo, anche se arrossire è, in se stesso, un atto involontario, può essere indirettamente portato sotto controllo volontario. E allo stesso modo funziona con la contrazione delle pupille degli occhi. Come ogni studente di medicina sa, questo è un riflesso assolutamente involontario; così non posso decidere di far sì che questo avvenga spontaneamente. Ma posso farlo accadere, per esempio, girando la testa e guardando una luce abbagliante.
Blaise Pascal, eminente matematico e scienziato e anche devoto cristiano, osservò nel diciassettesimo secolo che c’erano modi indiretti per portare qualcuno a diventare un credente. Suggeriva, per esempio, che andare regolarmente a messa poteva sortire l’effetto desiderato. Stava sostenendo un tipo di auto-manipolazione o auto-ipnosi? Non penso. Secondo Pascal diventare credente è in parte una questione emotiva, non intellettuale. «Devi renderti conto» disse, «che la tua incapacità di credere deriva dalle tue passioni».12 Impegnarsi in certe azioni di devozione (cantare inni, recitare salmi, direzionare i propri pensieri verso cose alte) potrebbe avere l’effetto di alleggerire il cuore, cambiare i propri sentimenti ed aprire possibilità che finora ci sembravano precluse. Così, sebbene uno potrebbe non essere capace di diventare credente a comando, potrebbe essere possibile adottare una strategia indiretta, come iniziare a frequentare i servizi religiosi, quindi intraprendere una condotta che potrebbe portare, alla fine del cammino, a credere o ad aver fede. E se veramente ci sono grandi benefici nell’essere credente, allora perché non andare avanti e provarci? Con le parole di Pascal, «Cos’hai da perdere?».
A questo punto, alcune qualcuno potrebbe sentirsi offeso dal modo in cui si sta conducendo la discussione. Ci siamo imbarcati in un dibattito sul fatto se sia possibile diventare credenti con lo scopo di guadagnare dei benefici. Ma anche se questi benefici esistono (cosa che molti potrebbero mettere in discussione) non c’è qualcosa di sbagliato riguardo all’idea di cercare i vantaggi del credere in qualcosa? Una fede può essere molto tranquillizzante, confortante, rassicurante, persino può far bene alla salute, ma di sicuro non è questo ciò che la rende vera. Paragona la domanda “Perché credere in Dio?” con domande del tipo “Perché credere che c’è una vita in altri pianeti?”, “Perché credere che il cibo nel tuo piatto è sano?”. Nel porre queste ultime domande non stiamo chiaramente chiedendo se potrebbe essere piacevole o di conforto, o conveniente o rassicurante credere in queste cose, ma se sono vere. E allo stesso modo, nel caso religioso, si potrebbe obiettare che non dovremmo stare a parlare dei benefici del credere, ma dell’evidenza o della giustificazione per credere.
Non voglio mettere da parte il problema della verità e dell’evidenza – sarà infatti un argomento centrale nel resto di questo capitolo e nei capitoli seguenti. Ma non penso che dovremmo accantonare del tutto la questione dei benefici. Ci sono molte cose della mia vita che mi tengo strette perché ne ho bisogno: perché la mia vita cadrebbe a pezzi se cessassi di avere fiducia in esse. Per andare al lavoro ho bisogno di credere che la mia automobile non scoppierà nel momento in cui la accenderò, anche se non ho eseguito un controllo di sicurezza accurato sull’impianto elettrico. Per impegnarmi nelle ordinarie attività quotidiane della vita, come mangiare, ho bisogno di avere fiducia nel ...
Indice dei contenuti
- Perché credere?
- Titolo
- Copyright
- Indice
- Prefazione
- Ringraziamenti
- 1. La fede e i suoi benefici
- 2. Fede, Ragione, Bontà
- 3. Fede e ignoto
- 4. Ostacoli alla fede
- 5. Fede e significato
- 6. Fede e significato
- 7. Credere e vivere
- Bibliografia
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Perché credere? di John Cottingham in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teología y religión e Religión. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.