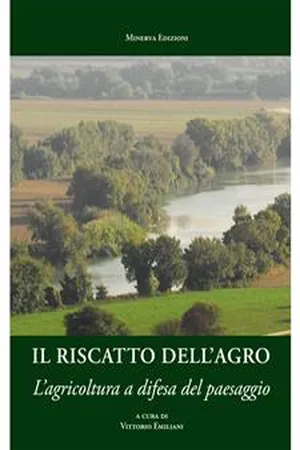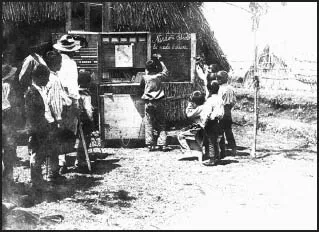![]()
INTRODUZIONE
Vittorio Emiliani
Un secolo fa, poco più di un soffio nella storia plurimillenaria di Roma, le decine di migliaia di ettari che componevano l’Agro romano sconfinando poi nella più vasta, ma non molto dissimile, Campagna romana, formavano ancora una pianura “calva e squallida, senza paesi né case, interrotta da lugubri stagni, solcata da rivoli morti” dalla quale tuttavia saliva “una poesia dolorosa”. Parole amare di uno scrittore visionario, Alfredo Oriani, romagnolo di Faenza (1852-1909), vergate già dentro al Novecento, al quale parevano “illusioni” (è infatti il titolo dello scritto) i pur generosi dibattiti sul riscatto di quel territorio al fine di farne “una campagna florida, ondeggiante di messi e di alberi, sparsa di case e di paesi, solcata da canali e da strade”.
Un paesaggio dunque, quello descritto nel 1903 da Oriani, che nulla, o quasi, aveva (o riaveva) di agrario e che riecheggiava le sconsolate immagini dell’unico fra i 2.279 sonetti dedicato da Giuseppe Gioacchino Belli (1791-1863) all’Agro, dal titolo eloquente, “Er deserto” (1). Datato 1836, nelle ultime due strofe così riassume il sentimento di paura col quale, dentro le mura, era vissuta dai romani quella silenziosa e mortifera pianura “calva”:
“Dove te vorti una campagna rasa
come ce sii passata la pianozza
senza manco l’impronta d’una casa
L’unica cosa sola c’ho trovato
in tutt’er viaggio, è stata una barrozza
col barrozzaro giù morto ammazzato”.
Un’immagine di orrida decomposizione, di derelitto abbandono che sempre accompagna l’Agro romano. Anche quasi mezzo secolo dopo, in Cesare Pascarella (1858-1940), “Er morto de campagna” (1881): “Le cornacchie e li farchi da per aria/Veniveno a beccàjese la faccia”. Povera salma riportata in città “co’ le torcie a vento/ pe’ la macchia, cantanno er Miserere”. Anche se queste desolate immagini erano mitigate, appena fuori però della Città Eterna, da paesaggi silenti, popolati soltanto da greggi di pecore e da isolati pastori nomadi, sullo sfondo dei solenni acquedotti romani. Le “vedute romane” alle quali si era applicato, fra gli altri, con successo, attorno al 1820, un futuro uomo di governo del Regno di Sardegna, quel Massimo Taparelli dei marchesi D’Azeglio (1798-1866), buon pittore, sceso a Roma ventenne per studiare e praticare le “belle arti” prima di venire richiamato al dovere di “fare l’Italia” per poi cercare di “fare gli italiani”.
Anche in Europa, dopo che Roma era diventata la capitale dell’Italia unita, la redenzione agricola di quella desolata landa veniva percepita come uno dei problemi primari che il nuovo regno si trovava di fronte. “Maestà, il miglior modo di giustificare la presenza del vostro governo in Roma è quello di portare la fecondità e la salute dove era la sterilità e la morte”. Così si era rivolto l’imperatore Guglielmo di Germania a Vittorio Emanuele II nel 1875. Tanto erano allegre e festose le immagini - dai quadri alle stampe colorate, per esempio di Antoine Jean-Baptiste Thomas di “Un’année à Rome” - dedicate alle colline dei Castelli e alle sue operose stagioni, quanto invece erano rare e sconsolate quelle della “mala aria” che infestava il paesaggio nudo della campagna romana.“Da straziare il cuore di un filantropo, e da umiliare più specialmente un italiano”. Così annotava lo scienziato e patriota bolognese Giuseppe Bertelli alias Quirico Filopanti accorso a difendere la Repubblica Romana del ’49, il quale, più tardi, non aveva mai avuto la meritata cattedra di matematica per il suo inattaccabile rifiuto di giurare fedeltà al re. Una scommessa, dunque, sociale e politica. Che la nuova classe dirigente risorgimentale si era probabilmente illusa di vincere rapidamente (col liberale Quintino Sella, vero regista operativo della “Terza Roma”) e che invece dovette grandemente dilazionare nel tempo anche per i più immediati e disastrosi problemi urbani ed extra-urbani creati dalla gigantesca alluvione del Tevere dell’autunno 1870 e da quelle seguenti.
Uno dei primi provvedimenti che dovette prendere la Giunta comunale provvisoria appena insediata dopo lo storico 20 settembre 1870 fu quello, doloroso, di impedire che centinaia di braccianti continuassero a dormire sulle scalinate del Campidoglio in attesa, la mattina dopo, all’alba, del possibile reclutamento al mercato delle braccia di piazza Montanara, lì sotto, all’ingresso di Campitelli, a lato dell’ormai ex Ghetto. Nessuno, infatti, o quasi rimaneva per la notte nella campagna “calva”. Tranne i pastori nomadi, per lo più abruzzesi, nomadi e transumanti, ormai assuefatti alla malaria. Essi, peraltro, andavano verso il mare Tirreno a svernare, nei mesi cioè nei quali la zanzara della malaria era assente, tornando verso i Monti Lepini d’estate. Mentre sulle colline di Monte Mario e dintorni, nelle vigne di cardinali e di patrizi, era consuetudine che a fare i lavori stagionali immigrassero temporaneamente, sin dal ’700, braccianti dall’Urbinate e dal Riminese (secondo i contratti rinvenuti da Armando Ravaglioli, storico e divulgatore di Roma antica fra i più efficaci). I primi a venire chiamati “burini” o “burrini”, da “burra” o “buris”, in latino il manico ricurvo dell’aratro leggero. Poi sinonimo in Roma di ogni forestiero dai modi poco raffinati. Un paesaggio agrario, a viti, ulivi e pascoli, con estesi boschi di essenze rare, pure le querce sugherarie, quello delle colline non ancora edificate di Roma. Paesaggio agrario che contrastava anch’esso con la piana dell’Agro fuori le mura e risultava simile a quello dei Castelli e delle alture del Reatino o della Tuscia. Come ancora testimoniano i Patriarchi, cioè i grandi alberi storici del Lazio: l’Olivo di Tivoli, non lontano da Villa Adriana, di età millenaria (probabilmente 1630 anni), o i Castagni di Terrelle nel Frusinate, a quasi mille metri, in Val Gariglia, carichi di 700 anni di età. Oggetto di studi da parte dell’Associazione Nazionale dei Patriarchi d’Italia, con sede a Forlì.
Roma, che aveva circa 212.000 residenti all’atto della storica “breccia”, si presentava coi caratteri di un grande borgo agricolo, frammisto a rovine romane imponenti e alla città dei palazzi e delle chiese mirabili unite dal connettivo delle abitazioni popolari nei vari rioni entro le Mura Aureliane. Dove gli abitanti erano stati cinque volte di più in epoca imperiale. Così, nei grandi spazi aperti o vuoti, erano sorte ville patrizie verdeggianti presto preda della “febbre” edilizia. Una certa campagna ancora si riversava fisicamente, materialmente - suoni, odori, consuetudini - dentro la stessa Porta del Popolo o dentro Porta Pia. “Di notte il silenzio della Città eterna era punteggiato di continuo”, ha scritto Silvio Negro, vaticanista, uno dei più acuti raccontatori di questa strana Roma fra passato agreste e presente “moderno”, “dal canto dei galli, dai ragli degli asini e belati di pecore. Pareva di essere in una città di agricoltori e questa impressione era largamente confermata di giorno dai branchi di pecore e di capre che lasciavano chiari segni del loro passaggio anche nelle strade principali”. Come ci tramandano le immagini evocative di quel grande fotografo che fu il conte Giuseppe Napoleone Primoli (1851-1927), romano-parigino, nipote per parte di madre di Luciano Bonaparte principe di Canino, il quale ritrae un fiume di capre giù per l’attuale via Crispi presso il Tritone o greggi di pecore attorno alla fontana berniniana di piazza Barberini. Nella città storica i fienili, del resto, erano ancora circa cinquecento. Presto la speculazione edilizia li avrebbe trasformati in abitazioni popolari.
Dicevo prima che del tutto differenti risultavano le immagini dei Castelli, pur miseri anch’essi sul piano socio-economico, o quelle delle alture sopra Subiaco e, ancor più, della corona di alte colline a vite e a ulivo e, più su, bosco di castagni e più in alto di lecci sopra i laghi di Bracciano e di Vico. Paesaggi ameni, climi salubri, luoghi di svago e di villeggiatura seminati di dimore patrizie, cardinalizie, papali, dai grandi giardini. Con interventi “firmati” da sublimi architetti di corte (primo fra tutti il Vignola) anche nel cuore di quei borghi: penso alla grande mole farnesiana di Caprarola e del rettilineo che vi si diparte dentro l’abitato, o alle case a schiera disposte da mano sapiente nella salita che porta alla maestosa cattedrale cistercense di San Martino al Cimino.
Un paesaggio agro-silvo-pastorale nel quale il disegno dell’uomo si insinua per secoli e secoli con felicità creandovi quella “seconda natura” che Wolfgang Goethe attribuiva a noi italiani (di allora) come una delle più alte qualità artistiche: aver sovrapposto alla natura originaria (quella che Averroè aveva chiamato icasticamente “natura naturans”) una seconda natura fatta di coltivi, di alberate, di terrazzamenti, di giardini, di borghi e pievi (la “natura naturata”) opera di artisti del paesaggio. Che in quella regione che noi oggi chiamiamo Lazio si rispecchiava e si esprimeva in tanti modi differenti. Ancora affine alla Toscana e all’Umbria fra nord-ovest e nord-est, già chiaramente “meridionale” in Ciociaria e ancor più nell’entroterra di Formia e di Gaeta. In mezzo, l’area di Roma, la città che a Goethe aveva “cambiato la vita” quando il Foro romano era ancora Campo Vaccino per quel continuo entrare della campagna in città, nella sola vera e duratura metropoli dell’antichità, che la storia aveva svuotato di abitanti e di attività. Così la racconta Vittorio Alfieri nella “Vita scritta da esso”: “Nei due anni di Roma io aveva tratto una vita veramente bella. La Villa Strozzi, posta alle Terme Diocleziane, mi avea prestato un delizioso ricovero. Le lunghe intere mattinate io ve le impiegava studiando, senza muovermi punto di casa se non se un’ora o due cavalcando per quelle solitudini immense che in quel circondario disabitato di Roma invitano a riflettere, piangere, e poetare. La sera scendeva nell’abitato, e ristorato dalle fatiche dello studio con l’amabile vista di quella per cui sola io esisteva (la belga Louise di Stolberg-Gedem, contessa di Albany, sposata ad uno Stuart, n.d.r.) e studiava, me ne ritornava poi contento al mio eremo, dove al più tardi all’undici della sera io era ritirato. Un soggiorno più gaio e più libero e più rurale, nel recinto d’una gran città, non si potea mai trovare; né il più confacente al mio umore, carattere ed occupazioni. Me ne ricorderò, e lo desidererò, finch’io viva”. Siamo nel 1783.
Parlare dunque di “paesaggio agrario laziale” è una sorta di invenzione novecentesca che ha le sue radici nel 1870 quando, proclamata Roma capitale (per viatico di Cavour ormai prossimo a morire e per volontà di una minoranza fortemente “risorgimentale”, liberale, mazziniana e garibaldina), vengono fuse, come Circondari, in un’unica Provincia di Roma, le quattro delegazioni di Viterbo, Civitavecchia, Velletri e Frosinone, assieme alla Comarca, cioè la ripartizione amministrativa creata da Pio VII Chiaramonti, la quale riuniva terre e paesaggi che andavano dal mare di Anzio e Nettuno ai Castelli, alla Valle del Baccano con Campagnano Romano e altri borghi, al lago di Bracciano, sino al confine di Civitavecchia. Un assetto amministrativo che resta in vigore fino al 1923 allorché viene ad esso aggregato il circondario di Rieti, sin lì inserito nell’Umbria (e un collegio Perugia - Terni- Rieti per la Camera rimarrà sino alla legge elettorale maggioritaria del 1993). Nel 1927 poi questo amplissimo territorio viene di nuovo suddiviso: stavolta in quattro province - Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone - alle quali se ne aggiunge nel 1934 una quinta, quella di Littoria (dal 1945 Latina) capoluogo dell’Agro pontino oggetto della prima, impegnativa bonifica integrale.
Questo sintetico sunto delle vicende politico-amministrative che hanno dato alla più “artificiale” forse delle regioni italiane dice già molto delle diversità paesaggistiche e agricole del Lazio, visibili del resto ad occhio nudo e facilmente rilevabili dalle parlate dialettali: chiaramente “centrali” nel Viterbese e nel Reatino, non meno chiaramente “meridionali” nei comprensori di Fondi, di Gaeta e di Formia, storicamente parte del Regno di Napoli, poi delle Due Sicilie, della provincia detta Terra di Lavoro. Oggi tutte e tre in provincia di Latina.
“Ormai è vicina la Terra di Lavoro,
qualche branco di bufale, qualche
mucchio di case tra piante di pomidoro,
èdere e povere palanche.
Ogni tanto un fiumicello, a pelo
del terreno, appare tra le branche
degli olmi carichi di viti, nero
come uno scolo. Dentro, nel treno
che corre mezzo vuoto, il gelo”.
Come sempre i poeti, in questo caso Pier Paolo Pasolini ne “Le ceneri di Gramsci” del 1957, sanno meglio di tutti disegnare ed evocare il profilo e l’atmosfera di un paesaggio nelle sue diversità. Quel “fiumicello, a pelo del terreno(…) nero come uno scolo” è una premonizione degli inquinamenti mortiferi di certi corsi d’acqua, per esempio del Sacco che continua ad avvelenare pascoli e armenti di una amena vallata che dai Monti Prenestini giunge fino alla confluenza del corso d’acqua nel Liri, a Ceprano (Frosinone). Delizie di una “modernizzazione” intesa essenzialmente come “rapina” dei beni primari: terra, acqua, aria, ecc. Purtroppo.
Dalla creatura amministrativa, artificiale e fragile, del 1927 il Lazio si consolida a regione comunque strutturata, pur nella diversità delle origini e delle culture, attraverso decenni che ne vedono la più profonda trasformazione socio-economica e quindi paesaggistica ad opera dell’uomo. Gli interventi direttamente promossi dalla mano pubblica con capitali ingenti o ingentissimi riguardano: a) sin dagli anni Dieci del Novecento, la scommessa, anzi la sfida, della riconquista dell’Agro romano quale habitat umanamente vivibile e sostenibile, dopo che il litorale fra Ostia Antica e Maccarese è stato riscattato, a partire dal 1884, un anno dopo la legge Baccarini sulle bonifiche, a forza di braccia e di carriole dall’epica spedizione di centinaia di braccianti romagnoli riuniti in cooperativa e in una sorta di utopica “colonia” dal socialista riformista Nullo Baldini, autentico capitano d’impresa proletario, fondatore del sistema cooperativistico ravennate tuttora fortissimo; b) la bonifica integrale dell’Agro pontino, iniziata a partire da Terracina da Pio VI Braschi (1717-1799) verso la fine del Settecento, riavviata nel periodo pre-fascista dagli stessi principi Caetani, in particolare da Leone Caetani (1869-1938), deputato demo-radicale, esule in Canada e privato dal fascismo della qualifica di accademico dei Lincei, sviluppata negli anni del mussolinismo come grande opera “esemplare” del ruralesimo di regime, faticosamente riavviata e completata nel dopoguerra dopo danni bellici gravissimi al sistema idraulico e ad altre opere; c) la bonifica pure integrale della Maremma laziale collocata fra la collina ricadente in Provincia di Viterbo e il Mare Tirreno, fino al confine costiero di Pescia Romana, pensata e attuata nel quadro della riforma agraria con la legge stralcio n.841 Medici-Segni datata ottobre 1950 (Delta del Po, Maremma toscana e laziale, Fucino, Puglia-Lucania-Molise, Calabria, Sardegna) riuscendo laddove non erano riusciti, nella Maremma “amara”, i signori del Medio Evo, il papa-re, il Regno d’Italia; d) gli interventi in campo agricolo, industriale e infrastrutturale della Cassa per il Mezzogiorno pensata dal gruppo Svimez di Pasquale Saraceno e votata anch’essa nel 1950 dal governo Dc-Psdi-Pri presieduto da Alcide De Gasperi. Organismo inizialmente incisivo il quale ricomprende per non pochi anni i territori laziali a sud di Roma fino alla località di Santa Palomba ricadente già nel XII Municipio della Capitale (appena sopra Pomezia, polo chimico-farmaceutico sorto soprattutto grazie agli incentivi della Cassa). Interventi, questi del dopoguerra, scaturiti da forti, drammatiche, pluridecennali lotte per “la terra a chi la lavora” - in realtà cominciate con occupazione delle terre e altre forme di rivendicazione spesso sfociate in sanguinosi scontri sociali nell’ultimo ventennio dell’Ottocento - condotte dalle sinistre e dai sindacati, in particolare dalla Cgil all’epoca guidata da un leader carismatico come Giuseppe Di Vittorio. Lotte che coniugano rottura del latifondo baronale, bonifiche di terreni paludosi, creazione di aziende coltivatrici col superamento del contratto di origine medioevale della mezzadria, particolarmente diffuso sulle colline dell’Italia Centrale, quindi anche del Lazio.
Bambini alla lavagna della scuola all’aperto.
Il manifesto per pubblicizzare le scuole per i contadini dell’Agro Romano.
Come si vede, un complesso imponente - anche se al tempo suo giudicato insufficiente rispetto allo stato di miseria, davvero terribile, del bracciantato e dei lavoratori stagionali - di interventi pubblici che, nell’arco del secolo che va dagli anni Ottanta dell’Ottocento a quelli del Novecento trasforma profondamente il volto delle campagne laziali e romane e di conseguenza i diversi paesaggi che si offrono alla vista dalla Tuscia alla Ciociaria, dal Mar Tirreno dell’Agro Pontino e del litorale romano alle montagne del Reatino. Nella vasta piana bonificata, dal litorale alle colline del retroterra, ai monti veri e propri, si afferma prima una diffusa cerealicoltura (coerente, negli anni Trenta, con la “battaglia del grano” mussoliniana), con le bionde messi, agli inizi stentate in verità, che daranno farina e poi pane “fragranza della mensa, gioia del focolare”, come scrive di persona l’ex maestro elementare Benito Mussolini per i nostri libri scolastici degli anni di guerra.
Poi però, ricostruito di sana pianta il sistema idraulico dell’area pontina e anche romana, devastato dai Tedeschi in fuga e dalla guerra, portata a termine la bonifica integrale in Maremma, colture e paesaggi cambiano, i cereali, il grano lasciano il posto alla vite, all’ulivo (si riscopre quest’ultimo anche quale frangivento), agli alberi da frutto, agli ortaggi. Più tardi alle serre. Tante serre da nascondere dietro l’opacità della plastica biancastra il verde delle colture orticole, i colori dei fiori e dei frutti. Dalle montagne e dalle colline laziali la popolazione di borghi spesso bellissimi nella loro rusticità antica scende a valle, verso Roma soprattutto, ma anche verso i capoluoghi di provincia, le città, le cittadine di pianura.
Era fragilissima, del resto, la trama degli abitati collinari ai tempi della malaria che risaliva verso l’alto “distruggendo” interi paesi, nel Settecento San Lorenzo Vecchio posto lungo la Francigena laziale, nel Viterbese. Nel 1871 la stessa Montalto di Castro non ha che 702 abitanti ed oggi ne conta dieci volte di più. Tarquinia medesima supera di poco i 4.000 e Tuscania i 3.000, Canino non arriva a 2.000. Popolazioni oggi più che triplicate o quadruplicate. Per non parlare di cittadine e castelli della Ciociaria, e ancor più di quelle che furono un tempo dimore e residenze estive di papi, principi e cardinali (i Castelli, integralmente, ma anche la zone, bellissime, dei laghi a nord, lungo la Cassia) e che oggi sono vere e proprie città, con poca vita propria e con molti pendolari da e per Roma. In auto per lo più essendo la rete ferroviaria metropolitana a lunga gittata gracile e inefficiente. Certo, gli incrementi di popolazione più vistosi si sono registrati laddove c’era un autentico deserto, o quasi, cioè nell’Agro Pontino. Qui, nel 1871, soltanto verso sud, verso quella che era stata Terra di Lavoro si contavano insediamenti umani storicamente significativi, Terracina, ad esempio, con poco più di 5.300 residenti, mentre oggi ne registra 43-44.000 o Fondi, che nel 1633 la malaria aveva ridotto gli abitanti da 10.000 a poco più di 332 e che oggi ne ha 37.000.
Giovani contadine davanti alla capanna in paglia, pertiche e rami intrecciati.
I massicci interventi finanziari pubblici e privati, ma soprattutto pubblici, nella pianura romana e laziale, dal litorale maremmano a nord a quello meridionale di Gaeta, dalle spiagge tirreniche ai Monti Lepini, ai Castelli e così via, trasformano radicalmente ambiente e paesaggio della vasta pianura così ottenuta o riconquistata. Nell’area di Latina si succedono addirittura almeno tre diversi tipi di agricoltura - che influenzano ovviamente il paesaggio - e cioè le “messi biondeggianti” della prima fase mussoliniana, tutt’altro che priva di problemi sociali, vuoi per l’arrivo dal Nord, dall’Emilia-Romagna e poi dal Veneto e dal Friuli di popolazio...