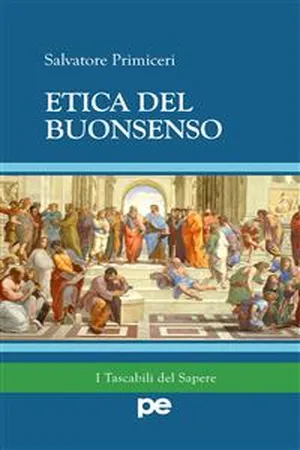
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Etica del Buonsenso
Informazioni su questo libro
Che cos’è il buonsenso? Quando e come si applica? Perchè non tutti lo usano allo stesso modo? L’autore stimola la riflessione sull’origine e sull’uso del buonsenso prendendo spunto dalla filosofia etico-morale sia antica che contemporanea ed elevandolo a strumento necessario per la ricerca della felicità. Secondo l’autore il buonsenso è un elemento innato dell’essere umano che ci consente di distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo e ciò che è giusto da ciò che è sbagliato per porre in essere i comportamenti e le azioni più corrette, talvolta in deroga alle consuetudini e alle norme. Il buonsenso spinge all’azione buona e giusta i cui effetti non saranno sbagliati per alcuno. L’uso del buonsenso restituisce serenità e felicità sia per chi agisce sia per chi riceve. Ricco di citazioni filosofiche, il volume fornisce un metodo per migliorare noi stessi e le relazioni con gli altri.
Tra gli autori citati nel testo: Socrate, Platone, Aristotele, Marco Aurelio, Seneca, Cicerone, Plutarco, Tommaso d’Aquino, Cartesio, Michel De Montaigne, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Adam Smith, Immanuel Kant, Philippa Foot, John Rawls…
Tra gli autori citati nel testo: Socrate, Platone, Aristotele, Marco Aurelio, Seneca, Cicerone, Plutarco, Tommaso d’Aquino, Cartesio, Michel De Montaigne, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Adam Smith, Immanuel Kant, Philippa Foot, John Rawls…
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Etica del Buonsenso di Salvatore Primiceri in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophy e Ethics & Moral Philosophy. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
CONSIDERARE L’INTENZIONE, LE CIRCOSTANZE E GLI EFFETTI
Capitolo IX
“ Un’azione è buona se non è cattiva in alcun modo ” è un precetto che appare scontato ma non lo è affatto.
La frase di Tommaso D’Aquino (1225-1274), proclamato santo da Papa Giovanni XXII nel 1323, presuppone un’analisi approfondita della situazione in cui ci troviamo ad agire.
Vanno, infatti, considerati elementi finora non valutati adeguatamente quali l’intenzione, le circostanze in cui avviene l’azione e gli effetti dell’azione.
Un’azione di buonsenso deve partire da una buona intenzione circa il fine da ottenere e tale fine deve riguardare tutti (fine non individualista o particolare).
Scrive Tommaso nella sua imponente opera “ Somma Teologica”:
“ (…) le azioni umane e tutte le altre cose la cui bontà dipende da altro, desumono la loro bontà dal fine a cui tendono, oltre che dalla bontà intrinseca esistente in esse”.
L’azione di buonsenso, oltre al buon fine, deve considerare anche i possibili effetti concreti e le variabili. Il risultato di un’azione di buonsenso deve essere condiviso da tutti e non può essere in alcun modo né cattivo né percepito come ingiusto da alcuno. La connessione che trasforma l’intenzione in azione, che mira ad ottenere un fine buono ed effetti buoni e giusti, è la ragione.
Il buonsenso attiene all’anima, ma anche alla ragione. È la ragione che trasforma intenzione e volontà in azione.
Non sempre, però, è facile o possibile ottenere un risultato comunemente accettato come giusto.
L’esempio riportato nelle pagine precedenti dell’anziana che commette furto in un supermercato attiene anche alla valutazione delle circostanze e alla valutazione dei possibili effetti delle decisioni (dal direttore del supermercato che decide di rimproverare platealmente la signora e chiamare i Carabinieri ai Carabinieri stessi che, una volta intervenuti, decidono di saldare il conto del supermercato per conto della signora).
Le cronache dei giornali ci raccontano quotidianamente fatti in cui il circuito dell’intenzione, azione ed effetto non produce risultati comunemente accettabili come buoni nel massimo modo possibile.
Tempo fa ho letto di un gruppo di ragazzi che, trascorso il sabato pomeriggio a fare shopping in una città vicina al loro paesino di residenza, decidono di rientrare a casa prendendo un treno senza, però, pagare il biglietto che sarebbe costato loro circa due euro. Sono tutti minorenni tra i 15 e i 17 anni.
Tra la cittadina dove si sono recati a fare acquisti e il loro paese c’è una distanza di circa 10/15 chilometri al massimo, quindi un viaggio di una decina di minuti.
Il controllore, però, accortosi della violazione dei ragazzi di viaggiare senza biglietto, li invita a scendere alla prima stazione utile.
Tra la stazione di partenza e il loro paese il treno effettua fermata in una piccola stazione automatizzata (ovvero senza personale umano) dove sostano pochissimi treni regionali nell’arco delle 24 ore.
I ragazzi, a soli 3 km da casa si ritrovano così, in piena sera, in una stazioncina di campagna vuota e comunque lontana dall’abitato.
Uno di loro decide di attraversare i binari per entrare nella stazione, ma viene tragicamente travolto da un treno veloce che sopraggiunge proprio in quel momento. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo davanti agli occhi degli amici.
Questa triste vicenda ci riporta al nostro discorso iniziale. Premesso che non è questa la sede né per emettere giudizi su fatti e comportamenti, di cui abbiamo sommari dettagli pervenuti da organi di stampa, né per effettuare rilievi giuridici che spettano agli organi competenti, è però utile porci alcune domande finalizzate al nostro ragionamento.
Partiamo dall’effetto. Un giovane ha perso la vita e tale fatto provoca un senso di ingiustizia nella maggior parte dei lettori della stessa notizia. In più gli altri ragazzi hanno subìto un trauma psicologico non indifferente nell’assistere impotenti alla tragedia.
Proseguiamo guardando alle azioni compiute dai protagonisti del fatto: alcune di esse sono sbagliate (non pagare il biglietto, non usare il sottopassaggio per attraversare i binari) ma l’azione del controllore che sanziona i ragazzi facendoli scendere dal treno è giusta o sbagliata? Qui la risposta è più delicata. Qualcuno potrebbe rispondere che ha semplicemente applicato il regolamento, svolgendo così il suo dovere; qualcun altro aggiungerebbe, invece, che avrebbe potuto valutare le circostanze (l’età dei ragazzi, la brevità del viaggio, la tenuità del fatto, visto che il mancato pagamento dei due euro di biglietto poteva essere determinato da un’intenzione di compiere una bravata oppure dal fatto che avevano terminato i soldi durante lo shopping) e riflettere sulle possibili conseguenze della sua decisione.
Per quanto fosse difficile prevedere uno scenario così tragico, il controllore avrebbe potuto evitare di esporre dei ragazzi minorenni a qualsiasi rischio, anche minimo, ma comunque possibile in una stazione deserta in tarda sera?
In sé, quindi, l’intenzione, tornando a Tommaso, poteva essere buona (insegnare ai ragazzi che il biglietto va pagato o, semplicemente, applicare le regole) ma l’effetto non lo è stato (l’investimento di uno dei ragazzi).
Il buonsenso, quindi, interviene sopra e oltre le regole (ad esempio pagare il biglietto), attraverso la valutazione delle circostanze (nel nostro caso: età, tenuità del fatto, distanza, costo irrisorio del biglietto, dovere di responsabilità di pubblico ufficiale verso minori) per permetterci di trovare una soluzione al problema che sia percepita e accettata da tutte le parti come la più giusta in quel determinato momento. La nostra soluzione ideale è un’azione che tende al bene e che non produce alcun effetto cattivo. Avrebbe potuto il controllore pensare ad un fine rieducativo dei ragazzi ma scegliendo un’azione diversa?
Il buonsenso funge, quindi, anche da deroga, in determinate circostanze, alle regole stabilite da una comunità, se l’azione che produce tende ad un risultato che soddisfa pienamente colui che la compie, colui che la riceve e la comunità stessa nella quale si svolge il fatto.
Si tratta di un principio generale che sta sopra ogni norma e muove quel senso di bontà e giustizia che migliora la convivenza civile e la giustizia stessa, elevandola al grado di “giustizia giusta”.
Il buonsenso è il faro che ispira la nostra condotta nell’esercizio di qualsiasi professione e nella nostra vita quotidiana.
Tommaso D’Aquino ordinava così la bontà delle azioni umane:
“ Si possono considerare quattro tipi di bontà nell’azione umana. La prima generica cioè dell’azione come tale: poiché l’agire (…), per quanto ha di atto e di entità, altrettanto ha di bontà. La seconda specifica: che dipende dall’oggetto proporzionato. La terza secondo le circostanze: come se fossero degli accidenti. La quarta, poi, secondo il fine, cioè quasi in rapporto alla causa della bontà”.
Purtroppo abbiamo visto che non sempre è possibile (né facile) determinare con certezza l’azione giusta da compiere. Il buonsenso può venirci incontro ma ci sono casi in cui l’effetto delle azioni nate da buone intenzioni non è sempre buono in assoluto. Può capitare infatti che un’azione porti ad un risultato buono in un senso e cattivo in un altro. Può capitare, altresì, che tale azione sia già frutto della consapevolezza che si determinerà comunque anche un effetto cattivo, nonostante la nostra azione ci appaia come la migliore possibile.
Il ragionamento sopra esposto prende il nome di “ Dottrina del Duplice Effetto”, elaborata anch’essa da Tommaso D’Aquino.
Secondo la teoria del duplice effetto è possibile, da un punto di vista etico, ritenere lecita un’azione anche se da essa derivano due conseguenze, una buona e una cattiva. Ma per consentire l’approvazione morale di una tale situazione è necessario che si verifichino quattro condizioni: 1) l’azione deve essere buona o neutrale; 2) l’intenzione di chi agisce deve essere buona e l’effetto negativo deve essere al massimo previsto ma non inteso come fine dell’azione; 3) l’effetto buono non deve dipendere dal verificarsi dell’effetto cattivo; 4) non è possibile impedire il verificarsi dell’effetto cattivo con alcuna azione e l’effetto buono deve essere più grande dell’effetto cattivo.
La dottrina di Tommaso è utile per spiegare i cosiddetti “ dilemmi morali”, questioni dove la scelta da compiere si scontra con il nostro sentimento morale.
A rendere ancora più chiaro il concetto di “dilemma morale” è intervenuta, con un’ampia produzione filosofica, la pensatrice inglese Philippa Foot (1920-2010), dichiaratamente ispirata alle dottrine di Aristotele e Tommaso D’Aquino, allieva di Elizabeth Anscombe (1919-2001), anche lei studiosa di etica e morale.
Philippa Foot è colei che ha posto il noto problema del “ carrello ferroviario”. La situazione è la seguente: poniamo che un carrello ferroviario stia correndo incontrollato a tutta velocità e che, sul suo percorso, ci siano cinque uomini legati sui binari che verrebbero sicuramente investiti e uccisi. Ci rendiamo conto, passeggiando casualmente nella zona, di ciò che sta per avvenire. A pochi passi da noi notiamo la presenza di una leva che, se azionata, devierebbe la corsa del carrello ferroviario su un binario secondario, evitando l’investimento dei cinque uomini legati sul binario principale. Sul ramo secondario, però, vi è comunque un altro uomo legato sulle rotaie che perderebbe ugualmente la vita. Il dilemma è se azionare lo scambio (in questo modo verrebbero salvate le vite dei cinque uomini legati sul ramo ferroviario principale, ma verrebbe sacrificata comunque la vita dell’uomo legato sul ramo deviato) oppure no. Voi cosa fareste?
Ci troviamo di fronte ad un problema dove appare impossibile evitare una conseguenza cattiva. Nella migliore delle ipotesi morirà comunque una persona, nella peggiore cinque.
Ho proposto personalmente questo dilemma in vari corsi di formazione che svolgo, sia a studenti che professionisti di vario settore, per verificare direttamente ciò che gli studi di Philippa Foot e altri filosofi moralisti hanno prodotto.
Il risultato è pressoché identico e vale a dire che la stragrande maggioranza delle persone a cui viene posto il dilemma si dichiarano pronti ad azionare la leva e deviare il carrello sul binario in cui è presente un solo uomo. In questo modo salverebbero la vita a cinque persone sacrificandone “solo” una.
Di fronte ad una scelta in cui comunque vada ci sarà un risultato negativo, le persone intervistate preferiscono scegliere il cosiddetto male minore.
Solo una piccola percentuale, meno del dieci percento, dice di preferire lasciar correre le cose per come avvengono e quindi di non intervenire nell’azionare la leva dello scambio.
L’esperimento è stato riproposto con una variante dalla filosofa e scrittrice statunitense Judith Jarvis Thomson. In questo caso si ipotizza che siamo spettatori casuali della stessa scena precedente, però da un cavalcavia (la ferrovia dove è in corsa il carrello è quindi sotto di noi). Vicino a noi si trova ad osservare la scena anche un uomo di grossa stazza. Non possiamo azionare alcuna leva di scambio ma nell’immediato potremmo spingere l’uomo robusto dal cavalcavia per fare in modo che si frapponga tra il carrello e i cinque uomini legati sui binari.
In questo modo, quasi certamente, la stazza dell’uomo (che morirebbe nell’impatto col carrello o comunque per la caduta dal cavalcavia) fermerebbe la corsa del carrello salvando la vita ai cinque uomini legati.
Cosa fareste? Sacrifichereste la vita dell’uomo spingendolo dal cavalcavia?
Le risposte a questa seconda variante ribaltano la situazione precedente. Più del novanta percento degli intervistati, infatti, non spingerebbe l’uomo dal cavalcavia e si limiterebbe a osservare inesorabilmente la scena dell’investimento del carrello ferroviario ai danni dei cinque malcapitati.
Qual è il motivo della divergenza nelle risposte tra il primo e il secondo esperimento? In entrambi i casi si tratterebbe di sacrificare una vita umana salvandone cinque, eppure la maggioranza delle persone avverte una differenza che induce loro a scegliere soluzioni contrapposte.
La chiave di tutto ciò sta nell’intenzione. È il concetto a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza.
Nel primo caso, quello della leva che aziona lo scambio, non si ha intenzione di uccidere ma di salvare la vita a cinque persone, anche se si prevede che possa comunque morire una persona presente nello scenario (è legata sull’altro binario). La leva si frappone tra l’intenzione e il risultato dell’azione, in qualche modo filtrandola.
Nel secondo caso, invece, una persona estranea allo scenario verrebbe intenzionalmente uccisa per salvare la vita a cinque persone.
Se nel primo caso potrebbe venire in soccorso la dottrina del duplice effetto, non si può dire lo stesso per la seconda situazione dove l’intervento umano verrebbe stavolta giudicato dagli stessi uomini come immorale, ingiusto e cattivo.
Se ci pensiamo non è così diverso da quanto accade, ad esempio, nella legittima difesa. Un eventuale atto contro la persona (poniamo un aggressore o un rapinatore) per salvare la propria vita o quella degli altri da un concreto e imminente pericolo, verrebbe “assolto” dall’intenzione di salvare la propria vita e quella di chi sta subendo eventualmente con noi la stessa aggressione. La valutazione immediata della circostanza porta ad azionare degli atti che potrebbero avere come conseguenza estrema l’uccisione dell’aggressore. Se, al contrario, noi ci sentissimo genericamente in pericolo, ma senza un reale motivo, dalla presenza di “persone sospette” in un certo luogo e decidessimo di far loro del male per sentirci “tranquilli”, ebbene tale atto nascerebbe con un’intenzione cattiva e non potrebbe essere giustificabile nemmeno dalle circostanze, del tutto frutto di fantasie e impressioni soggettive.
Il “gioco” si complica ulteriormente con un’ennesima variante al problema del carrello: il cosiddetto “ loop”. Prendiamo il primo caso e ipotizziamo che il ramo deviato dove è presente una sola persona legata sui binari non termini su una direzione autonoma ma finisca per ricollegarsi al ramo principale in senso contrario. Ciò implicherebbe che, qualora azionassimo la leva e il carrello investisse la persona presente sul binario “salvando” i cinque presenti sul binario principale, la corsa del carrello, dopo l’investimento, potrebbe proseguire andando a ricongiungersi col binario principale e rischiando così di investire comunque i cinque malcapitati. È vero che la corsa del carrello, dopo l’urto con il primo soggetto, potrebbe rallentarsi notevolmente e arrestarsi di lì a poco, ma rimane un’eventualità, seppur minima, che invece ciò non accada e che il carrello investa quindi ben sei persone e non una.
Come e quanto andrebbe considerata tale eventualità nel decidere se azionare o meno la leva? Peserà di più la maggior probabilità che il carrello si fermi prima di tornare sul ramo principale, oppure il minimo rischio che finisca per investire tutte e sei le persone presenti sui binari?
Infine, per complicarci sempre di più la vita, ipotizziamo che l...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Etica del Buonsenso
- Indice
- Premessa
- ALLA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
- PENSARE PRIMA DI AGIRE. CAPIRE PRIMA DI GIUDICARE
- DUBITARE ANCHE DELL’OVVIO. SOSPENDERE IL GIUDIZIO
- FARSI UNA RISATA (OGNI TANTO)
- FRENARE LA RABBIA, EVITARE LA VENDETTA
- STARE BENE CON SE’ STESSI
- SAPER MEDIARE
- ESSERE NEUTRALI, IMPARZIALI
- CONSIDERARE L’INTENZIONE, LE CIRCOSTANZE E GLI EFFETTI
- SENTIRE E RAGIONARE: LA MORALE COME DOVERE
- ESSERE ONESTI
- SAPER COMUNICARE
- PRODURRE FELICITA’
- ESSERE LIBERI
- TENDERE ALL’UGUAGLIANZA
- CAMBIARE MODELLI
- BIBLIOGRAFIA