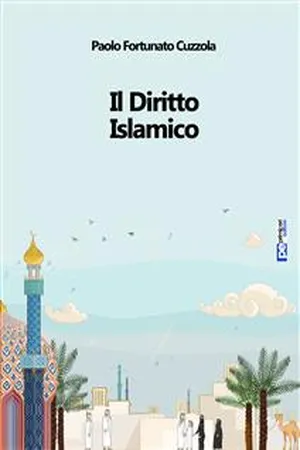
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il Diritto Islamico
Informazioni su questo libro
La conoscenza della legislazione di altri Stati, i cui cittadini vengono a vivere e lavorare in Italia, é fondamentale per superare le barriere culturali che impediscono l'integrazione. La cultura islamica è l'Italia si stanno conoscendo e proprio per questo, sono ancora alte le resistenze in termini di accoglienza e comprensione, costituite in primis da forti paure. Il testo, col suo stile pratico ed estremamente chiaro, riesce a fornirci un quadro completo sul diritto islamico, consentendo un facile apprendimento a tutti coloro che non solo operano nel mondo del diritto ma anche a chi abbia la semplice curiosità di conoscere per poi trovarsi preparati nel momento del dialogo con cittadini di cultura islamica. Il testo si rivolge a studenti, professionisti che per motivi professionali si recano in paesi di cultura islamica per ottenere le basi di conoscenza del diritto vigente in quei Paesi. La prefazione é di Salvatore Primiceri.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Lo status personale, il matrimonio, il diritto di famiglia e delle successioni
Capitolo 4
1. Introduzione
Nell’ambito del sistema giuridico islamico il diritto di famiglia e delle successioni rivestono un ruolo centrale, costituendo agli occhi dei musulmani il nucleo più intimo ed irrinunciabile della legge di derivazione sciaraitica.
Ciò è legato al fatto che questi settori del diritto sono dei campi dove più deciso risulta l’intervento normativo della Legge divina; molte delle norme che regolano il matrimonio ed i rapporti familiari trovano infatti la loro fonte diretta nella rivelazione coranica.
Anzi, dei versetti a contenuto normativo presenti all’interno del Testo sacro, la gran parte attiene proprio alla materia delle relazioni familiari. Il diritto di famiglia è oggetto nel Corano di una disciplina abbastanza esauriente.
Tuttavia molto spesso le norme presentano una formulazione vaga, oscura, che solo raramente risulta adeguata a far comprendere la volontà divina; a ciò si deve aggiungere che, per quanto concerne questa materia, nel Testo sacro sono quasi del tutti assenti formulazioni tecniche relative agli effetti giuridici di fatti o atti rilevanti.
Queste due circostanze spiegano perché, se pure il matrimonio e le istituzioni ad esso correlate trovano un preciso riferimento nella Legge divina, la loro completa definizione debba attribuirsi all’opera degli interpreti ed in particolare delle scuole giuridiche.
La disciplina sciaraitica che regola l’istituto familiare si basa pertanto su un nucleo di valori, principi e regole comuni e su un complesso di soluzioni giuridiche tra loro anche assai distanti se non addirittura inconciliabili. Il fondamento coranico conduce a ritenere queste disposizioni come assolutamente intangibili ed immutabili.
Ciò ha comportato che le stesse siano state, per lungo tempo, oggetto di un’interpretazione rigorosa che non lasciava spazio a modifiche ed evoluzioni. Solo dalla fine del diciannovesimo secolo, in concomitanza ai processi di modernizzazione che andavano interessando l’evoluzione dei paesi islamici, il nucleo del diritto sciaraitico ha conosciuto una nuova interpretazione. La tendenza che contrassegna in maniera più significativa questo sforzo esegetico è il tentativo di introdurre dei correttivi che permettano di temperare la severità della norma religiosa; l’obiettivo è quello di promuovere la posizione dei componenti più deboli della famiglia, ossia la donna e il bambino, e di equiparare i diritti e i doveri dei coniugi. Le norme sciaraitiche così riformulate sono state recepite dai codici di diritto di famiglia nei paesi musulmani, sebbene i risultati raggiunti dai legislatori siano staticomunque assai diversificati, sia nello stile che nei contenuti.
Questi testi vengono denominati “statuto personale” e ciò in virtù della applicabilità su base personale di questo gruppo di norme.
2. I soggetti del diritto islamico
A) La capacità giuridica
Si acquisisce con la nascita e termina con la morte, l'assenza o l'apostasia. Si considera nato il feto uscito vivo, sufficientemente formato e completamente staccato, dall'alveo materno, sono giuridicamente tutelati gli interessi del nascituro, il quale può ereditare o essere destinatario di una disposizione di ultima volontà.
La capacità giuridica (ahli ya) appartiene al mussulmano libero, pubere (bulùgh), sano di mente, che è considerato pienamente responsabile (mukallaf) anche sotto il profilo penale in quanto capace di agire ('amd).
La capacità giuridica comprende anche la capacità di divenire titolare di diritti e doveri (ahlì yat al-wujùb), cioè la capacità di agire ovvero l'idoneità di porre in essere atti giuridicamente validi.
Può essere limitata per varia natura, quali:
•sesso femminile;
•impubertà;
•condizioni psichiche e fisiche;
•stato d'insolvenza;
•condotta eticamente riprovevole;
•malattia mortale;
il soggetto limitato nella capacità giuridica è detto mahjur.
B) Condizione giuridica delle donne
l'Islam considera la donna uguale all'uomo sotto il profilo del valore e della dignità umana, ma fa discendere dalla constatazione delle innegabili differenze di genere, cui corrisponde una distinzione di ruoli assegnati da Dio, una diversa funzione sociale che si riflette sul piano giuridico.
Quindi, se da un lato la donna condivide pienamente con l'uomo la titolarità di tutti attinenti allo status di essere umano, dall'altro sono diversi i diritti correlati alle varie funzioni sociali e giuridiche.
In materia di proprietà ed obbligazioni, la posizione è sostanzialmente equivalente a quella dell'uomo, anche il regime patrimoniale del matrimonio è più favorevole alla donna che all'uomo, che però acquista la piena capacità contrattuale e di amministrazione del patrimonio solo con il matrimonio e che può disporre fino ad 1/3 del patrimonio occorrendo per la rimanente parte l'autorizzazione del marito.
Per ciò che concerne la sfera pubblica, la donna è esclusa dall'esercizio di alcune funzioni pubbliche (califfo, giudice, imam) anche se in alcune realtà rurali non è raro che le venga riconosciuto un ruolo più attivo.
L'Islam considera uguali tutti gli individui in materia di diritto al lavoro e all'arricchimento legale. Nel Corano e nella Sunnah non si trova un dovere della donna di dedicarsi al ruolo di moglie e madre, né il divieto di esercitare un'attività lavorativa, purtuttavia alcuni ahadith le vietano di svolgere quelle funzioni pubbliche che male si concilierebbero con talune caratteristiche fisiologiche e psicologiche.
In materia penale, il prezzo del sangue per la sua uccisione (diya) ammonta a metà del valore dovuto per un uomo.
In materia processuale la sua testimonianza in materia patrimoniale ha metà valore rispetto a quella di un uomo, mentre non è ammessa per le questioni di Stato o reati più gravi.
In ambito successorio ha diritto a metà quota rispetto a quella assegnata all'uomo, ma tale limitazione viene controbilanciata dal principio che obbliga esclusivamente l'uomo a mantenere la famiglia, e dal principio che solo la donna può ricevere il dono nuziale (mahr) del quale decide natura ed entità.
C) Condizione giuridica degli schiavi
In passato le maggiori scuole giuridiche islamiche riconoscevano la legittimità della schiavitù, purché lo schiavo venisse trattato con dignità e benevolenza.
Oggi, è pacificamente acclarato in tutta la legislazione islamica il principio dell’abolizione della schiavitù, ritenendola incompatibile con i principi islamici di giustizia, uguaglianza e fratellanza.
Lo schiavo ('abd) è considerato una persona, sotto il profilo religioso, mentre sotto il profilo strettamente giuridico essendo considerato una merce, poiché sottoposto al suo padrone non è ritenuto capace e responsabile.
Si diventa schiavi per nascita o schiavitù, gli effetti propri dello status vengono mitigati dal riconoscimento, in capo allo schiavo, di alcuni diritti attenuati e dalla circostanza che l'affrancazione è raccomandata dalla religione, prescritta dalla legge e talvolta prescritto.
Allo schiavo è riconosciuto il diritto di contrarre matrimonio, sia con altri schiavi che con persone libere diverse dai padroni.
Le schiave nubili sono concubine dei padroni, ma i figli generati in costanza di tale rapporto, se riconosciuti dal padrone, acquisiscono lo status degli altri figli nati dal matrimonio con una donna libera.
E' ammesso il ripudio tra schiavi.
I rapporti tra lo schiavo ed il padrone devono essere improntati al principio di umanità, pertanto sono vietati:
I maltrattamenti;
L’imposizione di lavori superiori alla proprie forze;
La separazione tra la schiava ed il figlio, fino al compimento del settimo anno;
L’obbligo del mantenimento (nafaqa), dello schiavo divenuto inabile al lavoro.
La schiavitù si estingue per:
•Affrancazione che, a sua volta può essere:
1. semplice (najiz);
2. sottoposta a condizione (shart);
3. a termine (ajal);
•Per atto di ultima volontà;
•Per contratto(mukàtaba) tra schiavo e padrone;
•Altre cause legali.
D) Condizione giuridica dei non mussulmani
Solo l'essere mussulmani fa acquisire la piena capacità giuridica, condizione per essere mussulmani è riconoscere il Dio unico e la verità della missione del Suo profeta Maometto.
I non mussulmani, che non hanno la piena capacità giuridica, si distinguono in due categorie:
Gli infedeli (ahl al -kitab – Gente del Libro);
Gli idolatri (ahl al – awthan – Gente degli idoli).
Una disciplina di favore è stabilita a favore dei dhimmi, gli appartenenti alle religioni Ebraica e Cristiana, la cui vita e proprietà sono protette in virtù di un impegno (dhimma) assunta dai mussulmani nei loro confronti poiché monoteisti.
Sono ammessi i matrimoni tra uomini mussulmani e donne dhimmi (non viceversa) a condizione che i figli generati dall'unione non perdano lo status di mussulmani che deriva dalla potestà del padre.
Nelle materie di proprietà ed obbligazioni vige una sostanziale equiparazione tra mussulmani e dhimmi, a livello processuale vi è il divieto di testimonianza in questioni attinenti ad un mussulmano, a livello successorio, non possono essere nominati esecutori testamentari di un mussulmano ed, infine, non possono possedere schiavi mussulmani.
A livello di libertà religiosa, questa è garantita per i dhimmi, atteso che il diritto mussulmano interviene nelle sole questioni giuridiche che coinvolgono i mussulmani o in questioni religiose.
L'apostasia (ridda) è un reato grave che è soggetta alle seguenti sanzioni penali:
esclusione dall'Umma;
incameramento dei beni nell'erario;
nullità dell'atto di ultima volontà (wassiya);
scioglimento del matrimonio.
È causa di esclusione della capacità giuridica.
E) Condizione giuridica del mahjùr
La capacità giuridica è limitata prima del raggiungimento della pubertà, il minore (sabì) è totalmente incapace di contrarre fino ai sette anni, mancando il discernimento (mumayyiz).
Al compimento dei sette anni fino al raggiungimento della pubertà (bulugh), sarà soggetto al compimento dei doveri religiosi e potrà compiere gli atti personali.
Sono affetti da nullità assoluta gli atti posti in essere dal minore a titolo gratuito e per il compimento degli atti titolo oneroso è necessario l'intervento del tutore.
E' mahjur la persona affetta da:
cecità;
sordità;
mutismo;
demenza continua ('atah).
Per il compimento di quegli atti ai quali la mancanza del senso la rende incapace.
Sono, invece considerati parzialmente mahjur:
•la persona affettada demenza intermittente la quale è incapace per gli atti di natura patrimoniale mentre è capace per gli atti di natura personale posti in essere nei momenti di lucidità;
•il soggetto che ha posto in essere un comportamento riprovevole (fisq) sotto il profilo etico-religioso, sotto il profilo dell'esercizio delle funzioni pubbliche;
•lo stato d'insolvenza (falas) rende colui che non ha pagato i propri debiti (muflis) incapace nella possibilità di disporre dei propri beni.
F) La condizione della persona giuridica
Nel diritto islamico, soggetto di diritto è esclusivamente la persona fisica, non vengono, formalmente, riconosciute le persone giuridiche.
Secondo la dottrina mussulmana la proprietà dell'erario è imputabile alla somma dei singoli mussulmani.
Lo studioso Santillana ha fissato alcuni principi generali comuni a tutte le persona giuridiche:
1.non si richiede, per l'esistenza di una persona giuridica, un riconoscimento speciale, un atto autorizzativo del potere sovrano che le attribuisca tale qualità;
2.la persona giuridica è distinta da quella delle persona che ne traggono beneficio;
3.le persone giuridiche non possono per natura agire direttamente. E' necessario che agisca in loro vece una persona fisica che la rappresenti, al rappresentante si applicano le regole del mandato;
4.la persona giuridica è assimilata al minorenne e a chi ha la rappresentanza si applicano le regole giuridiche relative a chi rappresenta i minori di età;
5.la persona giuridica è capace degli stessi diritti patrimoniali di cui è capace la persona naturale, tranne di quelli, che per loro natura, non si possono concepire senza l'esistenza effettiva di una persona fisica.
3.La famiglia legittima: il matrimonio
Secondo la legge islamica il matrimonio (nikâh) è, in primo luogo, un’istituzione giuridica volta a regolare l’ordine sociale; esso si pone come obiettivi principali la cura della prole legittima e la legalizzazione dei rapporti sessuali.[12]
Questa unione lecita fra uomo e donna risponde ad un’esplicita ingiunzione divina: “E unite in matrimonio quelli fra voi che sono celibi e gli onesti fra i vostri servi e le...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Il Diritto Islamico
- Sommario
- Prefazione
- Introduzione al Diritto Islamico
- Fondamenti ed interpretazioni del diritto islamico: le scuole giuridiche
- Gli strumenti della conservazione e dell'adeguamento
- Lo status personale, il matrimonio, il diritto di famiglia e delle successioni
- Il diritto dell'economia
- Il diritto penale e processuale
- Lo Stato e il Diritto Islamico
- Esempio di gestione islamica dello Stato: il Califfato di 'Ali
- Il Diritto Islamico nell'epoca contemporanea tra tensione alla modernizzazione e ritorno alla tradizione
- Note
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Il Diritto Islamico di Paolo Fortunato Cuzzola in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Diritto e Storia giuridica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.