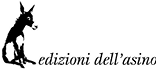Non si dà uscita mai da quelle segregazioni
non c’è corridoio né corte per quei reclusori sterminati.
Nessuna parete comune tra una cella e l’altra.
(…) Nessun messaggio possibile
senza usci le stanze: né finestre
niente posta, né alfabeto, né telefoni né bocche di lupo…
Nessun luogo d’aria per le voci
Elsa Morante
Pour l’enfant, amoreux de cartes et d’etamps
L’univers est égale à son vast appétit
Charles Baudelaire
Il giocattolaio. Georges Méliès
Nel suo monumento funebre ideale campeggia una massima filistea – “il silenzio è d’oro” – e mai omaggio, per quanto sincero, è stato altrettanto ingannevole e anche ingiusto. Da vecchio, gli era rimasta soltanto la voglia di chiacchierare, raccontarsi. Bastava dare la stura ai ricordi, provocarlo. Lui non si faceva pregare, figuriamoci. Nel ’36 – una decina di anni prima di quel film di René Clair che, senza nominarlo, lo riguarda (Le silence est d’or) – il mago delle illusioni non si fa più illusioni di sorta e il disincanto infesta le sue giornate vuote e troppo uguali. Il suo mondo di fantasia era svanito proprio come in una delle sue più tetre e allucinate fantasie. Letteralmente scomparso, disintegrato. Se ne parlava – tanto per passare il tempo, prendere tempo – era più che altro, magari, per puntiglio. Nelle sue garrule e purtroppo malinconiche concioni c’era ben scarsa vanità, molta amarezza. Aveva vissuto un sogno e l’aveva perso. Ne aveva preso atto, tristemente: il solito vecchio trucco di sempre era inservibile. Blocca la pellicola e poi falla ripartire, tenta l’azzardo. Alle spalle delle immagini preventivate, già messe in conto, compaiono all’improvviso nuove scene, costellazioni infinite di possibilità impensate, altri paesaggi (un tram a cavalli che si trasforma in un lugubre catafalco, tanto per dire; uomini che si mutano in donne, e viceversa). La sua celebre grande trovata adesso valeva meno di zero, era obsoleta. E poi non funziona mai, non c’è speranza. O funziona soltanto al cinema.
Si dava queste arie da grande precursore ma viveva di rammarico e rimpianti. Il suo mondo di invenzioni s’era dissolto negli acidi velenosi della memoria e adesso il vecchio parlava di sé al passato, in chiave postuma. Nei suoi giorni buoni aveva creato fantasmagorie di vorticosa e splendida follia:
Non c’era immaginazione, non fiaba, non portento, cui non dessi corpo nel mio teatro di posa: bagnanti seminude nuotavano fra terra e cielo; palombari riportavano a galla navi e tesori sommersi; le automobili fantasma scalavano il Righi; i treni solcavano il cielo, sospesi a palloni aerostatici; macabri musicisti palleggiavano le loro teste che andavano a impigliarsi in un pentagramma di fili telegrafici…
*
In un altro film del suo discepolo (e apostata), in Parigi che dorme, l’intera città è caduta in catalessi colpita dal misterioso “raggio” di uno scienziato e solo la figlia di quello, e un sorvegliante, sono riusciti a sottrarsi al sortilegio. Dall’alto della torre Eiffel, affacciati su un mare impassibile di deserti boulevard, nudi comignoli, digradanti tetti d’ardesia e zinco, terrazzini, quei due contemplano un paesaggio solo apparentemente consueto inghiottito all’improvviso dal silenzio assoluto di un’ipnosi. Lungo la curva del fiume riverberano luci fioche, tremolanti, e sulle torbide acque della Senna si specchiano soltanto le sagome di nubi in fuga a striare un ampio cielo curvo, viola e indaco. All’orizzonte, niente che si muova o respiri, nessuna vita. Non è la fine del mondo ma un arresto. Un sonno guasto e cattivo, senza sogni, ha spento la luce del giorno, o le coscienze, e della città resta solo l’ineffabile geometria di uno spazio inutilizzato, inutilmente complesso, indifferente.
Ciò che le storie del cinema non dicono e non sanno, o hanno rimosso, è che quella geniale trovata dadaista era un’invenzione del mago dimenticato, di Georges Méliès. Obliquamente, per interposta persona, con un’ultima impostura micidiale, lo stregone Alcofrisbas, l’incantatore, si era servito di Clair, il suo servo sciocco, per urlare tutta la sua rabbia bruciante, e il suo disprezzo, verso un mondo che ora faceva a meno di lui, l’aveva scordato. Da quando aveva lasciato la scena, era sparito, la realtà si era fatta surreale e il tempo non aveva più grana o spessore. Viveva circondato da spettri affaccendati o da sonnambuli.
Da troppo tempo – e ancora per troppo tempo – si era sepolto in questo suo chiosco anonimo e dimesso a spacciare biscotti e caramelle, strambi giocattoli. “Confiserie et jouets”: la grande insegna di latta con la scritta stampigliata in piombo nero introduceva a un riposto universo misterioso che non accettava intrusi o clandestini. Soltanto i bambini venivano a trovarlo. Soltanto i bambini e qualche povero idiota come Clair.
Nelle – rare – foto che restano del giocattolaio triste e di sua moglie il trucco, stavolta, è una patina di ordinaria rassegnazione, di scialbo e pacato realismo, di decoro, che maschera una realtà fantastica e intrattabile. Due nonni, due vecchi poveri in canna, e tre tristezze (con loro, c’è anche la nipotina, quest’orfanella). I viaggiatori che sbarcavano a Montparnasse dai treni del nord e attraversavano in fretta le cavernose navate della stazione nella luce ectoplasmatica di estenuate lampade ad arco sospese su densi vapori di fumo, nebbia e carbone, vedevano questa scena, anche patetica, o non la vedevano affatto e buonanotte. Difficilmente avresti immaginato che quell’omino con la testa rotonda, la barba a punta, il cappotto grigio piombo, il cravattino, avesse un passato segreto, o anche una storia. Doveva essere lì da sempre e sempre uguale. E anche la vecchia – adesso una solida matrona, grassa e severa, perseguitata dalle vene varicose o dall’accidia – pareva una megera qualsiasi, niente di che, e non l’avresti mai detto che una volta, era stata una bellezza, pure famosa, e avesse calcato le scene, nuda o vestita, nascosta da una pletora di annunci mirabolanti, paillettes e piume di struzzo, nomi d’arte ( Charlotte-Stephanie Faes, alias Fanny Manieux o Jeanne d’Alcy).
Lui non stava lì da sempre (e neanche lei) e persino quella bottega, così ordinaria, non era ciò che sembrava all’apparenza. Le solite merci in mostra, dozzinali, magari erano solo un pretesto. Tamburelli e trombette di latta, lecca-lecca, curiosi tricicli preistorici, fionde, fucili li potevi trovare pure qui, come un po’ ovunque, ma il vecchio aveva ben altre risorse in serbo, altre sorprese. Le bambole, per esempio, non erano proprio bambole sul serio, ma complicati marchingegni a orologeria, effetti speciali. C’era un giocatore di scacchi che muoveva i pezzi con una zampa-artiglio cigolante e conosceva le regole del gioco e non c’era verso di batterlo, più o meno, anche se potevi sempre provarci, naturale. C’era una bambolina-manichino che sapeva raccontare favole paurose con una vocetta chioccia, aspra e metallica. E c’era un trenino che se gli davi la molla scattava in verticale e, con fragore, trasformava le fiancate dei vagoni in mobili paratie bombate e, tutto d’un colpo, si mutava in sommergibile e poi in pallone aerostatico, quindi in affusolato siluro, e infine tornava treno, semplicemente. Giocattoli viventi, complicati marchingegni, infidi automi: il vecchio – che aveva escogitato ben altro, ai tempi suoi – era tornato a maliziosi svaghi da ragazzino e questo suo campionario clandestino lo riportava ai sogni e ai deliri dell’infanzia. Nelle sue case di bambole le stanze erano tutte stregate e a ogni canto si aprivano cunicoli, labirinti, doppiofondi, ingannevoli giochi di specchi deformanti, trabocchetti.
Vani passatempi senili con cui ricostruiva paesaggi sepolti già nella memoria. Negli anni ottanta, aveva visitato il maniero del celebre prestidigitatore Robert Houdin e in quella fastosa dimora sulla Loira aveva scoperto che l’arte dell’illusione può essere anche architettura, meccanica specialistica, scenografia. La villa di Le Prieuré era tutto un mirabolante e astruso congegno a molla. Un sofisticato sistema di leve, rotelle, pulegge, barre, alberi a camme sincronizzava le sinistre pendole rintoccanti in ogni appartata sala del palazzo e per portare l’acqua ai rubinetti c’era, proprio nell’atrio di ingresso, sotto le scale, un assurdo, scombinato mulino a gas (il mulino e l’orologio: la rivoluzione industriale, aveva scritto Marx qualche anno prima, nasce proprio da queste macchine che fanno tutto da sé, vanno da sole). Nelle scuderie, i grandi cavalli pezzati del negromante si nutrivano da mangiatoie automatiche a motore che – a tempo debito – erogavano misurate dosi di fieno e biada; nei viali, cupi e ombreggiati, del giardino nani di latta e gesso marciavano in fila indiana trascinati lungo apparentemente invisibili binari.
Tutte cose singolari, bizzarre e sensazionali, stupefacenti, che lasciavano a bocca aperta, meravigliavano. Ma Georges non era un curioso come tanti; il suo era già un interesse più smagato; una forma di spionaggio scientifico o di plagio. Con la sua grafia minuta, regolare, riempiva quaderni e quaderni di appunti, schemi, grafici e quando suo padre, il cerbero, lo incalzava chiedendogli che diamine se ne sarebbe fatto di quegli sgorbi, lui rispondeva sempre sorridente: “qualcosa me ne farò, stanne sicuro. Non ne ho ancora la benché minima idea ma non fa niente”. L’incerto futuro non lo impensieriva. Soltanto una cosa sembrava assodata: non riusciva a restarsene con le mani in mano.
Il demone dell’invenzione mi tormentava. Durante il periodo della mia breve carriera industriale, – ricorda tanti anni dopo, con rimpianto – avevo avuto modo di imparare tutta una serie di lavori manuali: falegnameria, carpenteria meccanica, riparazione e costruzione di macchine, utensili, automi. Assai dotato per il disegno, che praticavo con regolarità da quando ero bambino, occupavo il tempo libero scarabocchiando, sia per me stesso che per i giornali illustrati.
*
Poco dopo la Seconda guerra mondiale, Ennio Flaiano scrive di quel film di Clair, Il silenzio è d’oro, e parla proprio di lui, l’antesignano su cui era calato l’oblio troppo in anticipo.
Georges Méliès oggi non sarebbe ricordato se non avesse dato fuoco alle vere polveri cinematografiche con la sua esperienza di prestidigitatore e una grossolana ma prepotente fantasia che utilizzava Verne, i trucchi del celebre Bosco, l’astronomia popolare e persino i disegni che Savinio non aveva ancora fatto.
L’avrebbero ricordato, riscoperto. Il che non è consolante, in fin dei conti. In un incerto domani, cioè troppo tardi, può sempre arrivare l’omaggio postumo, il tributo, e allora è davvero una beffa, un’ironia. Sia come sia, nei giorni della “Confiserie et jouets”, a gare Montparnasse, l’incantatore potevi scambiarlo pure per un bottegaio taccagno, micragnoso, o un povero disgraziato perseguitato dalla sua eterna Santippe borbottante. Non c’era niente di strano; non era strano. Ai rari clienti – papà in viaggio d’affari che non volevano ripresentarsi a casa a mani vuote, famigliole in partenza per le coste della Bretagna che facevano incetta di secchielli e palette per il mare, belle ragazze da poco elevate al discutibile e gramo rango di zie – il vecchio poteva regalare al massimo uno dei suoi rari sorrisi esitanti o, qualche volta, la patetica magia di un gioco di carte. Di conigli, colombe, topolini e serpenti piumati nel cappello non ne voleva più sentir parlare. Era quello che era, ciò che sembrava. Un tipo buffo; un simpatico personaggio; un vecchio eccentrico. Sui suoi rinomati e curiosi abracadabra era calato un velo spesso e pesante di silenzio. Niente “bolle di sa...