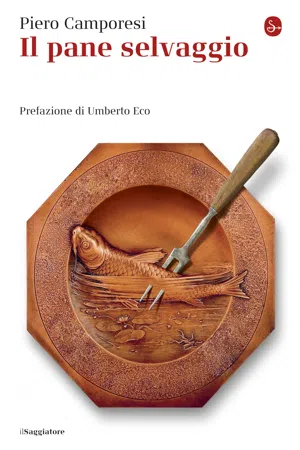
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
Il pane selvaggio
Informazioni su questo libro
Nell'Europa fra Quattro e Settecento, larga parte della società era non solo schiacciata dal peso degli status piramidali, immodificabili per legge divina e volontà regale, ma anche oltraggiata dalla fame e dalla miseria, tiranneggiata dall'uso quotidiano di pani ignobili, spesso mischiati volontariamente con erbe e granaglie tossiche e stupefacenti.Mentre i Galilei, i Cartesio e i Bacone fabbricavano una macchina del mondo razionale e ordinata, la sottoalimentazione cronica e l'ubriachezza domestica generata da queste droghe campestri e familiari lanciavano il corpo sociale in un viaggio onirico di massa, in trance ed esplosioni dionisiache che coinvolgevano interi villaggi, nei meandri di un immaginario collettivo demonico e notturno che compensava un'esistenza invivibile, alle soglie dell'animalità.Nel Pane selvaggio Piero Camporesi, ricorrendo a un'ampia campitura di fonti letterarie d'età moderna, racconta un'umanità narcotizzata, preda di una colossale vertigine oppioide, che viveva in un mondo di squallida apatia intellettuale e morale e di disinteresse per le cause più alte, sprofondata in un universo fantastico. Un'umanità, tuttavia, che ancora conosceva la percezione extrasensoriale della realtà, forme di coscienza e di scienza diverse da quelle, a una sola dimensione, della razionalità, e che dunque ancora poteva attingere ai serbatoi onirici che l'interdizione delle erbe allucinogene ha poi distrutto.Piero Camporesi – che per statura può essere avvicinato a Jacques Le Goff, e che come questi si è adoperato per restituire il ritratto storico e sociale dell'Europa preindustriale attraverso i sensi degli uomini che vi avevano materialmente vissuto – è stato un maestro, con la sua ricerca, per generazioni di studiosi, e con la sua prosa ricca eppure nitida impersona una delle massime vette raggiunte dalla scrittura italiana secondo-novecentesca. Tra i molti scritti di cui è stato omaggiato dai più importanti intellettuali e uomini di lettere contemporanei figura quello di Umberto Eco con cui si apre questa edizione del Pane selvaggio, con la quale il Saggiatore dà avvio al progetto di ripubblicazione del corpus delle opere di Camporesi: per rendere nuovamente al pubblico l'illuminante lettura che egli ha dato del nostro comune passato.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Indice dei contenuti
- Copertina
- Sommario
- Prefazione
- Occhiello
- Introduzione
- 1. La «miserabile malattia»
- 2. Il pane frangente
- 3. Cannibalismo sacro e profano
- 4. «… se ne vanno per il mondo malabiando»
- 5. «Computruerunt in stercore suo»
- 6. Il «mondo a capinculo»
- 7. La «carestia di vivere» e il «tempo del sospetto»
- 8. Il tempo di notte
- 9. Battaglie rituali e furori popolari
- 10. Medicina pauperum
- 11. «Strettezza di borsa»
- 12. Vertigini collettive
- 13. Sogni iperbolici
- 14. Paradisi artificiali
- 15. Il pane papaverino
- 16. La «volubile e verminosa colonia»
- 17. Putridi vermi e sordide lumache
- 18. Una città di mummie
- 19. Il trionfo della povertà
Domande frequenti
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app