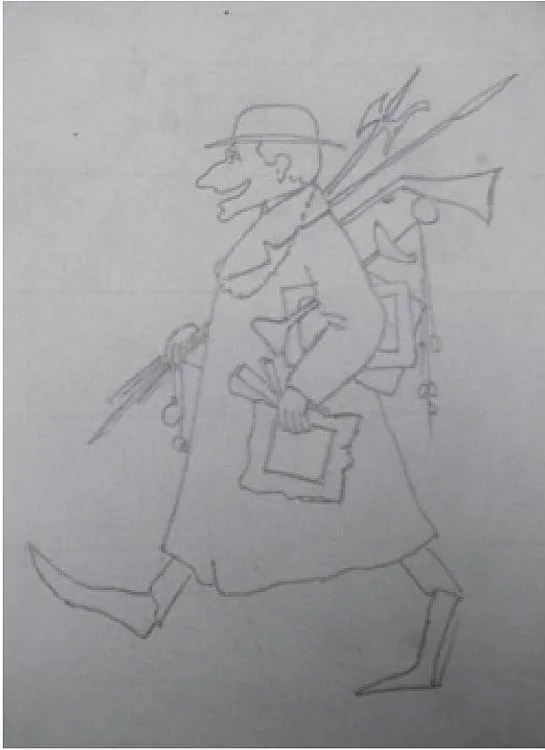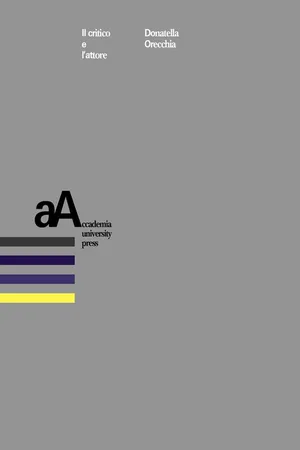1. Ermete Novelli «comico dell’arte»
1.1. Il comico dell’arte
1Il 30 novembre del 1914 sull’«Idea Nazionale», all’interno della rubrica «Le Cronache drammatiche», Silvio d’Amico pubblica il suo primo intervento critico in forma di breve saggio su Ermete Novelle1.
2È il principio di quella lunghissima collaborazione con il quotidiano romano che, iniziata nell’autunno dello stesso anno su proposta Maurizio Maravaglia2, uno dei dirigenti dell’Associazione nazionalista, già a partire dal 1918 vedrà d’Amico promosso dal ruolo di vice di Domenico Oliva a quello di responsabile unico della rubrica, ruolo che gli darà fra l’altro il privilegio di scegliere in modo assolutamente libero l’oggetto dei propri interventi. Ai tempi a cui facciamo ora riferimento d’Amico si occupa invece per lo più di quegli spettacoli, spesso di marginale interesse, che Oliva o per scelta o perché impegnato in altri lavori non tratta direttamente. Il suo lungo articolo su un comico noto come Novelli, risolto in forma di breve saggio più che di commento di cronaca, risulta pertanto piuttosto un’eccezione che una regola.
3L’occasione che dà l’avvio all’intervento è l’annuncio fatto da Novelli della sua volontà di ritirarsi dalle scene (decisione che presto l’attore ritratterà: l’anno successivo infatti costituirà la compagnia «Fert», prima attrice Lydia Borelli, di cui lui sarà direttore ma non attore e poi, pochi mesi dopo, si ripresenterà sulle scene italiane come capocomico). L’occasione è pretestuosa, probabilmente; perché è subito chiaro che la ragione profonda che muove d’Amico è piuttosto l’esigenza di definire pubblicamente, a esordio della sua carriera di critico, la propria posizione nei confronti della grande tradizione dei comici italiani di cui Novelli è certamente l’ultimo potente esempio; l’ultimo sussulto di un mondo che sta scomparendo e di cui intellettuali e critici come d’Amico, ma anche Gobetti e Bontempelli – la nuova generazione – non vedranno che tracce.
4E partiamo proprio di qui, dal contesto teatrale in cui la critica di d’Amico si situa e nel confronto con la quale il suo pensiero viene lentamente formandosi. Il mondo su cui Boutet aveva maturato il proprio gusto estetico e la propria passione per il teatro e l’attore e che, nonostante le posizioni polemiche contro il mattatore e la lotta per la difesa della drammaturgia, ancora si sente pulsare nelle sue cronache drammatiche, per il giovane critico, che nel 1914 ha 27 anni, è una realtà artistica ormai in decadenza. D’Amico ne vede solo più il poco che resta e resiste, un’esperienza che ritiene poco o nulla feconda per i nuovi tempi e che per questo vorrebbe definitivamente conclusa.
5Eppure proprio perché quella memoria perdura, perché ne restano ancora alcuni rari testimoni (Novelli e Zacconi ne sono due esempi), il confronto con la tradizione del «teatro all’antica italiana», come lo definirà Sergio Tofano, costituisce uno dei presupposti essenziali – e di ciò d’Amico si rivela perfettamente consapevole – per avviare una meditazione seria sul teatro italiano degli anni Dieci e successivo. L’articolo dal titolo Novelli se ne va è quindi la chiara espressione di un modo di guardare alla tradizione dell’attore italiano fra Ottocento e inizio Novecento con occhi che vedono innanzitutto la fine di quell’esperienza e che, dalla fine – la dichiarazione ufficiale del comico di abbandonare la scena – risalgono a costruire un quadro complessivo per circoscriverlo in un tempo chiuso e infine archiviarlo.
Il comico italiano è ben più foggiato pel plauso della gran folla che per la fine comprensione dell’intelligente. Il comico italiano non è mai stato e non è colto. Il comico italiano ha delle felicissime qualità d’intuito e d’espressione, di cui però si vale in modo quanto intenso altrettanto limitato [...] non capisce, non è intelligente, non va oltre il senso immediato delle frasi che deve dire, non si preoccupa mai di risalire (né saprebbe) da quelle frasi alla ricostruzione d’una persona, alla penetrazione d’un’anima; […] in fine, non è altro che «l’antico commediante dell’arte»3.
6C’è in queste poche parole, e in alcune altre di cui il saggio si compone, una buona sintesi del pensiero di d’Amico relativo all’attore di teatro, o meglio, a quella particolare forma che questi ha assunto in Italia a partire dalla Commedia dell’Arte fino a giungere, appunto, a Ermete Novelli.
7D’Amico non fu certo né il primo né il solo a ricordare a proposito di Novelli gli attori della commedia dell’Arte: prima di lui altri, Boutet compreso, ne scrissero, ma con minore insistenza e, soprattutto, con una minore volontà di dimostrare una tesi interpretativa sull’intera tradizione attorica italiana. Se nelle sue pagine infatti si ritrovano gli echi di altre pagine critiche scritte a commento di questo attore, il modo con cui il ragionamento viene condotto riflette invece un’intenzione che per nettezza e determinazione è solo sua.
8D’altro lato la forma stessa dell’articolo, che si avvicina a un breve pamphlet polemico più che a un saggio storico o a un intervento di cronaca, lo induce a enunciare con forza la sua tesi più che ad articolarla o a esemplificarla su un preciso testo spettacolare.
9E ora fermiamo l’attenzione su alcuni punti fondamentali del ragionamento di d’Amico che elenchiamo di seguito sinteticamente.
10Il comico italiano è incolto.
11Il comico italiano è improvvisatore. La sua improvvisazione si limita a sfruttare «genialmente» alcune «situazioni», in modo molto simile a quanto sarebbe accaduto durante la Commedia dell’Arte; la tradizione tardo ottocentesca del comico italiano (il grande attore-mattatore) infatti, avrebbe fatto uso del testo drammatico come di un canovaccio, applicando di volta in volta, all’interno di trame rese esili e scarne, il formulario delle solite battute e dei soliti gesti che appartengono al suo repertorio personale.
12Per questo il comico è per lo più monotono: accentua sempre le stesse frasi e ripete i medesimi gesti.
13Poiché non c’è «ricostruzione d’una persona», «penetrazione d’un’anima» e, detto in altre parole, non c’è indagine psicologica, il comico si arresta all’espressione del frammento, senza poter mettere in relazione più frammenti in un tutto dotato di un senso.
14Di qui l’accusa di ignoranza.
Tavola 1. Ermete Novelli in una caricatura di Ruggero Ruggeri
MBA. Fondo Ruggeri
15E torniamo da dove eravamo partiti: il comico è incolto, incapace di capire e, infine, privo di intelligenza.
16Ecco il contesto in cui si inserisce a pieno titolo Ermete Novelli.
17In queste dichiarazioni che, mancanti di un’adeguata articolazione dell’oggetto in questione, appaiono un poco semplicistiche, si esprime chiaramente un modo di concepire lo spettacolo teatrale di cui non è certo d’Amico il primo sostenitore. La polemica contro il comico dell’arte va qui a rafforzare quella contro il grande attore ottocentesco proprio perché la incontra in un punto preciso: l’affermazione, in entrambi i modelli di spettacolarità, di una predominanza assoluta del linguaggio dell’attore su tutti gli altri codici linguistici e in particolare su quello della scrittura drammatica. Il comico italiano rappresenterebbe così, in questa prospettiva, l’antagonista per eccellenza dell’altra ipotesi di spettacolarità a cui d’Amico invece fa riferimento: quella cioè secondo la quale l’opera dello scrittore è il primum assoluto su cui tutto lo spettacolo deve essere costruito e che ne garantisce l’unità, la coerenza e l’organicità complessive. Una poetica d’attore che si distanzi da un’ipotesi d’interpretazione del testo, non è contemplata come legittima.
Il comico italiano, allora e ora, sapeva e sa, con naturalezza prodigiosa, ridere, piangere, implorare, comandare [...]; e adopera questa sua valentia di frammentaria imitazione e riproduzione in tutte le occasioni che gli paiono adatte, applica insomma questo suo formulario alle battute che il suggeritore gl’imbocca [...]. Egli insomma dà rilievo alla parola, tutt’al più alla battuta, qualche rara volta alla scena; ma non al carattere; e men che mai alla commedia4.
18La “valentia” di cui parla d’Amico è dunque quella maestria nell’“imitare”, nel “simulare” e nel riprodurre con estrema scioltezza i gesti, le intonazioni di voce, la mimica del volto etc., utili alle principali situazioni drammatiche5: un talento tanto prodigiosamente radicato nel comico della tradizione italiana da sembrare quasi innato; un’abilità che, tuttavia, non sottoposta a un principio (il testo e, nel testo, il carattere) capace di condurla a una superiore sintesi artistica, resta ad uno stato di esuberante forza naturale, incapace di superare la dimensione del frammento, forse intenso, ma privo di spessore semantico. Come nella costruzione di un discorso: il comico sarebbe capace di accostare efficacemente le parole, talvolta di descrivere un dettaglio o delineare una frase, ma poi non sarebbe in grado di collegare fra loro i vari elementi in un discorso dotato di un senso organico complessivo.
19Responsabile di tale frammentarietà, non da ultimo, sarebbe anche il tipo di repertorio scelto. Sulla scorta del modello di teatralità che d’Amico fa discendere direttamente dalla Commedia dell’Arte infatti, la straordinaria capacità improvvisatrice ed espressiva del comico resterebbe come rattrappita monotonamente entro situazioni standardizzate che spesso, come capitava nel caso degli «scenari a soggetto», caratterizzano gran parte delle commedie dei moderni repertori. E tuttavia il grande attore farebbe ancora un passo in più, non essendo il suo un repertorio costituito da semplici canovacci, ma diventandolo di fatto una volta sottoposto alla forza disgregante della recitazione:
Nessuno quanto lui persiste a considerare, di fatto, la tragedia o la commedia che rappresenta, come la vecchia commedia dell’arte, come un puro e semplice canovaccio, una trama, uno schema offerto alla sua abilità perch’egli vi possa inserire e ricamare i suoi consueti virtuosismi tragici e comici6.
20La sua grandezza come quella dell’antico comico non consisterebbe dunque nel «comprendere e sviscerare e rendere una creatura d’arte»; consisterebbe invece nelle «eccellenti qualità tecniche: di mimica, di dizione, di fisionomia, di gesto» con cui egli creerebbe sì, ma « (purtroppo) un suo unico immutabile tipo, ...