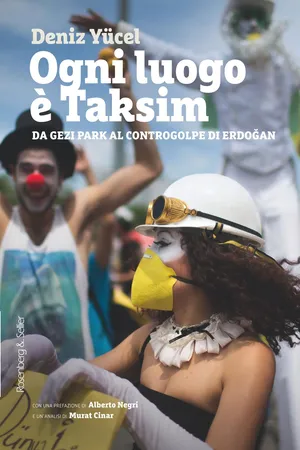Ogni luogo è Taksim
Il Movimento di Gezi Park
e il futuro della Turchia
di Deniz Yücel
a Berkin Elvan
1. Taksim:
una piazza politica
Una foto nella vetrina dei miei genitori
Il mio primissimo ricordo di piazza Taksim è una foto. Si trovava nella vetrina dei miei genitori, nel loro appartamento nel Sud dell’Assia, a Flörsheim am Main. Lì siamo cresciuti io e mia sorella İlkay, figli di lavoratori emigrati dalla Turchia. Forse mi è rimasta in mente perché non c’entrava molto con il resto, integralmente costituito da ritratti o foto di gruppo: una era del matrimonio dei miei genitori, mia madre Esma quand’era giovane con le sue sorelle, mio padre Ziya con fratelli e sorelle, i miei nonni, inoltre una foto sfocata di un uomo con la barba e un’espressione stizzita sul volto. Una volta venni a sapere che si trattava del mio bisnonno paterno, nonno Alim, e che questa ne era la sola immagine esistente. Queste persone erano in posa e avevano un’aria solenne. E tutte le foto erano in bianco e nero, forse per questo mi sembravano testimonianze di un tempo lontano.
Solo una delle immagini nella vetrina era diversa. Vi si scorgeva una folla. I visi erano irriconoscibili, ma si capiva che tanti alzavano in alto il pugno chiuso. Sotto di loro c’era uno striscione gigante con la scritta «Primo Maggio» e l’immagine di un lavoratore stilizzato col baffone e un’espressione triste, una mano legata a una catena, nell’altra una bandiera rossa. Lo stile degli anni Settanta.
Anche il mio secondo ricordo di piazza Taksim è indiretto. È la strofa di una canzone: «Eravamo cinquecentomila lavoratori | Andavamo in piazza Taksim | Che İstanbul abbiamo visto! | Un giorno ce lo chiederanno».
È una canzone di Ruhi Su, un sopravvissuto al genocidio degli armeni che aveva studiato canto lirico; fu il primo cantante a politicizzare la musica popolare turca.
Non so quando ho sentito questa canzone per l’ultima volta, forse vent’anni fa, forse di più. Ma in quei giorni di giugno 2013, quando la polizia si era ritirata dal centro della città e diecimila persone festeggiavano in piazza Taksim, come nel vicino Gezi Park, e io la attraversavo per la prima volta, erano queste le prime frasi che mi erano venute in mente: «che İstanbul abbiamo visto…». Sì, melodrammatica e kitsch. Ma non esiste rivoluzione senza páthos. E forse neanche senza un po’ di kitsch.
Mi era tornata in mente anche la foto con la folla, raccolta davanti allo stesso palazzo, il centro culturale Atatürk in piazza Taksim. Vi erano appesi solamente degli striscioni e un ritratto: quello di Deniz Gezmiş, il leader del movimento studentesco turco giustiziato nel 1972. I miei genitori mi hanno dato il suo nome.
Con le proteste di Gezi Park, e con lo slogan lì emerso: ogni luogo è Taksim, la resistenza è in ogni luogo, piazza Taksim è diventata un simbolo. Ma per i turchi di sinistra e della sinistra liberale, per i comunisti e gli anarchici, per i socialdemocratici e i sindacalisti e per tutti quelli il cui cuore batte in un certo senso a sinistra, Taksim era già un luogo sacro. E questo ha a che fare con quegli eventi di cui Ruhi Su cantava in questa canzone e che erano documentati dalla foto descritta. Si trattava del Primo Maggio 1977.
Il santuario della sinistra
Il 1º maggio del 1977 una grande folla si era raccolta in piazza Taksim. Dovevano essere circa mezzo milione di persone, trattandosi della più grande manifestazione della storia turca moderna fino a quel momento. Al termine del discorso di Kemal Türker – il presidente dell’unione sindacale Disk, che più tardi verrà assassinato da componenti del Partito del Movimento Nazionalista (Mhp), di estrema destra – da quello che oggi è l’hotel Marmara, e anche dal tetto dell’edificio dell’autorità per le risorse idriche vennero sparati dei colpi, esattamente nel momento in cui egli stava chiedendo: «Volete che questa piazza venga rinominata “Piazza Primo Maggio”?». Il panico stava dilagando e la polizia peggiorò la situazione fendendo la folla con i carri armati. La maggior parte delle persone morì nella calca in uno dei vicoli scoscesi adiacenti, dove una macchina parcheggiata chiudeva le vie di fuga. Ci furono almeno 34 morti.
I colpevoli e i mandanti non sono mai stati identificati. Nonostante ciò, fino a oggi persiste il sospetto che Bülent Ecevit, il presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e cinque volte primo ministro, abbia detto poco dopo che il massacro era stato opera della controguerriglia. Molti sostengono che fosse una misura di intimidazione. Altri arrivano a sospettare che si trattasse della preparazione di un golpe di una parte dell’esercito.
Anche Celalettin Can lo pensa. C’era anche lui quel giorno in piazza Taksim come rappresentante per İstanbul dell’Unione studentesca Devrimci Gençlik (Gioventù rivoluzionaria). Due anni prima, a diciannove anni appena, si era trasferito lì dalla provincia curdo-alevita di Tunceli per studiare. «Be’ – dice – in realtà sono venuto a fare la rivoluzione». Dall’unione studentesca di cui faceva parte ha origine il giornale “Devrimci Yol” (Via Rivoluzionaria), che uscì per la prima volta quel Primo Maggio 1977; intorno a esso si sviluppò un’organizzazione di massa eterodossa e di sinistra. Devrimci Gençlik rappresentava il blocco di dimostranti più numeroso in piazza Taksim; la maggior parte di quelli che sono morti, provenivano dalle sue fila.
Oggi Can ha 57 anni, è editorialista del quotidiano filocurdo “Gündem” e scrittore. Ha fatto parte del “Consiglio dei saggi”, una commissione incaricata dal governo di guidare il processo di pace con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Ed è presidente della Fondazione del Settantotto, impegnata a scoperchiare i crimini della giunta. Qual è la differenza tra la sua generazione e quella del Sessantotto? «Negli anni Settanta la Turchia da agricola era diventata una società industriale», dice Can. «Ed era un tempo in cui la sinistra era riuscita a portare in strada per la prima volta milioni di persone». Della sua generazione sono state uccise un numero di persone di gran lunga superiore rispetto a prima e dopo il golpe del 1971. Circa 4000 morti, compresi quelli giustiziati o i sostenitori dei lupi grigi uccisi da quelli di sinistra. «È anche vero che i golpisti del 1971 hanno impiccato Deniz Gezmiş e hanno ucciso Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya e altri. Ma non sono riusciti a sporcare la loro memoria. Per questo più tardi ci si è comportati come se queste figure del Sessantotto fossero uscite dalle favole e non avessero nulla a che fare con questa società. Dopo il golpe del 1980 lo stato non ha più fatto crescere i bambini con la paura di Dracula, Frankenstein e Tepegöz, ma con la paura degli eventi precedenti a quella data».
L’ufficio di Can è in uno dei vicoli limitrofi alla via ...