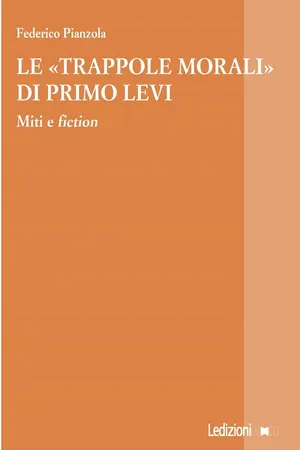3. Prometeo
questo libro fa vedere che l’avventura c’è ancora, e non agli antipodi; che l’uomo può mostrarsi valente e ingegnoso anche in imprese di pace; che il rapporto uomo-macchina non è necessariamente alienante, ed anzi può arricchire o integrare il vecchio rapporto uomo-natura. (L’avventura tecnologica, 1980, RR, OII 1444)
1. Prometeo maestro degli uomini
Sebbene Levi non abbia mai insistito particolarmente sulla figura di Prometeo, il mito dell’eroe che ha osato sfidare Zeus e ha donato il fuoco agli uomini è forse quello che si articola in modo più complesso e capillare nei suoi racconti di finzione. All’interno di un percorso che si propone di mettere in evidenza le varie trame fra miti e fenomenologia della creazione, il mito di Prometeo è calzante per varie ragioni e, sopratutto, introduce un aspetto fondamentale della questione: la creazione intesa come intreccio fra poiesi e antropopoiesi, due dimensioni ampiamente esplorate nei racconti di Levi. Le occorrenze delle varie forme della creazione e dell’invenzione «si richiamano reciprocamente e, alla fine, pongono gli stessi interrogativi, forse contenuti al meglio nella connessione tra il fare dell’uomo e il suo farsi, tra l’uomo come “fabbro” e l’uomo come “fabbro di se stesso”, “faber sui” [Il fabbro di se stesso, 1968, VF, OI 702; François Rabelais, 1964, AM, OII 645]» (Gordon 173).
In tale prospettiva, il mito di Prometeo offre un’enorme quantità di risorse retoriche e tematiche, dunque non sorprende che l’inventio di Levi si rivolga di frequente ad esso. Prometeo è il previdente e il preveggente, figura «dal pensiero complesso e accorto» (Th., v. 511), «un essere formidabile, capace di trovare scampo anche nelle situazioni impossibili» (Pr., v. 59), colui che dona agli uomini «le cieche speranze» per sopportare la loro condizione mortale (v. 250), e il fuoco, «maestro di ogni arte» (vv. 110-11).
Non solo «i mortali possiedono tutte le arti grazie a Prometeo» (vv. 505-06), e quindi devono a lui tutte le proprie abilità e competenze; l’eroe greco è anche di esempio agli uomini per come sceglie di usare la sua capacità di giudizio, l’astuzia e l’abilità pratica che lo contraddistinguono. Prometeo è un esempio etico di chi sa assumersi la responsabilità delle proprie azioni: nella tragedia di Eschilo egli lo afferma («Volevo, volevo farlo il mio sbaglio: non intendo negarlo!», v. 265) e il coro lo ribadisce («la scelta è stata tua: troppo onore hai fatto ai mortali», vv. 543-44). Le grandi abilità e l’atteggiamento responsabile fanno di Prometeo un eroe estremamente in sintonia con l’etica di Levi, ma il titano è celebre anche per un aspetto che non si addice ad essere incluso fra “le virtù dell’uomo normale”: la hybris, l’eccesso che viola il precetto greco della giusta misura (méden agàn), un valore molto importante anche per Levi. Tale eccesso è enfatizzato anche dal commento del coro, il quale rimprovera a Prometeo il «troppo onore» concesso agli uomini, un gesto che esorbita dall’ordine imposto da Zeus e dall’etica del dono, poiché i mortali non possono contraccambiare il favore ricevuto (934).
Per tale motivo, nella tragedia di Eschilo non vi è corrispondenza tra caratteristiche dell’eroe e valori etici proposti dall’insieme dell’opera, tra funzione del personaggio e funzione del discorso. Questa discrepanza nella costruzione retorica della narrazione impone di considerare non solo la figura di Prometeo, bensì il mito nella sua totalità come parte dell’enciclopedia a cui Levi attinge per le sue variazioni sul tema della creazione. Inoltre, non è solo la tragedia di Eschilo il testo a cui rivolgersi per comprendere il rapporto di Levi col mito, poiché un racconto così celebre come quello di Prometeo è narrato anche in altri testi ampiamente disponibili e noti: la Teogonia e le Opere e giorni di Esiodo, il Prometeo incatenato di Eschilo e la Biblioteca di Apollodoro.
In merito al rapporto fra Prometeo e gli uomini, è opportuno ricordare che nelle fonti che precedono cronologicamente la tragedia di Eschilo l’eroe non agisce spinto da amore per gli uomini ma per una gara di abilità e di inganni con Zeus (Th., vv. 534-616; Op., vv. 42-105). Tale aspetto si riflette in alcuni dei personaggi prometeici di Levi, i quali agiscono egoisticamente per provare la propria abilità, dunque cedendo alla hybris. In questi casi, l’aspetto filantropico, quando viene menzionato, è sbeffeggiato. Ad esempio, Alberto, il compagno di Levi nel lager, sostiene che «Prometeo era stato sciocco a donare il fuoco agli uomini invece di venderlo: avrebbe fatto quattrini, placato Giove ed evitato il guaio dell’avvoltoio» (Cerio, 1974, SP, OI 863). Alberto è sì un Prometeo a tutti gli effetti:
risalta come un eroe nell’antieroico mondo del campo di concentramento, per il suo ottimismo costruttivo, la sua resistenza al sistema del campo, ragionata e istintiva al tempo stesso [analoga alla resistenza di Prometeo al nuovo ordine imposto da Zeus], per la sua forza e la sua buona volontà, la sua libertà e, infine, per “la sua astuzia” […]. Per tutte queste qualità, Alberto è una specie di protettore per Levi nel campo, simile a Prometeo che protesse l’uomo dalla volontà distruttiva di Zeus. (Gordon 168)
Tuttavia, bisogna ricordare che il mondo del lager è un mondo in cui ogni forma ed ogni comportamento sono “viziati”, esasperati, deformati; e infatti Alberto-Prometeo non dona gratuitamente agli altri come invece fa l’eroe di Eschilo. Alberto non è un eroe tragico, non vi è pathos nella sua azione scenica; è invece personificazione delle abilità prometeiche. Sembra che Alberto agisca sfidando i Nazisti, in un gioco di abilità con cui vuole mostrare di possedere ancora la propria libertà a dispetto del loro potere: «Ho sempre visto, e ancora vedo in lui, la rara figura dell’uomo forte e mite, contro cui si spuntano le armi della notte» (1947, SQU, OI 51). Nel contesto del lager e della narrazione leviana Alberto è veramente un eroe, ma la sua generosità appare un effetto collaterale della titanica impresa di mantenersi umano e resistere al regime nazista. Paradossalmente, contropartita del fatto di avere tale funzione è che il personaggio risulta inevitabilmente idealizzato e “non-umano”, poiché non sembra soffrire per la propria condizione – e la sofferenza è l’unica certezza dell’esistenza (Un testamento, 1977, L, OII 147) – anzi, commentando il mito greco addirittura schernisce l’unico tratto “umano” che la tradizione, da Eschilo in poi, attribuisce a Prometeo: la filantropia.
Il personaggio di Alberto, però, non è certo interpretabile e giudicabile alla stregua delle altre figure disumanizzate del lager. La sua ipostatizzazione eroica è dovuta al fatto che la funzione del personaggio è legata al contesto scenico: in un ambientazione extra-ordinaria come quella del lager diventa importante affermare la possibilità di sfuggire all’ordine vigente, c’è bisogno di un Prometeo che usi il proprio ingegno – e non la forza e la violenza (kratos e bia), strumenti dei nazisti e di Zeus – per scovare quelle «sacche d’eccezione» (Il rito e il riso, 1974, AM, OII 798) nel sistema lager. In Eschilo, «sono la sottomissione al potere del destino e il suo riconoscimento che fanno del Titano un eroe da tragedia» (Calame, Prométhée généticien 62). Nell’opera di Levi, invece, parlando di quella «stagione diversa» (Cerio, 1974, SP, OI 862) che è stata Auschwitz, l’esigenza non è quella di rappresentare l’accettazione della condizione di prigionia, quanto piuttosto di evidenziare come, per sopravvivere, sia necessario non dimenticare ciò che è tipicamente umano, la speranza e l’ingegno donati da Prometeo-Alberto, e la dignità che deriva dal loro esercizio.
La valenza del mito in questo brano, però, non è circoscritta al passato. Nel momento in cui il tempo della narrazione ritorna al presente, in un mondo in cui Levi è un uomo libero, vi è un indizio testuale che ridimensiona il valore eroico di Alberto. Infatti, il motto nei confronti della “sciocchezza” di Prometeo («era stato sciocco a donare il fuoco agli uomini invece di venderlo»; Cerio, 1974, SP, OI 863) dissimula l’ironia di Levi, il quale simpatizza con la genuina generosità dell’eroe greco e controbatte alle parole di Alberto affermando che su di lui «[q]uesto discorso, della necessità di essere astuti» ha sempre avuto un «modesto risultato; anzi, [il] risultato paradosso di sviluppare in [lui] una pericolosa tendenza alla simbiosi con un autentico astuto, il quale ricavasse (o ritenesse di ricavare) dalla convivenza con [lui] vantaggi temporali o spirituali» (863). In questa prospettiva Alberto è un autentico astuto e le sue azioni non sono eroiche, perché motivate, almeno in parte, da interessi personali.
Il mito, dunque, si presenta stratificato e operante su più livelli discorsivi, non concedendo di stabilire una funzione univoca per esso. Le forme mitiche, anche attinte da narrazioni differenti (Esiodo e Eschilo, nel caso appena citato), confluendo in un nuovo racconto possono svolgere varie funzioni e interagire tra di loro grazie a quei processi di trasformazione che il nuovo contesto permette di attuare. Un’organizzazione retorica di questo tipo, in cui vi è una tensione tra le specifiche funzioni degli elementi della narrazione e la globale funzione etica del discorso, è riscontrabile anche in molti altri racconti. Per la complessità delle connessioni attivate dai temi affrontati, per la loro attualità nelle contingenze storiche in cui Levi viveva e per la ricchezza di sfumature delle qualità e delle azioni dell’eroe, il mito di Prometeo si offre come un’enciclopedia dotata di una notevole densità semiotica, la quale può quindi essere richiamata in una grande varietà di narrazioni.
Ho voluto soffermarmi su un esempio tratto da un racconto storico di Levi perché le caratteristiche riscontrabili in Alberto sono successivamente declinate anche nei racconti di finzione, in situazioni di volta in volta diverse: come attributi di uno o più personaggi, ponendo l’accento su qualità di volta in volta diverse, in alcuni casi esplorandone le potenzialità, in altri soppesandone le conseguenze. A volte è l’aspetto mitico dei doni prometeici ad essere valorizzato, in altre il racconto insiste sulla tragicità degli eroi in scena, ossia sulla personale assunzione di responsabilità del proprio destino. Prima di considerare le occorrenze del mito nei racconti di finzione, però, è utile riflettere su quali siano i doni di Prometeo agli umani, valutando il loro ruolo in relazione all’epistemologia e all’etica di Levi, in particolare in riferimento alla costruzione dialogica fra poiesi e antropopoiesi, fra creazione e creazione di sé.
2. Poiesi: homo faber
Una delle caratteristiche costitutive dell’uomo è di essere “fabbro”: secondo una delle «specificazioni» della natura umana date da Levi, «l’uomo è costruttore di recipienti; una specie che non ne costruisce, per definizione non è umana» e tale competenza tecnica è «indizio di due q...