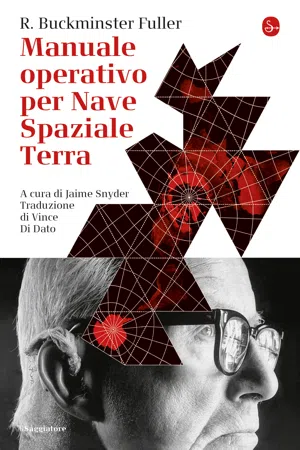![]()
1. Propensioni omnicomprensive
Sono entusiasta delle straordinarie e talvolta così tempestive ingegnosità umane. Se vi capita di naufragare e non ci sono più scialuppe, il coperchio di un pianoforte che galleggia vicino a voi può diventare un buon salvagente di fortuna. Ma questo non vuol dire che il miglior modo per progettare un salvagente sia quello di idearlo a forma di coperchio di pianoforte. Penso che siamo inclini ad accettare troppi coperchi di pianoforte – il risultato di scoperte fortuite del passato – come se costituissero l’unico modo per risolvere un certo problema. Il nostro cervello affronta esclusivamente casi particolari. La nostra mente, invece, è in grado di scoprire i princìpi generali validi senza eccezioni in ogni esperienza specifica, i quali, una volta individuati e fatti propri, daranno vantaggi apprezzabili in qualsiasi circostanza.
Poiché la nostra iniziativa spontanea è stata osteggiata, troppo spesso inavvertitamente, nella prima infanzia, di solito non abbiamo il coraggio di riflettere con cognizione di causa sulle nostre potenzialità. Troviamo più facile a livello sociale proseguire con le nostre ristrette, miopi specializzazioni, e lasciare ad altri – principalmente ai politici – il compito di risolvere i dilemmi comuni. Al contrario della spontanea tendenza alla limitazione tipica degli adulti, io farò del mio, spero «infantile», meglio per affrontare il maggior numero di problemi e pensare nel modo più lungimirante di cui sono capace, fermo restando che tutto questo potrebbe non portarci molto avanti nelle previsioni.
Ho studiato all’Accademia navale degli Stati Uniti, dove ho fatto pratica con le efficacissime arti della previsione, come la navigazione astronomica, il pilotaggio, la balistica e la logistica, oltre alla pionieristica e anticipatoria scienza progettuale alla base dell’antica maestria navale e da cui è derivata l’odierna teoria generale dei sistemi. Ricordo che nel 1927 cercai deliberatamente di capire quanto in avanti possiamo spingerci nel compiere previsioni affidabili sulla direzione intrapresa dall’umanità e di verificare, secondo i dati disponibili, come possiamo efficacemente interpretare i dettagli fisici di ciò che l’evoluzione globale potrebbe far presagire. Sono giunto alla conclusione che è possibile effettuare una previsione più o meno ragionevole su un lasso di tempo di circa venticinque anni. Il che sembra essere più o meno una generazione «di strumenti» industriali. In media, tutte le invenzioni paiono consumarsi nell’arco di venticinque anni, dopodiché i metalli vengono riutilizzati in modo nuovo e di solito più funzionale. Comunque, nel 1927 feci delle previsioni, la gran parte delle quali si spingevano solo fino al 1952, il che significava un quarto di secolo più avanti, ma alcune arrivavano fino al 1977, mezzo secolo dopo. Quando, nel 1927, qualcuno aveva occasione di domandarmi delle mie previsioni e io rispondevo che cosa mi sembrasse opportuno fare in vista degli anni cinquanta, sessanta e settanta, di solito mi veniva detto: «Molto divertente, lei è mille anni avanti rispetto al suo tempo». Avendo studiato i piccoli incrementi in cui possiamo pensare il nostro futuro, ero sorpreso della facilità con la quale il resto della società pareva essere in grado di vedere mille anni in avanti, quando io riuscivo a spingermi soltanto a un quarantesimo di quella distanza temporale. In seguito, iniziarono a dirmi che ero cent’anni avanti e ora mi dicono che sono leggermente in ritardo sui tempi. Ma ho imparato qualcosa sulla reazione comune a ciò che non è familiare e anche qualcosa sulla facilità e sulla rapidità con cui la realtà trasformata diviene così «naturale» da apparire ovvia da sempre. Così capii che le ultime reazioni erano state di quel tipo solo perché le evoluzioni che io avevo previsto erano avvenute in tempo.
Comunque, tutta questa esperienza mi ha infuso la fiducia necessaria per parlare di quel che potrebbe succedere nel prossimo quarto di secolo. Innanzitutto, mi piacerebbe esplorare alcuni dati fondamentali con cui ci confrontiamo in questo momento, come il fatto che più della metà dell’umanità viva ancora in una condizione di avvilente povertà, a cui è condannata in partenza, a meno che non venga cambiata la nostra situazione materiale globale.
Di certo non è una soluzione sfrattare i poveri, rimpiazzando le loro squallide abitazioni con edifici più costosi, che gli originali inquilini non possono permettersi di rioccupare. La nostra società adotta molti palliativi superficiali di questo tipo. E poiché le situazioni negative di ieri vengono così rimosse dal campo visivo rispetto alla loro posizione originaria, molti fingono con se stessi che i problemi siano stati risolti. Io sento che una delle ragioni per cui oggi stiamo lottando in maniera inadeguata, è che valutiamo i nostri costi su basi troppo limitate, e veniamo quindi poi sovrastati da costi inaspettati provocati dalla nostra scarsa visione.
Naturalmente, i nostri fallimenti sono la conseguenza di numerosi fattori, ma forse uno dei più importanti è il fatto che la nostra società agisce in base alla teoria per cui la specializzazione è la chiave del successo, non rendendosi conto che invece preclude la comprensione globale. Ciò significa che i potenzialmente integrabili vantaggi tecno-economici elaborati per la società dalla miriade di specializzazioni non sono integralmente compresi e pertanto non vengono attuati, o – quando succede – vengono applicati in modo negativo, per lo sviluppo di nuove armi, o nell’industria bellica.
Tutte le università sono state progressivamente organizzate per una specializzazione sempre più raffinata. La società presuppone che la specializzazione sia naturale, inevitabile e desiderabile. Eppure, osservando un bambino, notiamo che è interessato a qualunque cosa e spontaneamente apprende, comprende e coordina insieme un inesauribile numero di esperienze. I bambini sono un pubblico entusiasta e universale. Niente pare essere più importante, per la vita umana, quanto il voler capire tutto e connettere ogni cosa.
Una delle fondamentali priorità dell’umanità è quella di capire ed essere capiti. Tutte le altre creature viventi sono progettate per compiti altamente specializzati. In questo, l’essere umano pare unico: un comprensore comprensivo e coordinatore degli affari locali di Universo. Se lo schema generale della natura avesse richiesto la specializzazione all’essere umano, lo avrebbe costituito con un singolo occhio e un microscopio a esso incorporato.
Ciò che la natura voleva dall’essere umano, era che fosse adattabile verso molte, se non verso tutte, le direzioni; per questo ci ha donato una mente, insieme a un cervello che funge da centralina di coordinamento. La mente apprende e comprende i princìpi generali che governano il volo o l’immersione nel mare profondo, quindi gli umani possono indossare le ali o i polmoni acquatici, per poi levarseli quando non vengono utilizzati. L’uccello è grandemente ostacolato dalle sue ali quando tenta di camminare, così come il pesce non può uscire dal mare per addentrarsi sulla terra: perché uccelli e pesci sono esseri specializzati.
Certo, con le scienze comportamentali, stiamo giusto iniziando a comprendere qualcosa – ancora molto poco – su bambini e processi educativi. Avevamo pensato che i bambini fossero vuoti ricettacoli cerebrali in cui poter inculcare la saggezza metodicamente guadagnata dagli adulti, affinché i bambini diventassero a loro volta istruiti. Alla luce delle sperimentazioni moderne, non era una buona ipotesi di lavoro.
Poiché ogni nuova vita dimostra sempre propensioni omnicomprensive, mi piacerebbe sapere come mai abbiamo disatteso questa curiosità significativamente spontanea e globale comune a tutti i bambini, e nell’educazione ufficiale abbiamo deliberatamente istituito processi che portano solo a una ristretta specializzazione.
Non dobbiamo tornare indietro nella storia di molto per trovare la risposta. Arriviamo ai grandi, potenti uomini di spada, che sfruttavano la loro bravura fortunosamente e ambiziosamente, circondati dall’ignoranza abissale del consesso umano. Troviamo le prime società umane che si dibattevano in condizioni economiche tali per cui meno dell’1 per cento della popolazione globale sembrava in grado di vivere l’intero arco della propria aspettativa di vita. Questa misera prospettiva derivava da un’apparente inadeguatezza delle risorse vitali essenziali e dall’incapacità di una società ignorante di interagire con successo con l’ambiente, una società che per di più era dominata anche da istinti primordiali che portavano alla nascita involontaria di molti bambini. Tra loro c’erano leader scaltri che dicevano: «Seguitemi e ce la caveremo meglio degli altri». Fu il più potente e astuto di questi leader che, come vedremo, inventò e sviluppò la specializzazione.
Guardando la storia del percorso umano sulla Terra e osservando che tre quarti del globo è ricoperto d’acqua, è ovvio il motivo per cui gli umani – inconsapevoli che un giorno sarebbero riusciti a volare e a immergersi negli oceani con i sottomarini – concepivano se stessi esclusivamente come pedoni, come specialisti delle terre emerse.
Confinati su un quarto della superficie terrestre, è facile vedere come arrivarono a specializzarsi ulteriormente come agricoltori o cacciatori, oppure, guidati dai loro leader, come soldati. Meno della metà di questo 25 per cento della Terra era immediatamente favorevole allo sviluppo della vita umana. Perciò, nel corso della storia, il 99,9 per cento dell’umanità ha occupato solo il 10 per cento della superficie terrestre, risiedendo esclusivamente dove la possibilità di vivere risultava ovvia. Questo territorio favorevole non si trovava tutto insieme, ma era formato da una miriade di porzioni relativamente piccole ampiamente disperse sulla superficie dell’enorme sfera terrestre. Gli agglomerati isolati di umanità erano del tutto ignari dell’esistenza gli uni degli altri. Ed erano, allo stesso modo, ignari della vasta varietà di ambienti naturali molto diversi e della distribuzione delle risorse presenti in luoghi differenti da quelli in cui vivevano.
Ma esisteva un piccolo drappello di esseri umani che, gradualmente, attraverso il processo di invenzione e di sperimentazione, costruì e utilizzò, dapprima su fiumi locali, poi lungo le coste, quindi in mare aperto, zattere, piroghe, piccole barche e canoe a vela. Infine, progettò capienti vascelli da pesca dallo scafo centinato e con questi si avventurò in mare, per periodi progressivamente sempre più lunghi. Mettendo a punto navi via via più grandi e più adatte, i navigatori furono infine capaci di rimanere per mesi in mare aperto. Così, questi avventurieri finirono per trascorrere la loro vita in mare. Questo li portò inevitabilmente a viaggiare in tutto il mondo, verso rapide imprese generatrici di fortuna. E così essi divennero i primi uomini del cosmo.
Gli esseri umani capaci di solcare gli oceani dovevano essere anche straordinariamente bravi con la spada, sia sulla terra che in mare. Dovevano poi possedere una grande visione anticipatoria, grandi abilità nel progettare navi e conoscenze scientifiche originali, oltre a competenze matematiche applicate alla navigazione e tecniche che permettevano loro di muoversi nella nebbia, nella notte e nelle tempeste, tra i pericoli invisibili dati dalle rocce, dalle secche e dalle correnti. I grandi avventurieri del mare dovevano saper comandare gli umani dei loro possedimenti sulla terraferma, per ottenere le opere metallurgiche, di carpenteria, di teleria e di tutte le altre arti necessarie a produrre quegli enormi e complessi bastimenti. Dovevano stabilire la loro autorità e mantenerla, per disporre di adeguate provvigioni, fornite da cacciatori e agricoltori dei loro territori, per loro stessi e per tutti gli artigiani impegnati nella costruzione della nave. Ed ecco che la specializzazione fu enormemente amplificata sotto l’autorità suprema del visionario globale e del brillante coordinatore, del potente uomo di spada e avventuriero dei mari. Se la sua nave «rientrava» – il che significava, che tornava sana e salva da un viaggio durato lunghi anni – tutto il popolo nei suoi territori prosperava e il potere del leader ne risultava notevolmente amplificato.
Erano davvero pochi questi grandi uomini di potere. Ma, continuando a navigare, essi gradualmente scoprirono che le acque mettevano in connessione tutti i popoli e le terre del cosmo. Lo impararono all’insaputa dei loro marinai analfabeti che, quasi sempre, dopo essere stati colpiti in testa in una taverna e trascinati a bordo, si risvegliavano in mezzo al mare, dove vedevano solo un’immensità d’acqua e, senza cognizioni di navigazione, non avevano idea di quali rotte avessero percorso.
I padroni del mare presto scoprirono che le genti di ogni luogo visitato non sapevano nulla degli altri popoli. I grandi avventurieri si accorsero che le risorse della Terra erano distribuite in modo molto diseguale e compresero che, mettendo insieme diverse risorse disponibili a distanze remote tra loro, si completavano le une con le altre e potevano servire per produrre strumenti, servizi e beni di grande utilità e valore. Così, risorse di un luogo che prima sembravano essere di nessun valore, improvvisamente divennero di estrema importanza. Enorme ricchezza fu generata da ciò che gli avventurieri del mare potevano ricavare unendo le risorse e distribuendo i prodotti a stupiti e avidi compratori presenti in qualsiasi luogo della Terra. I capitani proprietari di navi si resero conto che, per la natura stessa del galleggiamento, con le loro imbarcazioni potevano trasportare carichi fantasticamente ingenti nelle loro stive, carichi così imponenti da non poter essere spostati sul dorso degli animali o sulla schiena degli umani. Per di più, i bastimenti potevano attraversare una baia o il mare, tracciando percorsi più brevi, in tempi molto inferiori a quelli necessari per seguire le coste o oltrepassare le montagne. Così, questi pochissimi padroni del cosmo acquatico divennero incalcolabilmente ricchi e potenti.
Per capire lo sviluppo della specializzazione intellettuale, che è il nostro primo obiettivo, dobbiamo indagare più a fondo le conoscenze globali dei leader del mare, contrapponendole alla miriade di specializzazioni manuali, fisiche e muscolari che venivano comandate dal loro intelletto e dalla loro maestria con la spada. I grandi avventurieri del mare pensavano sempre in termini di cosmo, poiché le acque del globo sono in continuità e ricoprono tre quarti del pianeta. Questo significa che prima dell’invenzione della trasmissione via cavo e via etere, il 99,9 per cento dell’umanità pensava solo in termini locali. Nonostante la nostra recente familiarità con lo sviluppo delle telecomunicazioni e la consapevolezza della Terra come di una totalità, noi stessi, nel 1969, siamo ancora organizzati a livello politico interamente in base a un’esclusiva e totalmente obsoleta separazione di sovranità.
Questa «sovranità» – imposta dall’alto con le armi –, la rivendicazione «nazionale» sugli esseri umani nati in differenti paesi porta a servitù ancora maggiori e ancor più rigorosamente specializzate, e a una classificazione di identità altamente individualizzate. Come conseguenza della «categorizzazione» schiavista, abbiamo le scientificamente illogiche e, come vedremo, spesso insensate domande «dove vivi?», «cosa sei?», «di che religione?», «di che razza?», «di che nazionalità?», domande ancora oggi ritenute logiche. Se, a partire dal ventunesimo secolo non sarà divenuto evidente all’umanità che si tratta di domande assurde e antievolutive, l’umanità stessa non vivrà ancora a lungo sulla Terra. Se non ne comprendete il perché, seguitemi con attenzione.
![]()
2. Origini della specializzazione
Naturalmente, dobbiamo ricercare le origini della specializzazione nelle pieghe della storia sperando, in questo modo, di correggere o eliminare i nostri ragionamenti errati. Possiamo affermare che, in media, un essere umano, prima del ventesimo secolo, poteva vedere circa un milionesimo della superficie del globo terrestre. Questa esperienza limitata fece sorgere un punto di vista locale e specializzato. Non sorprende che l’umanità pensasse che il mondo fosse piatto e nemmeno che credesse che questo piano esteso orizzontalmente proseguisse all’infinito. Nelle scuole di oggi insegniamo ancora ai nostri bambini che esistono piani e rette che continuano, incomprensibilmente, «per sempre» verso un insensato infinito. Questi punti di vista supersemplificati sono fuorvianti, oscuri e debilitanti, poiché precludono la possibilità di scoprire l’importanza delle nostre esperienze integrate.
Immersi in questa quotidianità che ostacolava il sapere e limitava l’umanità, i capitani-avventurieri-navigatori, padroni della storia e in possesso della conoscenza globale, si accorsero presto di essere in competizione soltanto con i fuorilegge, che a loro volta sapevano, o speravano di imparare con l’esperienza, «cos’è tutto questo». Io chiamo coloro che padroneggiavano i mari grandi fuorilegge o Grandi Pirati – GP –, semplicemente perché le leggi arbitrarie emanate o promulgate dagli umani per gli umani sulla terraferma non potevano essere applicate in modo efficace a chi stava oltre le coste, sul mare. Così, gli esseri umani del cosmo che vivevano sui mari erano intrinsecamente fuorilegge e le sole regole che potevano seguire – e che, di fatto, seguirono – erano le regole naturali, quelle leggi fisiche di Universo che, quando tempestose, erano spesso crudeli e devastanti. Il mare aperto, la nebbia e le rocce invisibili nella notte erano intransigenti.
La conseguenza fu che i Grandi Pirati si combatterono mortalmente a vicenda per decidere chi avrebbe controllato le immense strade del mare e, alla fine, il cosmo intero. Le battaglie furono ingaggiate dove l’umanità della terraferma non poteva vedere e la gran parte di chi veniva sconfitto si inabissava rimanendo ignoto agli storici. Coloro che continuarono a navigare e a prosperare, ci ri...