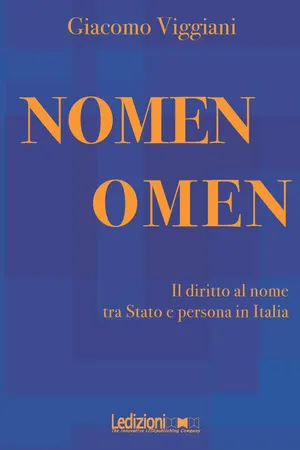
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
Nomen Omen
Informazioni su questo libro
Il diritto al nome appartiene oggi a pieno titolo al catalogo dei diritti della personalità. Come tale, non solo è uno strumento identificativo della persona, ma costituisce anche una parte essenziale e irrinunciabile della sua identità. In quanto diritto fondamentale, il nome è oggetto di protezione da parte di vari strumenti giuridici che, ad esempio, riconoscono il diritto di ogni persona a vedersi attribuito un nome e a poter preservare per tutta la vita l'identità così costituita attraverso di esso. Proprio per la sua pregnanza, il nome risulta però essere spesso anche oggetto di interessi contrapposti non sempre conciliabili, profilando questioni di notevole interesse giuridico; si pensi alla questione dall'attribuzione di un nome proprio non corrispondente al sesso, all'attribuzione di nomi propri ridicoli o vergognosi, o ancora all'annosa questione della trasmissione del cognome materno, sulla quale l'Italia rappresenta la "maglia nera" dell'Unione Europea.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
L’attribuzione del nome
Italia
«oggetto del diritto dell’individuo all’identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il nome che è per legge attribuito». Se dunque si può parlare di diritto al nome in relazione all’art. 22 Cost., specialmente se letto in combinato disposto con l’art. 2, esso non è né assoluto né svincolato dal contesto ordinamentale, ma anzi da esso ha la sua origine in quanto tale. Si mostrerà più avanti come lo scarto tra ordinamenti di common law e civil law in tema di nome risieda proprio nella differenza tra il diritto al nome come diritto alla libera scelta del nome e come diritto al nome per legge attribuito. Affermare che si ha diritto al solo nome che è per legge attribuito implica che la sua scelta è in qualche modo regolamentata e “guidata”, e dunque solo parzialmente libera2. Il procedimento di attribuzione è regolato dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 3963, (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), così come novellato dal d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54 (Norme in materia di disciplina del nome e del cognome).
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Indice
- Citazione
- Introduzione
- Il diritto al nome nel diritto sovranazionale e nella giurisprudenza internazionale ed europea
- Il diritto al nome in Italia
- L'attribuzione del nome
- Le controversie sull'attribuzione del nome proprio in Italia
- L'attribuzione del cognome materno in Italia
- Conclusioni
- Bibliografia
- Ringraziamenti
Domande frequenti
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app