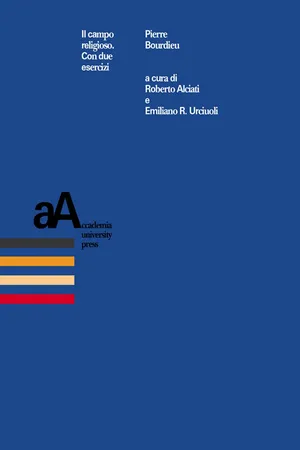Ricordare che tutto è storico non significa, come a volte ci si affretta a dire, professare un riduzionismo storicistico o sociologistico. Significa semplicemente rifiutarsi di sostituire al Dio creatore delle «verità e dei valori eterni” il Soggetto creatore e rendere alla storia, e alla società, ciò che è stato attribuito a una trascendenza o a un soggetto trascendentale. Significa, più precisamente, rinunciare alla mitologia del «creatore» increato.
[…]
Il personalismo ottiene la complicità immediata di tutti coloro che, volendosi pensare come “creatori” unici di singolarità, sono sempre pronti a intonare nuove variazioni sulla vecchia melopea conservatrice del chiuso e dell’aperto, del conformismo e dell’anticonformismo, o a reinventare, senza saperlo, l’opposizione costruita da Bergson contro Durkheim, tra «gli ordini dettati dalle esigenze sociali impersonali», e i «richiami lanciati alla coscienza di ciascuno da persone», santi, geni, eroi.
P. Bourdieu1
1. Il primo passo: la conversione del linguaggio
1I libri di Pierre Bourdieu non sono di facile lettura, né in originale né in traduzione. Anzi, si può dire che nel passaggio dal francese all’italiano (ancor di più a lingue non romanze) la vigilanza del traduttore e del lettore deve essere massima, quasi la stessa che si è abituati a prestare ai testi in lingue antiche o alla poesia. Il linguaggio bourdieusiano ha una sua originalità: si ripete con regolarità ed è possibile ricostruirne, a tratti, le mutazioni, gli assestamenti, che nel corso degli anni avvengono2. Prendiamo il caso della parola dénégation. Bourdieu ne fa un uso intenso ma ponderato, potremmo dire consapevole, tenendo conto, ad esempio, di quanto differisca da négation. Nel lessico francese della psicoanalisi, dénégation traduce la Verneinung freudiana: questa indica, per Freud, tanto la negazione logica (come nell’uso comune della parola in tedesco) quanto il fenomeno psicoanalitico del rifiuto inconscio di riconoscere una realtà. Freud però intendeva tenere insieme i due significati, ma come nella traduzione italiana delle sue opere essa è resa normalmente con «negazione», nella psicoanalisi francese, proprio per mettere in evidenza la peculiarità del fenomeno psicologico, viene quasi sempre tradotta con dénégation. Bourdieu segue quest’uso e dichiara esplicitamente di importare il termine direttamente dalla psicoanalisi, ritenendo che quando si smentisce e si rifiuta di riconoscere come vero un certo rapporto sociale (ad esempio, di dominio), in realtà, proprio con la smentita, lo si afferma3.
2Il traduttore italiano de Il senso pratico, Mauro Piras, avrebbe voluto mantenere uniformità nella traduzione, ma inspiegabili – in realtà spiegabilissime – decisioni redazionali hanno considerato «negazione» e «denegazione» sinonimi, generan do così una ingiustificata e disorientante discontinuità lessicale. La «Nota dei traduttori» (Anna Boschetti ed Emanuele Bottaro) all’edizione italiana de Le regole dell’arte invece precisa che i termini dénégation e méconnaissance sono stati resi sempre con «denegazione» e «misconoscimento»4.
3Questa attenzione al linguaggio va ascritta alla particolare sensibilità (e simpatia verso Bourdieu) dei traduttori, ma è anche il tributo a un principio epistemologico essenziale che guida la formazione universitaria e la ricerca successiva di Bourdieu: il linguaggio non nomina semplicemente le cose, esprimendo un contenuto o un senso, ma fa le cose, ovvero dà forma alla nostra percezione e rappresentazione del mondo:
Non si deve dimenticare che i rapporti di comunicazione per eccellenza, quali sono gli scambi linguistici, sono anche rapporti di potere simbolico in seno ai quali si attualizzano i rapporti di forza tra i locutori e i loro gruppi rispettivi. […] Una parte non irrilevante delle determinazioni, che formano la definizione pratica del senso, arriva al discorso automaticamente e dall’esterno. […] questa elaborazione particolare che tende a conferire al discorso proprietà distintive è qualcosa di percepito che esiste solo in relazione a soggetti percettori, dotati di quelle disposizioni diacritiche che permettono di fare distinzioni tra modi di dire diversi e arti di parlare distintive.5
4La nascita e l’evoluzione del sistema teorico bourdieusiano non possono quindi che essere ricostruite seguendo le tracce lasciate da alcune parole che, nella sua originale ricerca, diventano immediatamente concetti densi e qualificanti di un linguaggio speciale che si fa carico del difficile equilibrio fra esigenza di precisione e complessità di pensiero. Ma come la sovversione eretica sfrutta la possibilità di cambiare il mondo in cui viviamo cambiando la rappresentazione di questo mondo che contribuisce alla sua realtà, così anche «la postura radicalmente eterodossa rispetto ai tradizionali codici della disciplina sociologica»6, del suo modus operandi, del suo nomos, costituisce un autentico attacco alla gerarchia degli oggetti scientifici “legittimi” e, simultaneamente, al modo di descriverli attraverso il linguaggio proprio di ogni disciplina scientifica consacrata e riconosciuta. Più che di formazione universitaria e “spirito critico”, universalmente (e proprio per questo falsamente) considerato l’atout proprio dell’homo academicus, Bourdieu preferisce parlare di postura, la disposizione pratica verso la quotidianità:
Forse in questo caso il fatto di provenire dalle «classi» che alcuni amano definire «modeste» procura virtù che non vengono insegnate dai manuali di metodologia: la mancanza di qualsiasi disdegno per le minuzie dell’empiria, l’attenzione per gli oggetti umili, il rifiuto delle rotture clamorose e delle azioni spettacolari, l’aristocraticismo della descrizione che porta al disprezzo del brio e della brillantezza, tanto apprezzati dall’istituzione scolastica e premiati dai media.7
5Da questa disposizione trae origine anche la neolingua bourdieusiana, inevitabilmente come risultato della lotta tra ortodossia ed eterodossia8, cioè fra ciò che può e ciò che non può essere enunciato, dove il linguaggio accettato è quello dei dominanti i campi del sapere consacrato (la filosofia e la storia)9, mentre quello respinto è degradato a doxa, ovvero tutto ciò che si trova a essere accettato senza discussione né esame10. Questa divisione è per Bourdieu la sorgente inesauribile di ciò che chiama «l’effetto di teoria», ovvero la capacità da parte degli agenti – in questo caso gli uomini di studio – di imporre un principio di divisione che privilegia alcuni aspetti del reale e ne trascura altri. Tale principio di divisione parte necessariamente dal linguaggio.
2. Habitus e campo
6Sin dalle sue prime ricerche, Bourdieu si dedica con costanza alla definizione di un linguaggio nuovo per una sociologia che si faccia carico di studiare quegli aspetti del reale trascurati, ma, a suo avviso, essenziali per comprendere lo spazio sociale. La prima traccia di questa importante e infinita definizione data 1967 e porta il nome di habitus. In quell’anno, Bourdieu traduce per la collana «Les sens commun» delle Éditions de Minuit Gothic Architecture and Scholasticism di Erwin Panofsky, con l’aggiunta di una Postface11. Qui Bourdieu definisce per la prima volta questo concetto, partendo da Tommaso d’Aquino, colui che, sulla scia di Aristotele, ne fornisce una prima sistemazione filosofica. L’habitus è per Tommaso l’acquisizione delle virtù cristiane donate dal Sommo Bene come disposizioni durevoli e che danno corpo, una volta per tutte, all’antropologia (ovviamente fondata sulla teologia) cristiana12. Panofsky, partendo da questa definizione, rilegge l’affinità profonda dei modelli architettonici gotici come la riproduzione di questa disposizione ormai diventata abitudine mentale condivisa da parte dei costruttori, il principio unificatore di pratiche differenti. Lungi dal luogo comune dell’esprit du temps, Panofsky si interroga sui rapporti che si stabiliscono fra questa dispositio collettiva e lo spirito creatore del singolo, dell’artista. Qui si inserisce la critica di Bourdieu:
Opporre l’individualità alla collettività per meglio tutelare i diritti dell’individualità creatrice e i misteri della creazio ne personale, significa privarsi della scoperta della collettività nel cuore stesso dell’individualità, sottoforma di cultura – nel senso di coltura o di Bildung – o, per usare il linguaggio di Erwin Panofsky, di habitus mediante il quale il creatore partecipa della sua collettività e della sua epoca e che guida e dirige, a sua insaputa, i suoi atti creativi, in apparenza, i più unici.13
7L’habitus di Tommaso e Panofsky non è l’habitus di Bourdieu, ma il concetto, ormai sedimentato nel linguaggio filosofico corrente, si presta bene a essere rivitalizzato e diventare così un segno distintivo della sua neolingua sociologica.
8Molte sono le definizioni che Bourdieu darà del concetto di habitus nella sua ricca produzione successiva14. Potremmo dire che, col passare del tempo, la nozione si affina sempre più, alla ricerca quasi ossessiva della descrizione più inclusiva possibile e al contempo più dinamica:
L’habitus non è affatto un principio meccanico d’azione o, più esattamente, di reazione (al modo di un arco riflesso). È spontaneità condizionata e limitata. È quel principio autonomo che fa sì che l’azione non sia semplicemente una reazione immediata a una realtà grezza, ma una “risposta” intelligente a un aspetto attivamente selezionato del reale: legato a una storia gravida di futuro probabile, l’habitus è inerzia, la traccia del percorso passato, che gli agenti oppongono alle forze immediate del campo, e che fa sì che le loro strategie non possano venir dedotte direttamente né dalla posizione né dalla situazione immediate.15
9In altre parole, l’habitus è la capacità pratica di sapere come e cosa fare al momento opportuno, è il “senso del gioco”, ovvero il gioco sociale incorporato, diventato natura16. In questo senso, pertanto, non è un principio d’azione monolitico, immutabile, fatale ed esclusivo, bensì esso stesso generatore di azioni la cui parte d’apertura, d’incertezza, d’improvvisazione è grande: dipende dalla volontà dell’agente di assecondare o meno le regole del gioco17. Grazie a tale concetto si possono descrivere i comportamenti degli agenti, siano singoli o gruppi, come un insieme di pratiche, frutto, appunto, di un habitus particolare.
10Da qui, un insegnamento di metodo: si parte dall’opus operatum strutturalista e dal modus operandi marxista per trovare la sintesi che li superi entrambi. Ma una terza via di questo tipo non può che darsi in una sintesi dove tesi e antitesi si mantengono, sia pur spogliate sino al loro nucleo irriducibile. Questa costante tensione, questa dualità è l’habitus. E altrettanto duale è lo spazio sociale, la storia collettiva, sempre generata dall’adattamento «tra strutture soggettive (cose, istituzioni) e strutture incorporate (disposizioni, habitus)»18. In altre parole, la società si fa corpo attraverso l’habitus, struttura strutturata e strutturante19. Se la parte statica dell’habitus può essere paragonata all’abitudine, quella ripetizione meccanica, automatica, riproduttiva di un’azione, la parte, per così dire, dinamica, ha una forza generatrice. La coesistenza di que sti due momenti, apparentemente contrari l’uno all’altro, fa dell’habitus una nozione complessa, all’incrocio fra biologico, psicologico e sociale, che consente però di circoscrivere e individuare la zona grigia dove individuo e società, libertà e determinismo, soggettività e oggettività si incontrano.
11La società è però sempre organizzata, sia essa semplice o complessa, in spazi che Bourdieu chiama campi. Accanto ad habitus, il secondo concetto centrale del sistema teorico bourdieusiano è appunto quello di campo. Questi soli due concetti consentono a Bourdieu di muoversi disinvoltamente fra i molti oggetti d’indagine della sua lunga ricerca sociologica (sistema ...