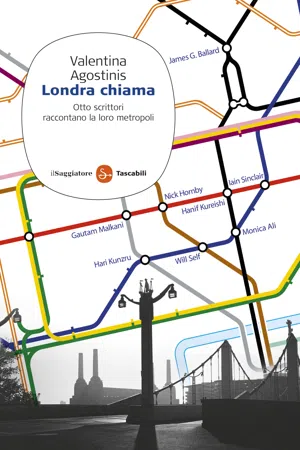![]()
James G. Ballard
Nei sobborghi del futuro
Lontane dalla vita febbrile della metropoli, che mette a dura prova le sinapsi umane, le cittadine satellite che sonnecchiavano protette dalla M25 erano praticamente un’invenzione dell’industria pubblicitaria. O almeno così amavano pensare gli account executive come me. Avremmo potuto credere fino all’ultimo giorno della nostra vita che quei posti erano trasfigurati dai prodotti che vendevamo loro, da marchi e loghi che davano un senso alla loro esistenza. Eppure, in qualche modo si ribellavano, diventavano eleganti e sicuri, il vero centro della nazione, tenendoci per sempre a distanza. James G. Ballard, Kingdom Come, 2006
Londra potremmo immaginarcela come un cuore pulsante, con arterie che pompano il flusso delle auto diramandosi in un sistema circolatorio che, attraversandoli, modifica i tessuti circostanti. La città è al centro di un organismo che vive grazie ai suoi battiti, ma i cui impulsi si fanno più deboli quanto più ci si allarga all’esterno, verso i margini, dove la vita si raggruma lungo le vie di scorrimento, come un tempo si addensava sulle rive del Tamigi (da cui prende il nome la campagna a ovest della metropoli, la Thames Valley). La parte più consistente di questo sistema circolatorio oggi è la M25, un anello che circonda Londra come l’orbita di un pianeta attorno alla sua stella. La M25 non è solo uno degli anelli stradali più lunghi al mondo, con le sue 117 miglia (188 chilometri, seconda in Europa solo alla Bundesautobahn 10 di Berlino, più lunga di 8 chilometri), ma detiene con il Boulevard Périphérique di Parigi anche il record dell’anello più trafficato del vecchio continente. Sul suo asfalto un movimento circolare continuo di automobili (un picco massimo di 200mila veicoli è stato registrato nello svincolo più trafficato, quello per l’aeroporto di Heathrow), un gigantesco fiume di metallo che gira su se stesso e a tratti si annoda con le arterie che arrivano dal centro per deviare il flusso all’esterno, verso il Nord e il Sudovest del paese, o per alimentarlo in senso opposto sugli svincoli da cui si raggiungono le varie zone della metropoli. È un sistema che ha affascinato molti artisti londinesi, e in alcuni casi quella per l’anello orbitale, con tutti i suoi significati di frontiera spazio-temporale, si è trasformata in una vera e propria ossessione. Lo scrittore Iain Sinclair vi ha camminato intorno per un anno, raccogliendo le storie di chi vive o ha vissuto in quelle periferie, ascoltando gli echi lontani di una letteratura che in quei luoghi ha iniettato dosi potenti di immaginario, raccontando in un gioco di rimandi tra passato e presente anche i cinismi e le brutture che la M25 si è portata dietro, mutando radicalmente non solo la geografia, ma le culture dell’intera area.
«The world’s biggest car park», «the road to hell» sono solo alcuni dei termini coniati per la M25. L’anello «infernale» è finito anche in un romanzo di fantascienza, Buona apocalisse a tutti! (Good Omens, 1990) di Neil Gaiman e Terry Pratchett, dove il suo percorso circolare è diventato un sigillo demoniaco da leggere dallo spazio. La cultura rave alla fine degli anni ottanta, con il suo gusto per la suburbia postindustriale, ha visto invece nell’autostrada attorno alla metropoli il sistema per far circolare pasticche e ravers verso gli eventi semiclandestini, e non a caso Orbital è anche il nome che si è dato nel 1989, in «omaggio» alla M25, il duo dei fratelli Phil e Paul Hartnoll, considerati geni della techno.
La M25 ha un punto debole, ed è quello in cui si spezza temporaneamente nell’East End, dove il flusso verso nord si sposta su una superstrada a pedaggio, la A282, che su due tunnell attraversa il Tamigi, mentre quello verso sud percorre il Queen Elizabeth ii Bridge, un ponte sospeso lungo 812 metri.
Oltre e lungo tutto il perimetro dell’anello si trova la Green Belt, una cintura verde in cui dalla metà degli anni cinquanta è vietato edificare per impedire l’allargamento eccessivo e caotico della metropoli, imperativo ormai sempre più disatteso. È sulla cintura infatti che i costruttori continuano a mangiucchiare brani di campagna per costruire nuove cittadine residenziali. E si trova sul territorio teoricamente non edificabile il nuovo quartier generale di Vodafone, a nord della cittadina di Newbury, così come il terminal 5 dell’aeroporto di Heathrow, inaugurato nella primavera del 2008. Un’opera faraonica, una cattedrale di vetro e acciaio firmata dall’architetto del Beaubourg, Richard Rogers, destinata a cambiare totalmente l’area a ovest di Londra. Il frutto, si legge sui comunicati degli ambientalisti, del lobbismo tra il governo Blair e la Baa, la società di gestione aeroportuale, grande sponsor del Labour (poi passata nel 2006 nella mani del colosso spagnolo Grupo Ferrovial). I verdi considerano come un pugno allo stomaco, un vero e proprio scempio, l’allargamento della M25 completato alla fine del 2005, che ha portato da 6 a 12 il numero delle corsie tra le uscite 12 e 15, per agevolare il flusso delle auto nei pressi dell’aeroporto.
Contro l’impatto del traffico aereo, gli ambientalisti di Climate Rush e Plane Stupid, appoggiati da molti residenti, non fanno mancare azioni di una certa eco mediatica per dimostrare la loro opposizione all’apertura di un sesto terminal e una terza pista di decollo e atterraggio, previsti dal governo Brown per il 2020 (ma che il leader dei conservatori David Cameron, e probabile nuovo premier alle elezioni politiche del 2010, non vuole).
Per lo scrittore James G. Ballard i territori lungo le vie di scorrimento che servono Londra, con la cultura che vi è nata nel decennio della grande trasformazione thatcheriana del paese (l’inaugurazione della M25 è stata festeggiata alla presenza della Lady di ferro il 29 ottobre 1986) rappresentano la vera Inghilterra contemporanea. È una cultura dominata dall’autostrada, profondamente condizionata dall’automobile, il cui sviluppo è stato a lungo scrutato da Ballard con lo stesso scrupolo di uno scienziato davanti all’insorgenza di un inquietante virus. Con Crash, il romanzo uscito nel 1973, lo scrittore elaborava una metafora di spaventoso realismo, in cui l’automobile è insieme il simbolo sessuale e il frutto tecnologico più significativo della vita dell’uomo contemporaneo. Qualcosa che ha portato, secondo le sue parole «a un cataclisma pandemico istituzionalizzato in tutte le società industriali: un cataclisma che ogni anno uccide centinaia di migliaia di persone e ne ferisce milioni». In quello che è forse il suo romanzo più cupo, lo scontro automobilistico è visto come «un sinistro presagio di un orrendo connubio tra sesso e tecnologia». Idee che si sono trasformate in visioni livide e potenti, nel film che il regista David Cronenberg, ugualmente interessato alla violenza contemporanea, ha tratto dal libro nel 1996.
Nella sua recente autobiografia I miracoli della vita (Miracles of Life, 2008) Ballard ha raccontato la genesi di Crash, il passaggio dall’idea alla sua realizzazione, che è avvenuta attraverso una bizzarra esperienza artistica. Il New Arts Laboratory, uno spazio alternativo londinese ricavato da una ex fabbrica di medicinali, all’uscita di La mostra delle atrocità (The Atrocity Exhibition) pubblicato dallo scrittore nel 1969, gli aveva chiesto di contribuire con un’opera e gli aveva messo a disposizione la galleria per un mese. Ballard decise di approfittare dell’occasione per testare le sue idee sui legami inconsci tra il sesso e l’incidente automobilistico, portando in galleria alcune auto semidistrutte, dopo averle recuperate in uno sfasciacarrozze a nord di Londra: una vera e propria installazione artistica. Per un mese tre grosse auto deformate da qualche fatale crash avevano fatto mostra di sé al New Arts, suscitando un bel trambusto. In quanto al test, le ipotesi dello scrittore erano state tutte confermate, fin dalla prima sera, quando all’inaugurazione si erano presentati molti giornalisti e tutto il mondo alternativo londinese: «C’era molta tensione in giro, come se tutti si sentissero minacciati da qualche allarme interno. Nessuno avrebbe notato quelle automobili se fossero state parcheggiate nella strada lì davanti, ma sotto le luci uniformi della galleria quei veicoli danneggiati sembravano una provocazione e creavano turbamento». Una giornalista di New Society, indignata, fu trascinata via a forza per impedirle di assalire l’autore di tanto scandalo, e durante tutto il periodo della mostra le auto venivano incessantemente attaccate, vilipese e perfino imbrattate di vernice bianca (questo a opera di un gruppo di Hare Krishna). Qualcosa di simile sarebbe successo anche al famoso letto di Tracey Emin alla Tate Britain qualche decennio più tardi, e forse per ragioni inconsce non molto estranee alla «sessualità traumatica» delle auto di Ballard.
Crash, il romanzo, si era portato dietro un potere oscuro: lo scrittore due settimane dopo la conclusione del libro, era rimasto coinvolto in un incidente automobilistico e aveva rischiato seriamente la vita. Era uscito però incolume dalla sua Ford Zephyr orribilmente sfregiata, e da allora non gli era accaduto più nulla. «Credo che Crash più che un inno alla morte sia un tentativo di placare la morte, di corrompere il carnefice che attende tutti noi in un tranquillo giardino vicino», scrive in I miracoli della vita.
Nell’estate del 1999 avevo incontrato Ballard nel bar dell’Hilton Hotel, nei pressi di Holland Park, a Londra, non avendo la possibilità di raggiungerlo nella sua casa a Shepperton, e in quell’occasione aveva insistito molto sull’oscuro piacere che viene dal guardare la violenza.
«Provi a guardare per ore delle soap opera in tv e poi passi a dei film come Psycho o Blue Velvet, opere che toccano corde profonde, non le solite sparatorie o corse in macchina, e sentirai subito il cuore che comincia a pompare. Nel mondo in cui viviamo non ci è data alcuna possibilità di esprimere le nostre emozioni più “antiche” perciò, quando raramente succede, ci si rende conto che hanno un effetto dirompente sulla nostra vita.» Con la sconcertante, fredda pacatezza di uno studioso di laboratorio, impegnato a spiegare l’avanzata di una nuova patologia collettiva, aveva proseguito: «Con i sistemi della realtà virtuale che stanno arrivando, potremo avere accesso a un mondo artificiale in cui si potrà “giocare” con la propria psicopatologia. È spaventoso! Potremo fare tutti i giochi, anche i più estremi, senza pagare alcun prezzo».
La cittadina di Shepperton, dove Ballard ha vissuto per quasi mezzo secolo, è la postazione da cui ha potuto seguire, nella valle del Tamigi e lungo la M4 che congiunge Londra all’aeroporto di Heathrow a ovest della M25, la vita dei nuovi insediamenti residenziali, luoghi fisicamente attraenti dove regnano l’artificio e una dipendenza assoluta dall’automobile. Nel suo romanzo Regno a venire, lo scrittore racconta ciò che potrebbe succedere a Brooklands, «una cittadina come tante, tra Londra e l’aeroporto di Heathrow», in seguito all’omicidio di un uomo da parte di un cecchino nascosto nel Metro-Center, il gigantesco centro commerciale che, oltre a negozi, alberghi, piscine e centri sportivi, ospita una tv via cavo con un palinsesto a base di pubblicità, football, hockey e rugby. Consumismo sfrenato, fanatismo, hooliganismo e uno strano e perverso nazionalismo danno come risultato un mix dal preoccupante sapore fascistoide. In questo avamposto umano malato non può mancare un razzismo rozzo e volgare, che colpisce gli immigrati di origine asiatica. Brooklands è il luogo immaginario ispirato alle reali new towns della valle del Tamigi, dove Ballard ha visto concentrarsi tutti gli incubi dell’Inghilterra contemporanea, compreso il terrore per una violenza dirompente e casuale, che può colpire all’improvviso nei vagoni della metropolitana, in un doubledecker o in un centro commerciale. Nel suo romanzo Millennium people (2003), scoppia una bomba proprio nell’aeroporto di Heathrow per mano di terroristi appartenenti a una classe media che si sta rivoltando contro il sistema.
Il ritorno visivo di questi nuovi territori sociali è dominato da una luce plumbea, e non assomiglia a niente di ciò che si è visto nel passato: non c’è storia in questi sobborghi residenziali, né una continuità temporale con la vita della classe media urbana dei decenni precedenti. L’unica attività che permette agli individui di comunicare tra loro, in un’ambiente privo di punti di riferimento sociali e culturali, è il consumo sfrenato delle merci.
La visione di Ballard è netta, senza sbavature nostalgiche o sentimentali. È una cruda analisi dei fondamenti su cui poggia una nuova dimensione dell’esistenza umana.
«Questi luoghi sono totalmente privi di quelli che io chiamo “elementi stabilizzatori” dal punto di vista sociale, e che caratterizzano invece le piccole città costruite secoli fa: chiese, scuole, club o centri dove si fa vita comunitaria, agenzie di collocamento dove ci si mette in coda per trovare lavoro. Queste nuove città non hanno né una biblioteca, né musei o gallerie d’arte dove sia possibile guardare, per esempio, reperti archeologici d’epoca romana. Ogni genere di riferimento al passato è cancellato. Ci sono solo case, appartamenti e grandi centri commerciali. Non c’è alcuna stabilità, non c’è senso del passato né del futuro, la gente abita solo un eterno presente. Gli individui, per andare al lavoro, tutte le mattine imboccano l’autostrada e guidano per una ventina di miglia. In Inghilterra, e anche in Italia, ci sono città famose per un prodotto tipico, per esempio il prosciutto di Parma, o un artigianato particolare, o un’attività industriale in cui quella comunità eccelle. Sono tradizioni che danno una identità alle città. In queste new towns non esiste niente di tutto questo. Abbiamo un panorama sociale molto diverso, che è raggelante e molto pericoloso. Perché la sua fragilità è tale da renderlo disponibile a ogni genere di manipolazioni. Non è successo ancora, ma potrebbe succedere.»
Questo era stato il suo esordio: durante l’intervista telefonica, cercavo di immaginare la stanza in cui scriveva da quarantasette anni (la foto del suo studio sarebbe comparsa sul Guardian, nella rubrica «Writers’ rooms», il 10 marzo 2007). Lo spazio della sua creatività quotidiana era dominato dall’enorme quadro – una copia dell’originale distrutto nel 1940 durante il Blitz – La violazione di Paul Delvaux: «Non smetto mai di guardare questo dipinto e le sue due donne belle e misteriose. Qualche volta penso di viverci dentro e di risvegliarmi al mattino rinfrancato. Un sogno molto maschile», scriveva lo scrittore nel breve articolo che accompagnava l’immagine. Appoggiata alla cornice del quadro, una cartolina che riproduceva La persistenza della memoria di Salvador Dalí, «la più grande opera pittorica del ventesimo secolo» secondo Ballard. In fila uno accanto all’altro lungo il bordo del caminetto, i volti dei suoi quattro nipoti, fotografie senza tempo, affacciate sulla sedia dello scrittore, una vecchia sedia da sala da pranzo imbottita e rivestita di pelle scura che la madre si era portata dalla Cina «e su cui probabilmente ci sono stato seduto da bambino». E poi il tavolo quadrato di legno massiccio, con accanto il cestino ricolmo di fogli, una testimonianza della fisicità della sua scrittura, ribelle al computer. «Scrivo le prime stesure dei miei libri a mano, e poi le ribatto con una vecchia macchina elettrica. Ho sempre fatto resistenza al computer, diffido di tutto quel mondo.» Conoscendo la sua rara capacità di interpretare il futuro tecnologico e di prevederne le ricadute sociali nella vita delle persone fin dentro la loro psiche, questa sua affermazione può lasciare perplessi. Il computer è cosa scontata come l’auto, i centri commerciali e i nuovi sobborghi residenziali, en...