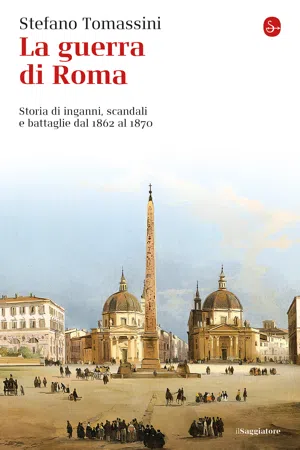![]()
PARTE TERZA
Tempo di guerre
![]()
Vacanza romana
Fra l’agosto e il settembre del 1865 Pier Carlo Boggio, accompagnato dalla moglie, andò a Roma e vi restò circa un mese. Era la prima volta e sarebbe rimasta l’ultima. Era appena arrivato e già scriveva a un suo amico, l’avvocato Antonio Cauccino:
Roma non ha mica per nulla cessato d’essere la Roma dei Cesari per diventar la Roma dei Papi – e nella Roma dei Papi nei giorni di domenica l’ufficio postale è aperto, e gli impiegati ci stanno a vendere i francobolli… ma le lettere NON si distribuiscono, e quelle che si impostano NON PARTONO!
Ciò malgrado però la Roma dei Papi val quella dei Cesari – e fra tutte e due fanno una città che è senza rivale al mondo.
Forse il dì che diventasse la Roma dell’Italia acquisterebbe un nuovo merito – quello di essere anche una città pulita e civile – che ora non è.
E per quanto io sia appassionato di tutto ciò che è antico – a tal segno che non mi so dar pace s’abbia ad atterrare qualche tratto delle mura di Firenze, e quasi vorrei conservata fin la tettoia dei Pisani in piazza della Signoria, qui in Roma mi sentirei il coraggio di dar mano al piccone e farmi capo demolitore, perché frammezzo ed anzi il più delle volte sopra i resti magnifici di una epoca senza pari, e a fianco le costruzioni moderne rese immortali dall’impronta di Michelangiolo e Raffaello, […] a fianco, dico, le più meravigliose creazioni del genio architettonico moderno, le toccherebbe di vedere, se venisse qui, le catapecchie le più orride, e quel ch’è peggio, le più infette, le più sozze che si possano immaginare. Qui ci sta un palazzo colossale, il Farnese per esempio, o il Corsini, o il Torlonia – ai lati, in faccia, ella vede sventolare su corde tirate, se occorra, da un capo all’altro della via, certe pezzuole e certi cenci che in ogni città civile sogliono essere un segreto fra chi li adopera e il lavandaio. Ma qui malgrado il presidio che ci tiene Napoleone III, l’aurea massima di Napoleone I sul linge sale è lettera morta – forse in segno di protesta che non so se io debba dire papalina o garibaldina – perché il presidio francese non lo credo meno in uggia a quelli per i quali vi sta, che non a quelli per cagione dei quali è venuto.
E poi faceva a Cauccino la solita rivelazione: che Roma puzzava, ancora e sempre puzzava.
Che cosa veniva a fare Boggio a Roma? Prima di tutto, forse, poteva essere una vacanza: la legislatura che si era chiusa – la prima del Regno d’Italia, ma si continuava a contarle di seguito al Regno di Sardegna, per cui risultava essere già l’ottava – era stata particolarmente faticosa per il deputato piemontese, che probabilmente insieme con la moglie sentiva di meritarsi un po’ di riposo e di svago. La vacanza poteva anche essere in qualche modo un pellegrinaggio: «Fautore antico e convinto della più larga ed assoluta libertà di coscienza» avrebbe scritto di lì a poco «non ho però arrossito mai di essere e professarmi cattolico». Mi è già capitato di accennare al fatto che Pier Carlo Boggio era massone, affiliato dal 1860 alla Loggia Ausonia di Torino. Capisco che si possa cogliere in questo una contraddizione: ma Boggio non era il primo e neppure l’ultimo che ci si trovava e, a quanto pare, non se ne crucciava troppo.
Politico, giurista di chiara fama, giornalista, Pier Carlo Boggio naturalmente non si contentava della vacanza e del pellegrinaggio; a muoverlo c’erano anche la curiosità propria del mestiere e gli ultimi eventi politici che più gli erano dispiaciuti: la Convenzione di settembre, il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, il fallimento della missione Vegezzi a Roma. Il fine del viaggio era dunque anche politico e, per certi notevoli aspetti, professionale, in quanto ne risultò un libro pubblicato nel successivo novembre a Torino. Il titolo era piuttosto impegnativo: La questione romana studiata in Roma. Per un terzo, grosso modo, parlava di Roma e dei romani, per gli altri due terzi della questione romana e delle sue possibili soluzioni. Era come se Pier Carlo Boggio avesse voluto rifare il percorso compiuto dal francese Edmond About cinque, sei anni prima con La question romaine e Rome contemporaine. La differenza era che Boggio aveva più nettamente spartito gli argomenti, forse perché, diversamente dal collega francese, non si sentiva di esibire conoscenze approfondite avendovi trascorso non più di un mese, ma soprattutto perché il deputato torinese sentiva l’urgenza, molto pratica, d’una soluzione della questione romana e aveva anche da sfogarsi di tutte le cose che non gli erano piaciute e continuavano a non piacergli. Il risultato era pregevole – Boggio era abile a scrivere, quanto a parlare – e la lettura era e può essere ancora godibile.
A chiederglielo, avrebbe probabilmente negato: ma la cosa più divertente è quanto ce l’avesse con Firenze e con i fiorentini. Per esempio, parlando del clima:
Ho abitato Firenze in agosto, ed ho in agosto abitato Roma. Il termometro saliva più alto nella città eterna che non nella neo-capitale.
Ciò malgrado sperimentai più sano e più gradevole il soggiorno di Roma – e sì che abitavo appiè del Pincio, in piazza di Spagna, quartiere dichiarato, non so perché, uno dei meno salubri di Roma in estate.
Se uscite al sole d’agosto in Roma, vi cuoce le cervella, ma l’aria è elastica, e la sera e il mattino respirate.
A vece che in Firenze un’afa continua vi toglie il respiro, un sudore incessante vi procura un bagno turco in permanenza, il quale però, lungi dall’afforzarvi e produrre i miracolosi effetti patologici e fisiologici che dai vari bagni turchi si ripromette l’egregio mio amico e collega di Parlamento, Davide Urqhart, vi spossa, vi sfibra, vi snerva per modo che mai non ho capito così bene il governo lemme lemme dei Lorenesi, e il temperamento linfatico dei Fiorentini, come dopo avere abitato Firenze.
Lo scozzese David Urquhart era stato diplomatico e parlamentare, oltre che gran viaggiatore. La sua prima passione era il diritto internazionale, applicato alla politica, ma qui Boggio lo citava per la seconda: dai suoi soggiorni in Turchia aveva portato a Londra e nell’Europa occidentale la moda dei bagni turchi.
Boggio ci ha fatto già sapere che Firenze d’estate gli leva il respiro, che i fiorentini hanno «il temperamento linfatico». Che resta da dire? Che non si può soffrire il modo che hanno di parlare. I romani invece…
I Romani non hanno dialetto ma parlano con elegante semplicità l’italiano, salvo qualche neologismo, e lo pronunciano con limpida naturalezza, immuni affatto da quella stomachevole aspirazione colla quale lo deturpa il Toscano.
Come Roma, così i romani sono stati per Boggio una sorpresa gradita, forse anche cercata, a remissione del fastidio di dover intanto tornare a Firenze per l’apertura del Parlamento.
Tante volte mi si era detto che infinito è in Roma il numero di coloro i quali vivono delle largizioni e degli abusi della Corte Pontificia, che quasi mi ero lasciato persuadere fosse pur qualche cosa di vero nelle parole così asseverantemente pronunciate dal Petruccelli alla Camera, malgrado le energiche smentite loro date dai rappresentanti della emigrazione romana.
Ed appunto perché questa emigrazione è molto numerosa, mi parea tanto più probabile fosse stremato assai il numero dei liberali unitari rimasti in Roma.
Ho avuto campo a largamente ricredermi durante il mio soggiorno in Roma.
Alla pagina seguente ecco già il primo accenno del nostro autore all’idea che si è fatto in testa per risolvere la questione romana:
La immensa maggioranza dei Romani è francamente unitaria costituzionale – ossia desidera l’Italia una, colla monarchia costituzionale –
Desidera l’unione di Roma all’Italia –
Amerebbe assai che questa unione facesse di Roma la capitale della Nazione –
Si rassegnerebbe tuttavia ad attendere per un qualche tempo questo pieno complemento delle sue aspirazioni, e si acconcerebbe, nell’epoca di transazione, anche allo spediente di un governo municipale romano, se di tal maniera potesse agevolarsi la soluzione delle presenti difficoltà mediante la riconciliazione tra il Papato e la Italia.
Mi sono fermato un attimo su quella parola, «transazione»: ho pensato che potesse essere un errore. Magari Boggio aveva scritto «nell’epoca di transizione», e il tipografo s’era sbagliato e aveva messo una a al posto della i. Poi mi sono convinto che mi sbagliavo io: Boggio diceva proprio transazione, riferendosi al fatto che quell’epoca che doveva venire, e venire presto, doveva appunto servire alla trattativa, al compromesso, all’accordo, alla conciliazione fra l’Italia e la Santa Sede. Era questa in sostanza la differenza fra la teoria sua, di Boggio, e l’altra enunciata da tempo da Massimo d’Azeglio. Per il marchese Roma poteva insieme riconoscersi italiana e rimanere del papa nei secoli dei secoli: in fondo non c’era altra ragione perché fosse eterna. Per Boggio poteva restare del papa giusto il tempo che sarebbe servito perché il papa e il re si mettessero finalmente d’accordo. D’altronde non era stato proprio Pio IX a fare il primo passo con la sua lettera a Vittorio Emanuele? Salto quasi cento pagine a vado a leggere ciò che Boggio dice del fallimento della missione di Francesco Saverio Vegezzi:
Oramai non è chi ignori come i nostri ministri fossero divisi in due campi – l’uno di essi voleva, e seriamente voleva che si trattasse con Roma; l’altro credeva pericoloso, o almeno inopportuno ogni accordo.
Di qui le esitanze e le contraddizioni – di qui istruzioni date e ritolte, formulate a un modo e interpretate in un altro – di qui indugi e scrupoli e difficoltà sempre rinascenti, insino a che tutto si sciolse in nulla.
[…]
La verità è che alla maggioranza del Consiglio dei ministri parve pericoloso ed inopportuno ogni accordo col Papa prima delle elezioni che già allora si sapevano imminenti, – e le trattative, per volontà del Governo italiano, andarono rotte.
Ma il modo stesso col quale ebbero termine, lascia lo addentellato a ripigliarle e proseguirle, quando ciò paia opportuno e conveniente: l’udienza di congedo data dal Papa al nostro inviato colle forme più solenni e insieme più cortesi, era per se medesima un invito al ritorno con intenzioni migliori, e il contegno conciliante tenuto da allora in poi dal Santo Padre verso il Regno d’Italia, è pegno sicuro della possibilità d’intenderci.
Che cosa dava a Boggio il motivo per avere tanta fiducia nella possibilità di riprendere le trattative? C’è da dire che aveva avuto modo di parlare a lungo con Pio IX, il quale gli aveva concesso un paio di udienze. C’è da aggiungere che da quello che l’autore riporta delle parole del papa emerge sì una grande cordialità, che era abituale nell’atteggiamento di Pio IX, specialmente con chi venisse dall’Italia del Nord e avesse a che fare con le vicende nazionali, emerge il tratto di spirito, d’ironia, che gli era altrettanto tipico, ma non si cava nulla di veramente nuovo rispetto ai problemi che facevano ostacolo a qualsiasi idea di conciliazione. «Il carattere affatto privato di quei convegni» spiega Boggio «non mi consente di entrare in troppi particolari; ma certo mi è lecito dire che dopo di essi mi sono convinto che il Governo italiano può venire ad una conciliazione onorevole per ambe le parti colla Santa Sede, senzaché ciò gli debba costare la rinuncia ad alcuna delle legittime aspirazioni per il bene presente ed avvenire della Nazione.» Dopo di che non esce nulla di veramente risolutivo.
Proverò a riassumere la parte virgolettata della conversazione fra l’anziano pontefice e il deputato, che non aveva ancora quarant’anni. L’udienza era a Castelgandolfo: Boggio aveva inviato la richiesta a monsignor Edoardo Borromeo Arese, maggiordomo di Sua Santità, che gli aveva subito risposto con la convocazione. Pio IX intanto si diceva convinto che i francesi non avrebbero lasciato Roma: «La Francia» spiegava «è profondamente cattolica, malgrado il volterianesimo dei suoi uomini politici. Napoleone III vuole morire imperatore dei francesi, e lasciare, se gli verrà fatto, il suo trono al figliuolo. Egli che conosce assai bene il suo paese, sa che l’una e l’altra cosa diventano difficili se offende il senso cattolico».
«Per altro» osserva allora Boggio «Napoleone III ha preso un impegno così solenne in faccia all’Europa colla Convenzione del 15 settembre che non saprei capire come gli possa venir fatto di eluderla.»
«È un impegno a lunga scadenza. Del resto io, la Convenzione del 15 settembre, la ignoro. Hanno stipulato su cose che mi riguardano senza consultarmi; mi hanno lasciato fuori, ed io continuo a rimanervi estraneo. Quante volte si cercò di avviare il discorso su questo tema, altrettante io l’ho deviato ad altro. Vadano o vengano, io non me ne preoccupo, me ne rimetto alla Provvidenza, ma ve lo dico ancora una volta, vi penserà le due e le tre volte l’imperatore dei francesi prima di richiamar davvero le sue truppe.»
Boggio, che evidentemente si sentiva la buona volontà e la forza di poter convincere il papa a imboccare la via conciliativa con il Regno d’Italia, a un certo punto, che però non sappiamo quale fosse, provò a ricordargli che il potere temporale non faceva parte del dogma, come Pio IX stesso aveva riconosciuto. L’altro gli replicò con una bella domanda: «E, quando il papa rinunciasse ad ogni potestà temporale, il governo italiano, al primo urto, gli intimerebbe pur anche il domicilio coatto, come al cardinale De Angelis ed a monsignor di Foggia?». Monsignor Frascolla, vescovo di Foggia, era, come e forse più dello stesso De Angelis, un campione della reazione: era stato processato e incarcerato, era uscito per amnistia nel ’64, ma era ancora confinato a Como.
Boggio provò poi a far considerare al papa come, seguitando quella situazione di continui contrasti fra la Chiesa e lo Stato, la religione stessa fosse esposta a «grandissimo pericolo».
«Volete voi dire che l’Italia andrebbe sino allo scisma?»
«Tutto è possibile.»
«Sbagliate, l’Italia è profondamente cattolica.»
«Sì, Santità, ma a patto di poter essere italiana. Ormai quel che è fatto è fatto: il regno d’Italia non vi è più insidia o violenza capace a disfarlo. E se ci ponesse nel bivio di rompere l’unità, o romperla colla Chiesa, credo che prevarrebbe il secondo partito, perché abbiamo più fiducia in Vostra Santità che nei tedeschi.»
«E come c’entrano i tedeschi?»
«C’entrano assai, perché disfare l’unità equivale al lasciarli tornare in Lombardia, e se ce li lasciassimo tornare in groppa, non sappiamo come né quando ce li leveremmo di nuovo di dosso; a vece che non ci sarà mai tolta la speranza di ottenere il nostro perdono dal pietoso animo di Vostra Santità, che non ci vorrà mai trattare peggio di quanto fosse trattato dal padre suo il figliuol prodigo del Vangelo.»
«Il figliuol prodigo del Vangelo chiedeva perdono al padre suo gridandogli: peccai in faccia al Cielo, peccai in faccia alla terra. Ma questo voi non lo dite.»
«Santo Padre, se basta per la riconciliazione c...