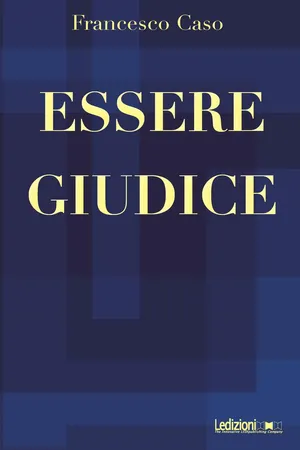![]()
8. Come si fa il giudice
Come si fa il giudice?
Qui non si vuole certamente dire come si deve fare il giudice, men che meno in senso precettivo o genericamente pedagogico. Si aspira piuttosto a tentare di spiegare in quali condizioni nella modernità si fa il giudice. Anche se, inevitabilmente, qualche “segreto del mestiere” verrà a galla.
I. Il Giudice e la conoscenza dei fatti
Qualcuno ha parlato ancora di “arte di giudicare” (così G. Alpa, L’arte di giudicare, Laterza, 1996). Locuzione che arieggia le arti un tempo dette liberali e comunque suggerisce l’idea che anche il giudicare sia un’arte, ma nel senso originario di “téchne”, cioè di saper fare o sapere qualcosa. Nella specie in un’attività squisitamente intellettuale, caratterizzata e dominata, però, da un sapere ben preciso, quello della scienza giuridica, che almeno il giudice professionale, quale giurista pratico, deve possedere. Tuttavia, che il diritto sia una scienza è controvertibile, e in ogni caso pare certo che non si tratti di scienza esatta.
Eppure, aristotelicamente il giudicare è strettamente collegato al conoscere (“Ciascuno giudica bene ciò che conosce, e solo di questo è buon giudice”, è detto nell’Etica Nicomachea), e cioè ad un’attività presuntivamente razionale.
Per Immanuel Kant addirittura “pensare” e “giudicare” sono la stessa cosa.
Tuttora, infatti, il processo per antonomasia è chiamato in diversi ordinamenti, come quello italiano, “processo di cognizione”, delineando quale eccezione una cognizione detta “sommaria” in determinati procedimenti in contrapposizione ad una cognizione che, di regola, aspira ad essere piena e completa.
L’attività del giudice, quindi, è anzitutto conoscitiva. Ma in primo luogo l’acquisizione delle sue conoscenze dei fatti rilevanti è nel processo, e limitata dal processo (pure nel processo c.d. inquisitorio anzitutto dalle c.d. prove legali, ormai comunque in declino, nelle quali il peso di una determinata prova – ad es. il giuramento e la confessione – era predeterminato dal legislatore e vincolava il giudice). Acquisizione limitata, anche, come si è già detto, dal tempo talvolta contingentato che gli può essere assegnato per il giudizio. In sintesi, infatti, da un lato, vige per lui il divieto di far uso della propria scienza c.d. privata circa i fatti da accertare nel processo e, dall’altro, quei fatti dovranno essere accertati, di volta in volta, secondo le regole processuali valevoli per ogni giudizio, che spesso gli precluderanno di acquisire d’ufficio, cioè di sua iniziativa, le prove e persino di ricercarne le fonti, pur essendo ora attualmente disponibili mezzi in grado di cercare senza posa nella Biblioteca di Babele. Si è già visto, inoltre, come egli possa tentare di acquisire e di governare conoscenze particolari e segnatamente scientifiche che esulano dal campo del diritto e quali siano gli spaesamenti che ciò può provocare.
In definitiva, da un punto di vista giuridico, il sapere del giudice è una conoscenza regolata, e regolata in modo da rispettare il principio dispositivo in tema di assunzione delle prove, e quello dell’onere della prova, nonché da far sì che egli resti equidistante dalle parti, e debba evitare vizi nella raccolta delle prove.
Ma, da un punto di vista gnoseologico, la conoscenza del giudice sicuramente è imbrigliata, non è libera ed è quindi limitata.
E questo cortocircuito logico è ben espresso dalla locuzione “verità processuale”, che sta a significare appunto che il giudice può raggiungere non la verità in assoluto (ammesso che esista), ma quella migliore che gli è consentita nei limiti del processo dettato dalla legge.
Il compito dei giudice circa l’accertamento dei fatti è stato sovente paragonato alla figura dello storico (“Il giudice e lo storico” è il titolo di un famoso saggio di Piero Calamandrei del 1939, ma l’accostamento da allora è divenuto ricorrente tema di riflessione).
Nondimeno, mentre qualsiasi verità “storica” potrebbe essere successivamente rimessa in discussione a seguito di ulteriori ricerche e approfondimenti, invece quella accertata dal giudice, come e più di quella dei narratori di fantasia (per Umberto Eco che Superman sia Clark Kent nessuno lo può discutere, mentre che Napoleone sia morto a Sant’Elena qualche storico “revisionista” un domani lo potrebbe sempre smentire), è destinata a diventare tendenzialmente indiscutibile (con il giudicato), anche se era stata limitata e relativizzata dal processo.
Infatti, res iudicata facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat; ma soprattutto la conclusione del noto brocardo, se, da una parte, sta a voler esprimere in forma estrema e paradossale la forza del giudicato, dall’altra, significa anche ammettere che nel diritto applicato in giudizio si debba tollerare che addirittura ciò che è falso possa diventare vero. Il che indubbiamente evoca un notevole pessimismo di fondo a riguardo (ma occorre riconoscere anche che affermare che il giudicato possa trasformare persino i vincoli di sangue naturali è stato davvero premonitore da parte dei nostri progenitori).
Non appare affatto casuale, allora, che il totem del giudicato di recente sia molto più messo in discussione che nel passato, e che anche a livello di corti internazionali sempre di più se ne indaghino i limiti.
Inoltre, dal giudice si esige anche altro che essere un dotato giurista, e gli si richiedono vaste conoscenze, non circoscritte al campo del diritto, tanto che, come si è visto, si finge ancora che sia peritus peritorum, e quindi teoricamente abilitato a far uso della propria scienza personale in qualsiasi settore dello scibile.
Ma il giudice professionale, cacciato in questa impasse, potrà far uso di vari strumenti propri della sua “arte”, e quindi, per esempio, nascondere in argomenti retorici un’inconfessabile percezione meramente intuitiva di un caso che non ha potuto (o voluto) conoscere in modo esauriente e razionale e, come si è visto, nel tempo teoricamente occorrente.
La cosa può e deve essere vista anche da un altro punto di vista.
È acquisito che potere e conoscenza sono strettamente interdipendenti in modo quasi circolare: quanto più si conosce più si ha potere, e tanto più potere si ha tanto maggiore sarà il vantaggio cognitivo derivante dalla posizione rivestita, quasi come una rendita conoscitiva di posizione appunto (fornita, per così dire gratuitamente e senza sforzo per il solo fatto di occupare un determinato posto). In particolare chi occupi posizioni di vertice (anche nella magistratura ovviamente) disporrà di informazioni privilegiate di prima mano che gli derivano dai rapporti collegati all’esercizio di quel potere, e da fonti che gli verranno quasi spontaneamente messe a disposizione, in tempo, come suol dirsi, reale; mentre gli altri quei dati, se attingibili, dovranno procurarseli per proprio conto, sovente a non indifferenti costi di tempo e danaro, o magari solo intuirli. Inoltre, il potere fa la conoscenza e comunque può condizionarla, se non manipolarla.
Orbene, il potere conoscitivo limitato del giudice in via ufficiale potrà essere giustificato (forse sarebbe meglio dire, mascherato) dai principi apparentemente neutrali della tradizione (nemo judex procedat ex officio, judex judicare debet secundum alligata et probata partium, la necessaria terzietà del giudice, etc.). Ma, quando si discute di segreto di stato, di segreto bancario, di segreti professionali, di privacy, di mezzi c.d. invasivi di ricerca della prova, quali, per es., le intercettazioni di comunicazioni nelle loro varie forme, di reati informatici, di processi che riguardano i politici o altri c.d. poteri forti, di anonimato della madre che non vuole essere nominata all’atto della nascita di chi ha messo al mondo, e via ipotizzando, quali limiti della conoscenza del giudice, ognun vede come l’esistenza e la relativa disciplina degli stessi dipendono da scelte della politica. Queste ultime, quindi, sono state occasioni di tensioni e scontri con la magistratura giudicante e non, proprio perché i giudici possono, più o meno consapevolmente, mal sopportare quei limiti, dettati da ragioni che, secondo i casi, possono sembrare loro ingiuste, e magari imposti dal potere politico per non far sapere solo determinate cose nel processo e quindi all’opinione pubblica.
Insomma, il tema della conoscenza anche per il giudice è di tale complessità che vira “verso l’infinito ed oltre”.
II. Il Giudice e la conoscenza del diritto
Invece, rispetto al diritto, e cioè al campo che gli è proprio, il giudice in teoria non s’imbatte in limiti di sorta, e può liberamente acquisire le informazioni giuridiche che ritiene gli servano.
Anzi il brocardo della tradizione jura novit curia (il giudice conosce le leggi) sta addirittura ad esprimere il concetto che nel giudice si presume una conoscenza quasi innata del diritto, da lui posseduta per il sol fatto di essere giudice. E l’altro bellissimo aforisma da mihi factum, dabo tibi jus (narrami il fatto, ti darò il diritto) – in cui il soggetto sottinteso della proposizione è appunto il giudicante rispetto a chi a lui si rivolga in un rapporto personale diretto – manifesta magnificamente lo stesso ottimismo sulla capacità del giudice di somministrare giustizia sol che gli vengano provati i fatti rilevanti.
Naturalmente le cose oggi non stanno esattamente così. Il giudice professionale viene tuttora accreditato di sapienza giuridica.
Ma il tema delle fonti del diritto (id est ciò da cui si attingono le regole, come l’acqua che sgorga naturalmente da una fonte) è divenuto anch’esso estremamente complesso, al punto che talvolta è arduo persino stabilire quale sia il diritto oggettivo da utilizzare nel caso concreto. In retroguardia ormai la consuetudine, il diritto positivo non da ora è costituito, non certo solo dalla legge scritta (di cui un tempo che pare preistorico il giudice era solo la “bocca” che doveva pronunciarla), ma anche da una miriade di fonti c.d. secondarie (regolamenti, ordinanze amministrative, codici di autoregolamentazione, norme deontologiche e tecniche, protocolli, etc.), di incerta natura, prodotte da soggetti e organi diversi (e non solo dal quasi mitico Legislatore) e in continuo divenire.
La molteplicità, il rapido modificarsi nel tempo, il tecnicismo, ma anche il difetto di coordinamento, di tutte queste fonti eterogenee, ormai prevalentemente esterne ai rassicuranti codici, e non sempre raccolte in testi organici almeno settoriali (quelli che in Italia si chiamano s...