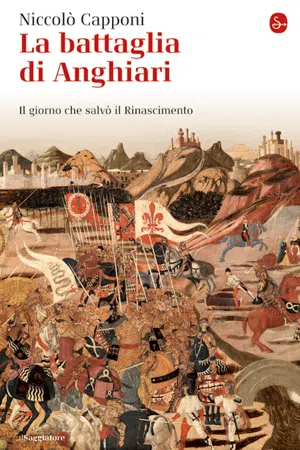1. «Ora pigliate le guerre…»
Il barbuto individuo osservò con occhio attento la grande sala del palazzo. Date le dimensioni, l’impresa che si accingeva a compiere era a dir poco colossale, ma anche possibile fonte di prestigio e denari. Certo, i suoi attuali committenti non erano così generosi come coloro a cui era abituato; ma i guai dell’Italia lo avevano costretto ad abbandonare quello che, per quasi un ventennio, era stato il suo cantiere per fare ritorno alla sua città natale. Per fortuna, nel corso degli anni si era costruito una solida fama come artista, il che gli aveva procurato la commissione che si accingeva a intraprendere, un’opera che, secondo le intenzioni dei suoi nuovi patroni, sarebbe servita a dare un forte segnale politico circa le capacità militari del regime.
La città, invero, aveva un disperato bisogno di successi militari, nonché di portare sotto un’unica bandiera i suoi proverbialmente litigiosi abitanti. Dopo decenni in cui una famiglia sola l’aveva fatta da padrona, pur conservando l’apparenza di un sistema di governo pluralistico, gli abitanti, grazie anche a un congruo aiuto dall’esterno, avevano ritrovato la libertà. Ma con essa era arrivata una serie di guai, non ultime le ribellioni di località soggette; in particolare una stava dando, da un decennio, parecchio filo da torcere al regime. Tutti i tentativi di catturarla erano falliti, e il pesante giogo fiscale necessario a finanziare la guerra stava facendo serpeggiare un forte malcontento tra i cittadini. Peggio ancora, gli insuccessi sul campo avevano creato la diffusa impressione che il regime fosse ormai sul punto di crollare, e vi erano nella città parecchi individui che non aspettavano altro che il ritorno della famiglia precedentemente al potere. Pertanto, il lavoro commissionato all’artista doveva servire come opera di propaganda, all’esterno come all’interno.
Il problema era stato la scelta dei temi da rappresentare. Anche nel passato la città non era stata famosa per la sua bellicosità, e le vittorie da lei riportate sul campo si contavano sulle dita di due mani. Soprattutto, andavano trovati soggetti che potessero avere un’attinenza con la situazione odierna: la guerra in corso contro la località ribelle e la resistenza della città contro coloro che in precedenza avevano cercato di privarla della libertà. Alla fine, erano rimaste due opzioni possibili: la prima risaliva al 1363, quando i cittadini erano riusciti a battere la compagnia del celebre condottiere inglese Giovanni Acuto – italianizzazione dell’originale John Hawkwood; il secondo scontro, invece, era stato talmente celebre da meritarsi le attenzioni di storici del calibro di Leonardo Bruni, Flavio Biondo e Bartolomeo Platina – per non menzionare il suo ricordo in diverse rappresentazioni artistiche. Nella città esisteva un cassone nuziale rappresentante la battaglia in questione e appartenente ai discendenti di uno dei rappresentati politici presso l’esercito che aveva conseguito la vittoria.
Prima di uscire dalla sala il barbuto individuo fece un paio di calcoli mentali su come intendeva impostare l’opera. C’era molto lavoro da fare: trovare manovalanze, acquistare cartoni e altri strumenti di lavoro, reperire il legname per le impalcature, il tutto in quantità enorme allo scopo di dipingere uno dei più imponenti cicli pittorici mai visti: la battaglia di Anghiari.
Angelo della Pergola e Guido Torelli erano persone che sapevano il fatto loro. I due condottieri, al servizio del duca di Milano Filippo Maria Visconti, stavano elaborando un piano di battaglia, mentre dalla loro base di Borgo Sansepolcro, nell’alta Val Tiberina, osservavano il campo fiorentino posto sotto il paese fortificato di Anghiari, qualche chilometro a sudovest. I capitani viscontei avevano appena ricevuto da un disertore preziose informazioni circa le discordie esistenti tra Bernardino Ubaldini e Ardizzone da Carrara, i comandanti avversari. Inoltre sapevano bene quanto male in arnese fossero le forze messe assieme da Firenze, il Comune avendo dovuto fare i salti mortali per ricrearsi un esercito dopo le pesanti sconfitte di Zagonara, l’anno precedente, e nella Val di Lamone, qualche mese avanti. Con i soldati migliori già al soldo di altri potentati, i fiorentini erano stati costretti ad assoldare il poco disponibile rimasto sulla piazza; e benché alcuni dei condottieri impiegati dal Comune fossero gente di vaglia, gran parte dell’esercito fiorentino era una massa raccogliticcia, comprendente veterani già appartenuti alla compagnia del defunto Braccio da Montone e avanzi raschiati dal fondo del barile mercenario. Inoltre, non era cosa da poco la frattura esistente tra i vari comandanti fiorentini, spesso provenienti da diverse scuole militari e frequentemente divisi anche da rivalità personali. I condottieri milanesi intendevano fare capitale di questi fattori.
Nonostante la debolezza qualitativa dei loro nemici, il della Pergola e il Torelli si rendevano conto dei rischi esistenti nel portare un attacco a un campo trincerato, per cui diventava necessario costringere i fiorentini in una situazione a loro sfavorevole. Il Torelli, pertanto, cominciò a provocare il nemico mandando avanti piccoli nuclei di soldati contro il campo trincerato, sicuro che sarebbero stati respinti. Ma questo faceva parte del piano dei viscontei, i quali contavano in tal modo di far montare nei loro avversari un malaccorto senso di fiducia nelle proprie capacità. I comandanti milanesi andarono avanti così per qualche giorno, finché non reputarono le vittime arrivate alla giusta cottura. Il 9 ottobre dell’anno di grazia 1425, i ducali ripeterono il solito copione, ma stavolta con una significativa variante: la prima, debole, unità d’attacco sarebbe stata sostenuta da una seconda e più forte, in modo da attirare quante più truppe fiorentine fuori dall’accampamento. Il piano funzionò alla perfezione e, come i viscontei cominciarono a ritirarsi, i fiorentini si buttarono all’inseguimento, solo per trovarsi dinanzi l’intero esercito milanese. Nel confuso combattimento che seguì, il Torelli e il della Pergola ebbero il sopravvento, sgominando e ributtando indietro gli avversari. Bernardino Ubaldini, cui fin dall’inizio era sfuggito di mano il controllo delle proprie truppe, fu fatto prigioniero mentre i suoi colleghi riuscirono a scampare alla rotta dando lo sprone ai cavalli.
Anghiari era la quarta battaglia consecutiva persa da Firenze nel giro di quindici mesi, in quello che era stato per il Comune un autentico annus horribilis.
Gli eventi che avevano portato alla battaglia di Anghiari avevano avuto origine nella confusa situazione politica italiana a cavallo tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo. All’inizio del Quattrocento il duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, noto come il conte di Virtù (da Vertus, nello Champagne, feudo portatogli in dote dalla prima moglie Isabella di Valois, figlia del re di Francia Giovanni II) era riuscito a imporre la propria egemonia su gran parte dell’Italia settentrionale e centrale attraverso un’accorta e spregiudicata politica espansionistica. Al tempo della sua morte, nel 1402, Venezia e Firenze erano rimasti gli unici stati a tenergli testa; il papato non era in grado di opporsi al duca, causa la situazione di scisma esistente nella Chiesa dal 1378 che aveva portato alla creazione di due pontefici, quello legittimo residente, perlopiù, a Roma e un antipapa dimorante ad Avignone; in quanto al meridione d’Italia, era da tempo terreno di scontro tra le case d’Angiò e d’Aragona, quando non tra i vari rami della dinastia angioina. Ma Venezia poteva fare poco per opporsi alle mire espansionistiche di Gian Galeazzo, visto che possedeva un territorio piuttosto limitato nell’Italia continentale, mentre i fiorentini erano con le spalle al muro, dato che la maggior parte dei comuni toscani aveva scelto di assoggettarsi al Visconti. Politicamente isolata, circondata da vicini ostili e sconfitta sul campo di battaglia, Firenze pareva sul punto di cadere nelle rapaci grinfie del duca. L’improvviso trapasso di questi non fu solo la salvezza del Comune, ma rimescolò completamente le carte sul tavolo da gioco italiano.
Gian Galeazzo aveva diviso i suoi possessi tra i figli Giovanni Maria, Filippo Maria e l’illegittimo Gabriele Maria. La giovane età dei successori del conte di Virtù, unita alle lotte intestine tra i loro tutori, precipitarono il ducato di Milano nel caos più completo, situazione che permise ad alcuni condottieri, già al servizio di Gian Galeazzo, di fare man bassa dei territori viscontei, mentre uno di essi, il piemontese Facino Cane, divenne l’effettivo padrone del ducato attraverso l’esclusiva influenza esercitata su Giovanni Maria. Della confusione politica esistente a Milano approfittarono i veneziani e i fiorentini; i primi conquistarono una fetta consistente della parte orientale del dominio di Gian Galeazzo, inglobando nel loro stato Vicenza, Padova e Verona e portandosi al ridosso delle frontiere mantovane e ferraresi; i secondi, invece, acquistarono da Gabriele Maria Visconti la città di Pisa, che riuscirono a prendere solo nel 1406 dopo un lungo e spietato assedio (i pisani non avendo alcuna intenzione di sottostare al giogo dell’odiata Firenze) riuscendo a completare il blocco della città con una flottiglia di galee veneziane prese in affitto.
In teoria, una conquista fiorentina di Pisa avrebbe dovuto preoccupare Venezia che si sarebbe ritrovata a fare i conti con un potentato commerciale dotato di porto. Ma la Serenissima aveva giocato bene le proprie carte: i veneziani erano riusciti a prendere Padova nel 1405 anche grazie al fatto che i fiorentini, occupati coll’assedio di Pisa, non erano stati in grado di aiutare i padovani. Inoltre, la conquista di Pisa non fu per Firenze un affare in senso assoluto: l’interramento provocato dai detriti dell’Arno stava rapidamente riducendo le possibilità del porto pisano e il nuovo sbocco marittimo mise Firenze in contrasto con gli altri stati costieri del Tirreno. Genova, in particolare, vide in modo assai negativo la presenza di una nuova, potenziale concorrente economica quasi alle porte di casa. Pertanto, e in barba ad accordi presi in precedenza, i genovesi convinsero il governatore francese di Genova (la città essendo all’epoca un protettorato dei Valois) a rifiutare la cessione di Livorno, Sarzana e delle torri poste a protezione di Porto Pisano. Alla fine dei conti, l’aiuto veneziano ai fiorentini poteva sembrare una polpetta avvelenata.
Per Venezia, invece, l’ampliamento dello «stato di Terraferma» rappresentò un grosso vantaggio. Non solo la Serenissima era riuscita a consolidare la propria sicurezza spostando le frontiere occidentali fino al Lago di Garda, ma aveva anche acquisito un ampio comprensorio da cui poteva trarre gli approvvigionamenti necessari alla sopravvivenza della capitale. Inoltre, la conquista del Veronese, del Padovano e, soprattutto, del Vicentino, creò ottime possibilità d’investimento terriero per il ceto dirigente veneziano. A tutto ciò andrebbe aggiunta l’acquisizione di entità feudali già dipendenti dai Visconti, o dalle varie città della Terraferma, fonti importanti di reclutamento militare per la Serenissima. Ciò detto, l’espansione di Venezia nell’Italia settentrionale avrebbe portato il coinvolgimento della città nelle lotte per l’egemonia sulla penisola italiana e, in pratica, prodotto nei veneziani qualcosa di simile a una schizofrenia strategica che li avrebbe condotti a privilegiare di volta in volta o il fronte della terraferma o quello orientale e mediterraneo, minacciato dall’espansione ottomana nei Balcani e nell’Egeo.
Nel 1412, con l’assassinio di Giovanni Maria Visconti e la morte di Facino Cane, cominciò la ripresa del ducato di Milano. Prima di passare a miglior vita, il Cane lasciò la sua compagnia di ventura e il proprio, cospicuo, patrimonio personale a Filippo Maria Visconti, con l’obbligo però che questi ne sposasse la vedova, Beatrice di Tenda. Il giovane duca, che possedeva tutta l’abilità politica e la spregiudicatezza del padre, accettò di buon grado d’accasarsi con una donna vent’anni più vecchia di lui per i vantaggi materiali e militari insiti nell’unione. Come prima cosa, infatti, dovette affrontare altri pretendenti al dominio di Milano, tra cui il cugino Estorre Visconti che aveva preso il possesso di Monza. Per Filippo Maria fu giocoforza procedere con cautela nella riconquista delle terre viscontee, il duca utilizzando, a seconda dei casi, o l’accordo o la forza o i subdoli mezzi impiegati da ogni governante italiano dell’epoca. Per le operazioni militari, il Visconti si avvalse di uno dei luogotenenti del defunto Facino Cane, il duro e abile Francesco Bussone, detto «il Carmagnola» dal luogo di nascita. Grazie a campagne militari brillantemente condotte, il Carmagnola riprese tutta la Lombardia e la parte del Piemonte comprendente Tortona, Alessandria, Vercelli e Novara. Nel 1421, in collaborazione con la flotta aragonese, costrinse Genova ad accettare il protettorato milanese e l’anno successivo batté clamorosamente ad Arbedo (Bellinzona) le forze dei cantoni svizzeri inviate a occupare il Ticino. Il successo del Carmagnola nella riconquista dello stato visconteo fu dovuto anche al fatto che nessun potentato italiano lo intralciò: erano tutti altrimenti impegnati.
A Venezia l’elezione, nel 1414, del doge Tommaso Mocenigo aveva rallentato la spinta della Serenissima verso ovest, anche perché la repubblica si era trovata impelagata in una guerra con gli Ottomani e successivamente con il patriarca di Aquileia Ludwig von Teck, appoggiato militarmente dal re d’Ungheria e futuro imperatore romano Sigismondo del Lussemburgo. Con un conflitto in atto alle porte della Laguna, i veneziani non potevano permettersi il lusso di aprire un secondo fronte di guerra nel milanese, e inoltre il Mocenigo non riteneva l’espansione del Dominio di Terraferma utile per la repubblica – nel suo testamento politico implorò che il suo successore non fosse Francesco Foscari, convinto che avrebbe coinvolto Venezia in guerre costose e senza via d’uscita. Puntualmente, a meno di due settimane dalla morte del Mocenigo, fu annunciata la nomina del suo successore: Francesco Foscari. E in breve tempo trovarono conferma i timori del defunto doge.
Nei primi anni della ripresa viscontea Firenze non volle, né ebbe la possibilità di opporvisi, distratta com’era da più immediate e pressanti minacce. Già dai primi anni del secolo XV il re di Napoli Ladislao d’Angiò aveva intrapreso una politica tesa ad annettere al proprio regno l’intera Italia centrale e, in poco tempo, conquistare Roma e spingersi fino ai confini della Toscana. Per un breve periodo una lega tra Firenze e Siena riuscì a fermare l’avanzata di Ladislao, il quale si opponeva anche ai tentativi, soprattutto fiorentini, di porre termine allo scisma esistente nella Chiesa cattolica. Per Firenze la ricucitura di questa divisione era in parte mossa da un sincero sentimento religioso, ma anche da ragioni politiche, dato che il papato poteva servire come stato cuscinetto tra la Toscana e il Regno di Napoli. Per ragioni opposte Ladislao non intendeva affatto adoprarsi per la ricomposizione dello scisma, la presenza di due pontefici rivali favorendo invece la sua politica espansionistica. In realtà, i fiorentini erano presi tra l’incudine e il martello, avendo timore di Ladislao, ma al contempo mire territoriali sulle Romagne e la Val Tiberina, ben consci che una Chiesa unificata sarebbe stata un’interlocutrice ben più coriacea di una divisa. Questo atteggiamento contraddittorio è ben riassunto in uno degli aforismi dettati, intorno al 1410, dall’oligarca Gino Capponi a suo figlio Neri:
La Chiesa divisa fa pel Comune nostro, e per la nostra Libertà mantenere; ma è contro all’anima: e però non vi si debbe dare opera, ma lasciare fare alla natura. E se si potesse fare, ch’egli attendessimo allo spirituale solo, sarebbe sacrificare, e utile al Comune nostro la loro unità. Pure l’amicizia del Papa è utile al nostro Comune, e per niuno modo non vi contrapponete a quella; che cosa niuna ci può riuscire, se non con amistà della Chiesa.1
I fiorentini avevano già provato a porre fine allo scisma, favorendo la convocazione a Pisa di un concilio ecumenico che dirimesse la questione. Il concilio depose sia il pontefice romano sia quello avignonese e ne elesse un nuovo, Alessandro V; ma la sostanziale mancanza di autorità politica dell’assemblea pisana ebbe come unica conseguenza una Chiesa tricefala, dato che i deposti si rifiutarono di sgombrare il campo. Come se ciò non bastasse, papa Alessandro morì dopo poco più d’un anno di regno, e il concilio pisano elesse come suo successore l’ambizioso Baldassarre Cossa, con il nome di Giovanni XXIII. Per prima cosa il nuovo pontefice tentò la riconquista di Roma, con l’appoggio dei fiorentini e del pretendente al trono di Napoli Luigi II d’Angiò. Dopo un primo successo che portò all’insediamento dell’antipapa Giovanni nella Città Eterna, la sconfitta sul campo di Luigi causò il suo abbandono dell’impresa, costringendo quindi il Cossa a cercare l’accordo con Ladislao, in cambio del suo riconoscimento ufficiale come re di Napoli. Questi, che già era riuscito a siglare paci separate con Firenze e Siena, fu ben contento di accettare, avendo bisogno di tempo per riorganizzare le proprie forze.
Ma nel maggio 1413 Ladislao marciò su Roma costringendo Giovanni alla fuga e i fiorentini, appena usciti da una sfiancante guerra con Genova per il controllo di Livorno e Sarzana, a cercare un nuovo accordo con il napoletano. A Firenze si era ben coscienti che la sete di dominio del re era superiore a qualsiasi trattato, e così la città tirò un sospiro di sollievo quando si apprese che Lasdislao aveva improvvisamente esalato l’anima nell’agosto 1414. Come nel caso di Gian Galeazzo, per Firenze la natura si era rivelata il miglior alleato.
La dipartita di Ladislao favorì anche la risoluzione dello scisma nella Chiesa. Appena entrato a Roma, Giovanni XXIII aveva convocato un concilio ecumenico, che però aveva dovuto chiudere i lavori quasi subito, causa l’offensiva militare napoletana. Grazie alla disponibilità del re dei Romani2 Sigismondo del Lussemburgo, il concilio si riconvocò a Costanza, nella Germania meridionale, e decretò la deposizione dei tre contendenti. Tuttavia, i padri conciliari aspettarono un paio d’anni prima di eleggere un nuovo papa, non volendo intralci durante l’elaborazione della cosiddetta dottrina «conciliarista», che in pratica sottoponeva il vicario di Cristo all’autorità dell’assemblea generale della Chiesa e lo obbligava a convocare un concilio ecumenico ogni cinque anni. Quando, nel novembre 1417, si arrivò all’elezione di papa Martino V (al secolo Oddone Colonna), questi, pur accettando alcuni dei decreti emessi a Costanza, ci mise poco a riaffermare il primato pontificio in materia di fede. Martino lasciò la Germania nell’aprile successivo, dopo lo scioglimento dell’assemblea ecclesiale, diretto a Roma. Purtroppo per lui, la situazione politica italiana lo avrebbe costretto a diversi anni di forzato esilio dalla Città Eterna, essendo emerso un nuovo potentato nel centro della penisola.
Si può ben dire che la violenza abbia accompagnato fin dall’infanzia Andrea Fortebracci (o Fortebraccio), combattendo giovanissimo al fianco del padre, Oddo Fortebracci conte di Montone, nelle lotte intestine della natale Perugia tra le fila della fazione detta dei «beccherini». L’ascesa dei nemici «raspanti» costrinse i Fortebracci all’esilio e, per buona parte della vita, Andrea non ebbe che un’idea in testa: rientrare a Perugia da padrone. La sua vita errabonda lo portò a militare sotto le insegne del celebre condottiere Alberico da Barbiano, ma il suo chiodo fisso lo rendeva un subordinato difficile da gestire, data anche la propensione ad abbandonare i suoi datori di lavoro ogni qual volta si presentava l’occasione di rientrare a Perugia. Di conseguenza, e anche per la mancanza di risorse economiche, la sua carriera fu lenta e, nonostante le indubbie capacità militari, giunto alla trentina era ancora un semplice comandante di squadrone. La rottura di quest’impasse avvenne nel 1407 quando la ...