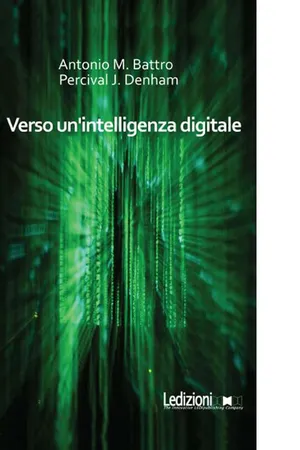CAPITOLO 1
GLI “HABITUS” DIGITALI
Nec manus, nisi intellectus, sibi permissu, multam valent; instrumentis et auxilibus res perficitur.
(La mano nuda e l'intelletto abbandonato a se stesso servono poco. Per compiere le opere sono necessari strumenti e mezzi d'aiuto)
Francis Bacon, Novum Organum
Nelle parole di Howard Gardner, “un’intelligenza è una nuova costruzione concettuale che si basa su potenzialità e capacità biologiche e psicologiche”. È fondamentale sottolineare questi ultimi due aspetti, che oggi si integrano nell’ampio spazio comune delle neuroscienze cognitive. Detto in altro modo: “Un’intelligenza è un potenziale biopsicologico per processare quell’informazione che potrà essere attivata in un contesto culturale per risolvere problemi o creare prodotti considerati di valore per questa cultura” (Gardner 1999, 34). Un’intelligenza, di conseguenza, non è una “cosa” ma un potere, una capacità. A volte queste capacità sono deteriorate a causa di una lesione cerebrale, e, per questa ragione, lo studio di persone disabili risulta di grande importanza per comprendere quale luogo e funzione nella vita umana sono occupate da una particolare intelligenza. D’altro canto, lo sviluppo cerebrale – normale o patologico – dell’infante e dell’adolescente dovrà porsi in relazione, anche se in modo indiretto, con il tema dello sviluppo dell’intelligenza digitale e della scolarizzazione nel secolo XXI. Questi studi fanno parte di quella che si è convenuto chiamare “neuroeducazione” o “neuroscienze dell’educazione” (Battro, Fischer e Lena The Educated Brain, essays in neuroeducation. New York: Cambridge University Press, 2008.). Si tratta di un campo di studi che sta acquistando un’importanza crescente in tutto il mondo. Non vogliamo, con la nostra ricerca dei fondamenti di un’intelligenza digitale, imbarcarci nella polemica “natura vs cultura”. La nostra dotazione genetica e la nostra cultura acquisita non si possono separare artificialmente. Di fatto la cultura si esplicita nel cervello. Studi recenti, grazie a tecniche di immagini cerebrali, hanno trovato, per esempio, differenze importanti nell’attivazione di neuroni secondo l’idioma parlato da un individuo (Paulesu et al. 2000). Un’altra prova in questo senso è il prodigioso estendersi del linguaggio umano nel tempo e nello spazio. La nostra specie ha la capacità unica di poter parlare per comunicare e, la storia che possiamo ricostruire, ci permette di inferire che il linguaggio articolato ha sofferto un’evoluzione costante dai primi ominidi fino al presente. L’esistenza sul nostro pianeta, al momento attuale, di migliaia di lingue, è un segno in più della straordinaria plasticità del nostro cervello nella manipolazione simbolica. Uno di questi linguaggi ha un carattere rigorosamente formalizzato e si esprime nel “codice digitale” che ci permette di comunicare con i computer e di programmarli, il che, a sua volta, provoca, indirettamente e attraverso di molti intermediari, un cambio profondo nel nostro sistema di comunicazione sociale, ossia nella nostra cultura.
Il senso numerico e il digitale
In alcune lingue si identifica “numerico” con “digitale” il che può essere fonte di confusione, come nel francese, dove il “linguaggio digitale” viene chiamato “linguaggio numerico”. In castigliano la differenza, fortunatamente, è ben chiara. D’altro canto la distinzione tra attività numerica e digitale, intesa come scelta-clic, è fondamentale per comprendere le nostre idee. In quanto al numero, è interessante menzionare i recenti studi di Stanislas Dehane sui circuiti neuronali che agendo come processori numerici elementari nel cervello umano (e in altre specie), potrebbero giustificare l’esistenza di un vero “senso numerico”, ossia una componente essenziale dell’intelligenza logico-matematica (Dehane 1997 e 2005). Però, questo senso numerico, non farebbe parte dell’intelligenza digitale come la definiamo qui. L’esistenza di un eventuale “senso digitale”, un’”intuizione digitale”basica, comparabile al “senso numerico” proposto da Dehaene e che sia il primo segnale di un’ “intelligenza digitale” propriamente detta, non ha, ancora, evidenze dirette.
Senza dubbio non è una mera coincidenza che molti esperimenti di laboratorio, tanto nella psicologia animale come in quella umana, si basino su semplici scelte, su una selezione binaria, di sì o no, quando si schiaccia un bottone o un interruttore. La scelta-clic è, sicuramente, osservabile in molte specie e questa universalità ci permette di affermare che gioca anche un ruolo determinante nell’intelligenza digitale degli esseri umani.
È importante riconoscere, inoltre, che le nuove tecnologie digitali possono attuare come vere “protesi informatiche” del sistema nervoso (Papert e Weir 1973, Valente 1983, Rose e Mayer 2000, Battro 2000 e 2002) e che sono capaci di compensare certe deficienze prodotte da lesioni del sistema nervoso. Grazie a queste, molte persone con disabilità motorie e sensoriali riescono a raggiungere un alto livello di produzione intellettuale, cosa che sarà sempre più frequente man mano che ci addentriamo nell’era digitale. In questo senso, la citazione di F. Bacon che apre questo capitolo acquisisce nuova forza.
Calligrafia e dattilografia
Per proseguire, approfondendo questa riflessione, è necessario stabilire una distinzione chiara tra la “scrittura analogica” e la “scrittura digitale”. La scrittura manuale, e la calligrafia in particolare, sono esempi tipici di abilità analogica, dove un movimento continuo della mano lascia un segno continuo, un movimento discontinuo lascia un segno discontinuo, molta pressione della matita lascia un segno spesso, poca pressione, un segno fino. C’è sempre in questi casi un’“analogia” tra la produzione e il prodotto. Non accade lo stesso con la scrittura digitale. Quando scriviamo lettere, sillabe, parole, frasi o caratteri ideografici con un computer, usando la tastiera o altri sistemi alternativi (riconoscitore vocale, comandi, eccetera) non “riproduciamo” passo a passo la forma grafica ma la “produciamo” in modo immediato e quasi magico.
Forse il “salto digitale” si produce più velocemente in quelle culture, come quella cinese, che usano ideogrammi, e dove la difficoltà di apprendimento dei segni ha mantenuto emarginati milioni di cittadini. Oggi, grazie ai computer, il panorama sta cambiando rapidamente. In Cina si usa un formato di scrittura chiamato pinyn che ha la caratteristica di far corrispondere potenzialmente a un’espressione decine di ideogrammi differenti. Lo scrittore deve imparare a discriminarli. Quest’esercizio di scrittura cinese con il computer si rinnova e cambia in modo opposto all’abituale: tradizionalmente gli ideogrammi si costruiscono passo a passo, dai più semplici ai più complessi, compito che porta via moltissime ore agli studenti cinesi. Ora tutto questo sforzo si può ridurre drasticamente, e così aumentano sensibilmente le possibilità di insegnare a leggere e a scrivere all’immensa popolazione di questo paese. Inoltre, con il computer è stato prodotto in Cina un cambio cognitivo interessante, di natura culturale, visto che con la moderna pratica digitale molti riconoscono di star perdendo, per mancanza di esercizio, la capacità di costruire i caratteri tratto per tratto, ma non così la capacità di riconoscerli e leggerli.
Come conseguenza di queste trasformazioni si è aperto un forte dibattito culturale in Cina, con l’aumento delle persone che comprendono il linguaggio scritto, prima di tutto, come un mezzo di comunicazione e non tanto come un rito o una calligrafia, e che hanno fretta di integrarsi alla società globalizzata (Lee 2001). In futuro, le abilità calligrafiche tradizionali della cultura cinese, puramente analogica, rimarranno, sicuramente, riservate agli artisti della piuma e del pennello, che, con queste, continueranno a creare bellezza. È anche giusto ricordare che il giapponese si può esprimere tanto nella calligrafia di un ideogramma (kanji) che in una scrittura fonetica (katakana). Merita osservazione come la prima si processi preferibilmente nell’emisfero cerebrale destro e la seconda nel sinistro. Per questa ragione, molti afasici di lingua giapponese con una lesione nell’ emisfero sinistro non perdono la grafia kanji.
Dettare e scrivere
L’editor di testo controllato con la tastiera ha indubbi vantaggi di leggibilità e rapidità, e anche il dettato mediante sistemi che riconoscono la voce ha prodotto una rivoluzione teorica e pratica. In generale, la macchina risponde bene alla parola correttamente articolata e funziona come una poderosa amplificazione delle nostre abilità digitali, e costituisce un aiuto significativo per superare certe disabilità motorie e sensoriali. Non si riduce, però, a quest’attività compensatoria o suppletiva, anzi, ci sembra che si dovrebbe insegnare a dettare a un computer anche nella scuola comune.
Così si pone un tema significativo nell’ambito didattico, che concerne da vicino lo sviluppo di un’intelligenza digitale nella scuola. Una cosa è dettare e un’altra scrivere, sono due sistemi cognitivi differenti e due modi differenti di processare l’informazione da parte del cervello, torneremo su questo più avanti. Si tratta di un campo aperto alla ricerca, che coprirà ogni giorno sempre maggior rilevanza pedagogica man mano che si perfezionino i sistemi di riconoscimento vocale (Battro e Denham, 1997).
La lingua madre e la lingua digitale
Oggi sappiamo che il cervello di una persona bilingue precoce si differenzia da quella di una persona bilingue tardiva, ossia che ha acquisito la lingua dopo gli 11 anni. Nel primo caso si attivano le stesse aree in ambedue le lingue; nel secondo caso le aree si distinguono chiaramente (Dehaene et al. 1997). Ricerche recenti dimostrano, come abbiamo anticipato, che la cultura, in questo caso espressa con la lingua materna, si incorpora in maniera strutturale nel cervello umano. Per esempio, quando un lettore inglese legge un testo nel suo idioma nativo, usa soprattutto zone della corteccia cerebrale frontale sinistra e temporale inferiore; quando un lettore italiano legge nella sua lingua madre, invece, utilizza di più la regione temporale superiore. Questo è relativo alla struttura stessa del linguaggio. In effetti, le regole fonologiche che governano il passaggio dalle lettere al suono sono più semplici in italiano - o in spagnolo - che in inglese, dove le parole che si differenziano solo per una lettera, come cough, bough, dough, e tough, non si pronunciano allo stesso modo. Insomma, ci sono lingue più “trasparenti” che altre rispetto alle relazioni tra ortografia e fonologia, in questo senso possiamo affermare che il “cervello della lettura” per l’inglese non è lo stesso che per l’italiano o per lo spagnolo (Paulesu et al. 2000). Inoltre, quando impariamo a leggere in una seconda lingua, in qualche modo “cambiamo la corteccia cerebrale” (Fazio et al. 1997). Certamente, non abbiamo coscienza di questo fatto che accade nel profondo dei nostri neuroni, però lo possiamo verificare osservando le immagini del cervello mentre leggiamo. Un giorno si potrà anche studiare il cervello di una persona che apprende a usare il “linguaggio digitale”, il linguaggio del computer, come un linguaggio in più. Il ragionamento è il seguente: se le differenti lingue naturali si incorporano, come sembrerebbe essere, in zone specifiche della corteccia cerebrale, è probabile che una lingua artificiale, come quella che si usa nella programmazione, si materializzi anch’essa in circuiti neuronali propri. In ogni caso quest’esperimento, - ancora da realizzare-, si riferisce all’intelligenza linguistica e logico-matematica più che a quella propriamente digitale, che, a nostra detta, non si confonde con le due menzionate, anche se sicuramente è relazionata a queste.
Disegnare con la parola
I nuovi strumenti informatici hanno aperto, senza dubbio, un nuovo mondo all’intelligenza umana, permettendo che una capacità cognitiva data si possa esprimere in differenti formati. Una delle trasformazioni più notevoli è stata l’introduzione di strumenti digitali per disegnare. Nel passare da un disegno fatto a mano a uno fatto con il computer si cambiano non solo i comandi motori, ma anche la concezione stessa del disegno. Prendiamo il caso, al quale abbiamo avuto il privilegio di assistere, di un architetto che nel mezzo della sua carriera di successo rimase tetraplegico perché colpito da sclerosi multipla (Battro 1991 e 2000, Battro e Denham 1997). Grazie alla sua poderosa intelligenza e straordinaria volontà, superò questo momento critico e riuscì a rimpiazzare le sue mani con un computer e un programma di riconoscimento vocale, con i quali è potuto tornare con successo alla sua professione. In questa trasformazione “digitale “ ha ricevuto l’appoggio e la devozione della sua famiglia e dei professionisti che lo hanno assistito fino alla sua scomparsa, per cui tutti sentiamo profondo dolore.
Il suo esempio ci ha aiutato a capire in che modo la corteccia cerebrale può sostituire un disegno convenzionale, “analogico e continuo”, fatto a mano con una matita, con un controllo “digitale e discontinuo” realizzato con la sua voce, con ordini vocali. In questo caso, il computer ha agito come un’interfaccia che ha permesso di trasferire il controllo corticale dei movimenti della mano e delle dita necessari per disegnare, ora ostacolati dalla malattia, alle zone che processano la parola, specialmente l’area di Broca. Così, con queste risorse informatiche, l’architetto riuscì a sviluppare una nuova e originale intelligenza digitale, una capacità cognitiva superiore di tipo nuovo, quella di “disegnare con la parola”. È interessante sottolineare come lui non avesse mai utilizzato un computer prima di porsi in contatto con noi, stimolato dal suo desiderio di superare la disabilità motoria. Abbiamo fatto varie prove per trovare la miglior interfaccia che potesse eliminare la tastiera, fino a che abbiamo trovato a una soluzione elementare, il linguaggio di programmazione Logo per disegnare, che si poteva attivare con istruzioni vocali molto semplici (avanti, indietro, con la penna, eccetera). I primi tentativi furono stimolanti e in poche sessioni l’architetto riuscì a produrre figure lineari in due o tre dimensioni (Reggini 1985). Una volta che comprese il potere del disegno di questi sistemi digitali semplici, passò senza maggiori difficoltà al CAD (computer aided design) sfruttandone tutto il potenziale grafico, e tornò a produrre disegni e piani architettonici di alta qualità professionale.
Il controllo vocale di un processo di disegno non è semplice e presuppone il trasferimento da un comando motorio a uno linguistico. Si tratta di un cambio della corteccia cerebrale (cortical shift), di un originale “cambio digitale” (digital shift), che si realizzò, in questo caso, con l’aiuto di un riconoscitore vocale abbinato a un software per il disegno. Era meraviglioso osservare il lavoro che si realizzava nella sua “nicchia digitale”. Dalla sua sedia a rotelle, oltre a disegnare, controllava un congiunto di strumenti attraverso comandi vocali per ascoltare musica, scrivere testi, usare il telefono, la televisione e la radio. Ma, l‘applicare questa nuova abilità digitale al disegno tecnico fu il risultato di un’agenda rigorosa e ascetica. In primo luogo, dovette allenare il riconoscitore vocale perché identificasse circa 150 istruzioni di CAD e, successivamente, dovette costruire una base di dati dei disegni di elementi in due o tre dimensioni più comuni. Era solito dire che “ci sono mille modi di produrre un progetto architettonico con il computer, però solamente uno che dà senso di armonia e piacere estetico”. Inviava i suoi progetti e si collegava con i colleghi dal suo studio, tramite modem, in particolare con il figlio, architetto anche lui, che imparò a usare il computer per aiutare il padre. È un fatto, un detto comune, che, molte volte, è proprio la persona con disabilità quella che promuove una coscienza digitale in chi gli sta vicino.
La scelta-clic, condizione sufficiente.
Pensiamo che l’intelligenza digitale si basi sulla selezione di un’alternativa semplice, la scelta-clic, che è l’unità fondamentale di un’euristica binaria, un’abilità di portata eminentemente pratica.
Questa scelta si esprime, in differenti ambienti o supporti, nel processo elementare di schiacciare bottoni, manovrare manovelle, premere interruttori di ogni tipo, che la cultura industriale da due secoli a questa parte ha sviluppato in amplissima varietà in molti tipi di dispositivi elettronici ed elettromeccanici. Dobbiamo però riconoscere che questa “abilità digitale” ha avuto una crescita vertiginosa ed esplosiva dallo sviluppo, che data solo un paio di decadi, dei personal computer, sviluppo che ha dato vita a una nuova cultura digitale senza antecedenti nella storia. Cercheremo ora di dimostrare che questa scelta-clic è di carattere “materiale” e non si identifica semplicemente con un’alternativa formale propria di una prospettiva booleiana. Se così fosse, infatti, la scelta-clic sarebbe compresa nell’intelligenza logico-matematica e la nostra proposta sarebbe vana.
Analizzeremo, in primo luogo, il caso di una scelta-clic che si realizza senza aiuto del computer. Si tratta della storia drammatica di Jean-Dominique Bauby, autore di un meraviglioso libro: “Lo scafandro e la farfalla» (Bauby, 1997.)3. Una lesione distrusse gran parte del suo cervello e danneggiò irreversibilmente la sua capacità motoria condannandolo a un’assoluta immobilità e dipendenza dagli altri, ma preservando la sua lucidità e coscienza. Come a volte succede in questi casi estremi di “sindrome del chiavistello” (più conosciuta con il termine inglese locked-in syndrome), Bauby poteva controllare solamente un piccolo gruppo di muscoli volontariamente, in questo caso aprire o chiudere un occhio, il sinistro. Per Bauby questo era il solo segnale che poteva trasmettere a ciò che aveva intorno. Si trattava, evide...