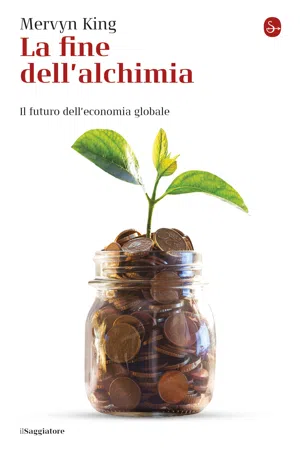![]()
1. Il Buono, il Brutto e il Cattivo
Da parte mia credo che il capitalismo, saggiamente governato, può probabilmente essere reso più efficiente di qualsiasi altro sistema ora in vista nel raggiungere obiettivi economici.
John Maynard Keynes, «La fine del laissez-faire»
Scoprire di essersi sbagliati in modo disastroso è un’esperienza salutare, che non dovrebbe essere risparmiata a nessun economista, e che infatti molto pochi non conoscono.
John Kenneth Galbraith, Una vita del nostro tempo
La storia è ciò che è accaduto prima che noi nascessimo. Per questo ricavarne lezioni è tanto difficile: a commettere quegli errori è stata una generazione precedente. Quand’ero studente, negli anni sessanta, sapevo perché gli anni trenta erano stati così duri: le decisioni dei governi e delle banche centrali si fondavano su idee economiche superate, e a prendere quelle decisioni erano personaggi all’antica, che le foto d’epoca ci mostrano con cilindro e favoriti e che non sapevano nulla dell’economia moderna. Era giunto il momento di una generazione giovane e aggiornata che, nelle università e al governo, avrebbe impedito il ripetersi di una Grande depressione come quella degli anni trenta.
Negli anni sessanta ogni cosa sembrava possibile. Idee e tradizioni superate venivano gettate via per fare largo al mondo nuovo. L’economia – la «scienza triste», l’aveva chiamata nell’Ottocento il filosofo e letterato Thomas Carlyle –1 sotto l’influenza di matematici, ingegneri e fisici si apriva a un nuovo approccio scientifico, che prometteva non solo una migliore comprensione dei fatti economici, ma anche migliori risultati.
I successivi cinquant’anni sono stati un’esperienza di luci e ombre. Il reddito nazionale del mondo sviluppato è più che raddoppiato e nei cosiddetti paesi in via di sviluppo centinaia di milioni di persone sono uscite dalla povertà estrema. Ma gli anni settanta hanno visto un’inflazione galoppante, e nel triennio 2007-2009 c’è stata la peggiore crisi finanziaria che il mondo abbia mai conosciuto. Come leggere tutto ciò? L’era postbellica è stata un successo o un fallimento?
Le origini della crescita economica
La storia del capitalismo è una storia di crescita e di innalzamento degli standard di vita, inframmezzata da crisi finanziarie generalmente imputabili a nostri errori nella gestione del denaro e delle banche. Il mio collega cinese aveva detto una verità importante, profonda. La crisi finanziaria del triennio 2007-2009 (che d’ora in poi chiamerò «la crisi») non è stata colpa di questa o quella persona o di politiche economiche: è stata la più recente manifestazione della nostra incapacità collettiva di gestire il rapporto tra la finanza (il modo in cui sono strutturati il denaro e le banche) e il sistema capitalistico. La maggior parte dei resoconti della crisi non valorizza questo fattore e si concentra sui sintomi anziché sulle cause sottostanti. Dobbiamo ancora fare molta pratica, è vero, ma non per questo l’economia capitalista è inevitabilmente condannata all’instabilità e al fallimento: dobbiamo solo impegnarci di più per capire come farla funzionare.
Per molti anni l’economia capitalista si è dimostrata la strada più efficace per sfuggire alla povertà e conquistare il benessere. Il capitalismo, nell’accezione che ne do qui, è un sistema economico in cui i proprietari privati del capitale ingaggiano altre persone pagando un salario affinché lavorino nelle loro imprese e fanno investimenti raccogliendo denaro dalle banche e dai mercati finanziari.2 A supporto del sistema capitalistico l’Occidente ha creato una serie di istituzioni: lo stato di diritto per garantire il rispetto dei contratti tra privati e tutelare i diritti di proprietà, la libertà intellettuale per favorire l’innovazione e la circolazione pubblica di nuove idee, le norme antitrust per promuovere la concorrenza e infrangere i monopoli, infine vari servizi e reti come l’istruzione, l’acqua, l’elettricità e le telecomunicazioni, che sono pagati dalla collettività e formano un’infrastruttura a sostegno di un’economia di mercato ben funzionante. Queste istituzioni creano un equilibrio tra libertà e restrizioni, tra concorrenza sfrenata e regolamentazione; si tratta di un equilibrio delicato, che ha avuto bisogno di tempo per svilupparsi3 e ha profondamente cambiato il nostro standard di vita. Se infatti l’economia cresce del 2,5 per cento l’anno (come è accaduto nell’America del Nord e in Europa dopo la Seconda guerra mondiale), nell’arco di un secolo il reddito nazionale totale aumenta di dodici volte: un’autentica rivoluzione.
Negli ultimi due secoli siamo arrivati a dare per scontata la crescita. A metà del Settecento Adam Smith capì che lo straordinario cambiamento economico della sua epoca – il passaggio cioè da un’era di relativa stagnazione economica (in cui la produttività, ossia la produzione pro capite, era rimasta sostanzialmente invariata, a parte gli incrementi riconducibili alla scoperta di nuovi territori o di nuove risorse naturali) a una situazione di crescita prolungata e ininterrotta della produttività – era dovuto a un fattore preciso: la specializzazione. Se gli individui si concentravano su determinati compiti (attraverso la divisione del lavoro) e impiegavano beni strumentali, potevano moltiplicare enormemente la propria produttività rispetto al «faccio tutto io». Per illustrare il suo ragionamento Smith portò il celebre esempio di una fabbrica di spilli:
Un operaio […] potrebbe forse a malapena, impegnandosi al massimo, fare uno spillo al giorno, e certamente non potrebbe farne venti. Ma nel modo in cui ora viene svolta, non soltanto questa attività è un lavoro specializzato, ma è divisa in molti rami, la maggior parte dei quali parimenti specializzati. Un uomo svolge il filo metallico, un altro lo drizza, un terzo lo taglia, un quarto lo appuntisce, un quinto lo arrota nella parte destinata alla capoccia. […] la fabbricazione di uno spillo è così distinta in circa diciotto distinte operazioni, che in talune fabbriche sono eseguite da mani distinte […]4
La fabbrica descritta da Smith riusciva a produrre, con dieci uomini, oltre 48000 spilli al giorno.
L’applicazione di know-how tecnico a un numero sempre maggiore di attività accentuò la specializzazione e accrebbe la produttività. La specializzazione si accompagnò con due esigenze ancora più urgenti: da un lato quella di un mezzo per scambiare i frutti del proprio lavoro con una gamma sempre più varia di beni creati da altri specialisti (il denaro), dall’altro quella di un modo per finanziare l’acquisto di beni strumentali che rendessero possibile la specializzazione (le banche). I lavoratori si specializzavano, il fabbisogno di macchinari e investimenti di capitale aumentava e il ruolo del denaro e delle banche cresceva. Dalla metà del Settecento in poi, dopo un millennio di produzione pro capite sostanzialmente invariata, la produttività iniziò ad aumentare lentamente ma con costanza.5 Il capitalismo stava realizzando i beni che aveva promesso. Gli storici discutono ancora oggi sui motivi per cui la Rivoluzione industriale avvenne in Gran Bretagna: gli studi più recenti sottolineano fattori come l’aumento della popolazione, l’abbondante disponibilità di carbone e ferro, il sostegno delle istituzioni, le convinzioni religiose e così via. Ma è certo che tra le condizioni necessarie per il decollo della Rivoluzione industriale vi fu l’evoluzione del denaro e delle banche.
Quasi un secolo dopo, di fronte all’esperienza dell’industrializzazione e del massiccio trasferimento di forza lavoro dalle campagne alle fabbriche urbane, gli autori socialisti tracciarono un quadro molto diverso. Per Karl Marx e Friedrich Engels il futuro era chiaro: il capitalismo era solo una breve tappa nel percorso che avrebbe portato dal feudalesimo al socialismo. Nel Manifesto del 1848 illustrarono l’idea del «socialismo scientifico», che si accompagnava a una visione deterministica secondo cui il capitalismo sarebbe crollato, lasciando spazio al socialismo e al comunismo. Più tardi, nel primo libro del Capitale (1867), Marx sviluppò la sua tesi con dovizia di particolari. La sua previsione era che i detentori del capitale si sarebbero arricchiti sempre più e che questo eccesso di accumulazione capitalistica avrebbe provocato un calo dei saggi di profitto, riducendo l’incentivo a investire e scaraventando nella miseria la classe operaia. In effetti, nelle manifatture inglesi dell’Ottocento gli operai vivevano e lavoravano in condizioni terribili, rappresentate vividamente nei romanzi di Charles Dickens. Ma l’inchiostro delle pagine della celebre opera di Marx era ancora fresco quando l’economia britannica entrò in una fase prolungata di crescita dei salari reali (ossia dei salari monetari al netto delle variazioni nel costo della vita). La crescita della produttività e dei salari reali e la sostanziale stabilità dei tassi di profitto non si interruppero nemmeno con le due guerre mondiali, inframmezzate dalla Grande depressione degli anni trenta. Lo sviluppo economico e il miglioramento degli standard di vita divennero la norma.
Il capitalismo non è crollato sotto il peso delle sue contraddizioni interne, ma non ha nemmeno portato sicurezza economica. In molti paesi capitalisti, nel corso del xx secolo, i due mali opposti dell’iperinflazione e della depressione hanno eroso gli standard di vita e la ricchezza dei cittadini. Negli anni trenta, con la Grande depressione, la disoccupazione di massa ravvivò, soprattutto in Europa, l’interesse per le prospettive del comunismo e della pianificazione centrale dell’economia. L’economista inglese John Maynard Keynes promosse l’idea che l’intervento statale a sostegno della spesa totale in un determinato paese potesse ricreare il pieno impiego senza dover ricorrere al socialismo vero e proprio. Dopo la Seconda guerra mondiale si diffuse la convinzione che la pianificazione statale, con cui era stata vinta la guerra, avrebbe consentito di vincere anche la pace. E ancora nel 1964, in Gran Bretagna, il neoeletto governo laburista annunciò il varo di un National Plan che, ispirandosi a una versione piuttosto naïf delle idee di Keynes, si concentrava più sulle politiche di aumento della domanda di beni e servizi che sulla capacità dell’economia di produrli. Non appena la prima iniziò a correre più della seconda, il risultato fu l’inflazione. Nel frattempo, sull’altra sponda dell’Atlantico, il costo crescente della Guerra del Vietnam, dalla fine degli anni sessanta, a sua volta faceva salire i prezzi.
L’aumento dell’inflazione mise sotto pressione il quadro di riferimento internazionale entro cui avvenivano gli scambi commerciali tra paesi, basato sugli accordi di Bretton Woods (siglati nel luglio del 1944 alla conferenza internazionale svoltasi nell’omonima cittadina del New Hampshire). Quell’intesa – concepita per permettere a un’Europa danneggiata dalla guerra di ricostruire gradualmente la propria economia e reintegrarsi nel sistema del commercio mondiale – portò alla nascita di un sistema monetario internazionale in cui i paesi definivano i propri rispettivi tassi d’interesse in un quadro di cambi valutari fissi. A tal fine occorreva limitare con decisione i movimenti internazionali di capitali, che altrimenti sarebbero andati in cerca dei tassi d’interesse più remunerativi, vanificando la possibilità di preservare i differenziali nei tassi d’interesse oppure le parità di cambio. I controlli valutari erano onnipresenti, e in ogni paese esistevano limiti agli investimenti in valuta straniera. Da studente ricordo che negli anni sessanta nessun viaggiatore britannico che si recava all’estero poteva portare con sé più di 50 sterline l’anno.6
Le nuove istituzioni internazionali – il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Banca mondiale – utilizzavano risorse fornite dai paesi membri per finanziare le temporanee carenze di valuta estera di un paese o gli investimenti necessari per sostituire le fabbriche e le infrastrutture distrutte durante la Seconda guerra mondiale. L’assunto implicito era che i tassi d’inflazione dei vari paesi fossero bassi e allineati tra loro: qualsiasi perdita di competitività di un paese dovuta a un differenziale d’inflazione rispetto ai suoi partner commerciali era considerata temporanea, e andava affrontata con una politica deflazionistica che consentisse un recupero di competitività; i prestiti del Fmi avrebbero aiutato il paese a coprire il deficit commerciale a breve termine. Ma alla fine degli anni sessanta le differenze tra i tassi d’inflazione dei vari paesi, e soprattutto tra Stati Uniti e Germania, apparivano tutt’altro che passeggere. Furono queste differenze, tra il 1970 e il 1971, a condurre alla fine del sistema di Bretton Woods, cui succedette, nei primi anni settanta, un sistema di tassi di cambio «fluttuanti» in cui la forza delle varie valute dipendeva dall’offerta e dalla domanda privata sui mercati dei cambi.
L’avvento di un sistema di cambi fluttuanti alleggerì inevitabilmente la pressione sui singoli paesi a ridurre l’inflazione. Poco dopo, il mondo occidentale fu investito da due choc petroliferi: nel 1973 un embargo proclamato dai paesi arabi quadruplicò i prezzi del petrolio, e nel 1979 il blocco delle forniture seguito alla Rivoluzione iraniana provocò un ulteriore raddoppio dei prezzi. Il risultato fu la Grande inflazione: l’aumento annuale dei prezzi toccò il 13 per cento negli Stati Uniti e addirittura il 27 per cento in Gran Bretagna.7
Esperimenti economici
Alla fine degli anni settanta il mondo occidentale diede inizio a quelli che oggi possiamo considerare tre arditi esperimenti per migliorare il governo della moneta, dei tassi di cambio e del sistema bancario. Il primo consistette nell’accrescere l’indipendenza delle banche centrali al fine di ridurre e stabilizzare l’inflazione: questa scelta venne poi inquadrata nelle politiche di inflation targeting, finalizzate al mantenimento di prezzi stabili in ambito nazionale. Il secondo esperimento introdusse la libera circolazione dei capitali tra paesi e un sistema di tassi di cambio fissi sia in Europa (dove si è poi giunti a un’unione monetaria) sia in una significativa porzione dell’economia mondiale in più forte crescita, e in particolare in Cina, dove fu introdotto un tasso di cambio fisso sul dollaro: l’obiettivo di questo secondo esperimento era la stabilità dei tassi di cambio. Con il terzo esperimento furono aboliti i vincoli regolatori al sistema bancario e finanziario, favorendo sia la concorrenza e la diversificazion...