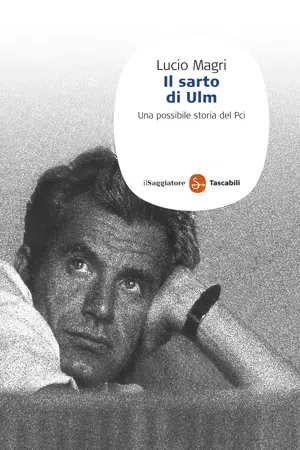![]()
1. L’eredità
Questo libro non vuole e non può essere una storia compiuta e specifica del Pci, che pure ne costituisce il privilegiato campo di indagine. È molto di meno e qualcosa di più.
Di meno, perché si concentra su di un periodo preciso, dalla svolta di Salerno agli anni novanta, nel quale la particolare identità, culturale e politica, del Pci risulta meglio definita e nel quale, per la sua forza e la sua capacità, ha avuto un’incidenza rilevante in Italia e nel mondo. Di più, perché sceglie e isola alcuni passaggi decisivi di quello stesso periodo, per integrare un’informazione gravemente carente con l’aiuto della memoria personale, o comunque direttamente raccolta. O per correggere interpretazioni e giudizi, collocandoli il più possibile nel contesto storico generale, e usando il senno di poi, e la riflessione da esso stimolata, per trarne qualche elemento, non arbitrario, per quella che si chiama «storia controfattuale», e qualche suggerimento sul presente e sul futuro.
Vorrei però premettere alcune considerazioni sia sulle generali e concrete vicende dalle quali il Pci era nato, che costituivano le sue risorse e gli opponevano dei limiti, sia su un patrimonio culturale, che si offriva al suo tentativo di innovazione. Organizzo queste considerazioni preliminari in due gruppi ovviamente distinti, ciascuno con un titolo volutamente provocatorio: «Il fardello dell’uomo comunista», che non offre scoperte originali, recupera fatti noti agli storici ma di recente rimossi o adulterati nella memoria collettiva e nella stessa cultura ufficiale; e «Il genoma Gramsci», cioè la straordinaria, sotterranea miniera di idee, che Gramsci offriva al Pci, sfruttata in modo fecondo, ma secondo convenienza e comunque solo in parte.
1.1 Il fardello dell’uomo comunista
1. Nell’ultimo quindicennio dell’Ottocento, e fino alla vigilia della Prima guerra mondiale, è emerso, in Europa ma non solo, un nuovo soggetto sociale, politico, culturale ben definito. Esso aveva alle spalle una lunga e travagliata gestazione: straordinari momenti di insorgenza rivoluzionaria (il 1848, la Comune) conclusi da altrettanto brucianti sconfitte, aspri e mai del tutto superati conflitti ideologici (anarchici, neogiacobini, socialisti utopisti ecc.); varie esperienze pratiche (sindacali, cooperativistiche, comunitarie); il tutto inserito e modellato in contesti nazionali molto diversi tra loro. Alla fine però era emerso un protagonista indiscutibilmente egemone, il socialismo di orientamento marxista, organizzato in partito, e collegato a sindacati, cooperative, giornali, riviste, su scala nazionale e con espliciti e impegnativi legami internazionali: la Seconda internazionale. Sui suoi legittimi genitori non ci sono dubbi possibili. Esso è nato da un incontro storicamente determinato. Da un lato una nuova classe, che lo sviluppo economico rapidamente produceva e rapidamente escludeva, ben definita nel rapporto tra capitale e lavoro salariato. Questa classe andava proprio allora concentrandosi nella grande industria, era capace di rivendicazioni e lotte collettive, e al tempo stesso (avendo dietro di sé la Rivoluzione francese) non era più plebe indistinta e rassegnata, poiché aveva una confusa coscienza dei propri diritti sociali e politici. Dall’altro lato un pensiero forte, il marxismo, che a sua volta aveva radici nell’eredità insieme riconosciuta e criticata della cultura moderna, offriva a quel nuovo soggetto sociale non un generico sostegno, ma strumenti intellettuali robusti per comprendere le ragioni strutturali delle sue sofferenze, per decifrare e immettersi in un’interpretazione generale della storia, per dare fondamento e plausibilità a un progetto di trasformazione generale del sistema e lo chiamava quindi a darsi un’organizzazione politica e ad assumere il ruolo di futura classe dirigente. Tale incontro non fu privo di ostacoli e controversie, ancora dopo le aggregazioni organizzative e anche tra coloro che pur si dichiaravano sinceramente marxisti. Controversie teoriche (dal «marxismo della cattedra» influenzato dal meccanicismo positivistico o dall’eticismo kantiano, all’economicismo tradeunionista); controversie politiche (sul suffragio universale, sull’importanza del Parlamento, sul colonialismo, sulle questioni operaie). Su tutto questo non occorre soffermarsi, perché esiste una vasta letteratura, ma soprattutto perché le controversie non impedirono a quel soggetto in formazione di definire comunque, anche a prezzo di qualche mediazione e di qualche ambiguità, un’identità culturale e di darsi un indirizzo politico unitario.
Utile invece, perché oscurato da successive e più aspre divisioni e oggi quasi dimenticato, è ricordare l’esito cui quel tentativo arrivò nel periodo del suo decollo, cioè la sua straordinaria ascesa, su ogni versante, nel corso di poco più di vent’anni, e i risultati ottenuti, molti dei quali permanenti. Conquiste politiche: allargamento sostanziale in molti importanti paesi dell’accesso al voto, spazi di libertà di parola, di stampa e di organizzazione, pur pagando cruente repressioni, carcerazioni, esilii. Conquiste sociali: riduzioni dell’orario di lavoro, diritto alle «coalizioni dei lavoratori», cioè alla contrattazione collettiva, primi passi di assistenza sanitaria e previdenziale e di tutela di donne e bambini, istruzione elementare obbligatoria. Crescita organizzativa (in Germania quasi un milione di iscritti) e crescita elettorale (intorno al 1910 la socialdemocrazia raggiunse, in Germania ma non solo, oltre il 35% dei voti e divenne il primo partito in Parlamento). Infine successi culturali: il marxismo penetrò nelle università (oltre che nelle fabbriche, nelle carceri e fino in Siberia), formando gruppi dirigenti di grande valore e imponendo ai maggiori intellettuali che lo avversavano di confutarlo, ma prendendolo sul serio. Anche qualche insorgenza rivoluzionaria, contro stati autoritari, sconfitta ma non inutile, come in Russia nel 1905, o vincente, come in Messico. Una così sorprendente e rapida ascesa era connessa a un’unità di fondo che, al di là dei dissidi passati o di quelli in gestazione su alcuni punti, era sufficiente a definire un’identità, a mobilitare grandi speranze in grandi masse. Non c’era socialista, per quanto riformista e gradualista, che non credesse alla necessità e alla possibilità di un superamento del sistema capitalistico come obiettivo finale del suo impegno. Non c’era socialista, per quanto rivoluzionario e impaziente, che negasse l’importanza di battaglie parziali come strumenti per migliorare, se vincenti, le condizioni di vita dei lavoratori, o almeno, se sconfitte, ma ben combattute, per acquistare un grado più elevato di consenso e di mobilitazione alla propria causa. Non c’era infine socialista che negasse la necessità di una permanente e strutturata organizzazione politica, con una precisa connotazione di classe, e come sede per formare una coscienza di classe. La parola socialista e quella comunista non si presentavano quindi in quel contesto divergenti, tanto meno incomponibili, designavano anzi la differenza e la complementarietà tra una fase di transizione, più o meno lunga, e un approdo cui quella transizione doveva portare.
Basta il semplice restauro della memoria di quella fase fondativa a dirci qualcosa di importante su tante sciocchezze che tormentano la discussione dei nostri giorni. Soprattutto quanto sia stato fondamentale il contributo del movimento operaio marxista alla nascita della democrazia moderna, nei suoi caratteri essenziali e distintivi: sovranità popolare, nesso tra libertà politica e condizioni materiali che la rendano esercitabile. Quanto sia stato importante il nesso tra organizzazione, pensiero strutturato, partecipazione di massa per fare di una plebe, o di una moltitudine di individui, un protagonista collettivo della storia reale. Infine, quanto sia parimenti assurdo supplire oggi a un vuoto di analisi e di teoria riverniciando dietro nuovi nomi idee già logore e battute un secolo fa, come l’anarchismo; o usare parole antiche, come socialdemocrazia, per indicare idee o scelte del tutto diverse da ciò che erano nate per indicare.
2. Nel giro di pochi anni, però, quel movimento che sembrava avviato a essere una «potenza» precipitò in una crisi verticale, si ruppe in molti frammenti. Perché? Perché si scontrò con un evento tanto sconvolgente quanto difficile da leggere e da governare: la Prima guerra mondiale.
Sembra ben strano, se non fosse rivelatore, che, ancor oggi, l’acceso dibattito sul Novecento, e in particolare sui suoi aspetti tragici, abbia trascurato o marginalizzato quel passaggio storico fondamentale e «costituente» per l’intero secolo. A dire il vero, l’incapacità di elaborare una convincente spiegazione di quella guerra, delle sue cause, della sua portata e delle sue conseguenze non è sorprendente in sé. L’intera generazione che la visse e vi partecipò con convinzione, presto ne misurò concretamente la tragedia: milioni e milioni di morti e di invalidi, economie demolite, stati e imperi che si dissolvevano, particolarmente nei paesi perdenti ma ovunque in Europa, colpirono l’intera società, quasi tutti gli strati sociali, certezze e culture che sembravano consolidate. La sorpresa era stata grande per tutti, perché ragioni e responsabilità di un tale disastro sembravano, in quel momento, inspiegabili, non c’era una crisi economica o sociale che spingesse a un conflitto militare di quelle dimensioni e a quei costi, la spartizione coloniale del mondo si era quasi conclusa con mediazioni accettate, la competizione tra le potenze per l’egemonia, pur evidente, si svolgeva sul terreno finanziario e tecnologico. Le stesse classi dominanti, pur da tempo impegnate in un riarmo a scopo dimostrativo, non prevedevano e non auspicavano una guerra mondiale, le alleanze tra loro apparivano casuali e contraddittorie al loro interno, fino all’ultimo riluttavano al passo decisivo. Ma poi, la scintilla di Sarajevo e una concatenazione quasi casuale di provocazioni fatte alla leggera avevano portato al precipitare di una guerra mondiale, alla quale i nuovi armamenti davano il carattere mai conosciuto di «guerra totale». E masse enormi vi parteciparono con la piena convinzione di «difendere la propria patria e la propria civiltà», sopportando il ruolo di «massa da macello». Questa duplice e contraddittoria coscienza («la guerra come incidente» o la «guerra di difesa dall’aggressore») segnò a lungo la memoria collettiva, cui concorse anche la grande intellettualità. Più tardi intervenne, critica ma altrettanto limitativa, la teoria – Croce ne è un esempio – della «parentesi di irrazionalità»; infine, prevalse stabilmente la lettura della Prima guerra mondiale come lotta tra le «democrazie» occidentali (che però erano al momento anche le maggiori potenze coloniali) e gli imperi autocratici (peccato che il Kaiser e lo Zar combattessero in campi diversi e gli americani fossero intervenuti solo all’ultimo momento). È quest’ultima la lettura oggi codificata: la Prima guerra mondiale come anticipazione di uno scontro che poi si ripropose nella Seconda guerra mondiale e nella guerra fredda (non a caso un presidente della Repubblica italiana, brava persona, è di recente arrivato a chiamare «quarta guerra di indipendenza» quel primo conflitto che un papa aveva definito giustamente «inutile strage»). Sarebbe interessante approfondire questo discorso, dedicandolo ai tanti che assolvono il capitalismo e il liberalismo dalla responsabilità della faccia oscura del Novecento, compresi i legami che lo uniscono all’attuale teoria della guerra preventiva. Ma ci porterebbe lontano da ciò che ci interessa: le conseguenze della Prima guerra mondiale sul movimento operaio marxista, sulle sue divisioni e metamorfosi, sulla nascita del comunismo. Onestamente non si può dire che il movimento operaio sia stato sorpreso. Al contrario, già a cavallo tra i due secoli, non solo si sviluppò una discussione in cui il tema della guerra via via acquistava maggior rilievo, ma si andava direttamente al cuore del problema, se ne indagavano le cause, la si collegava a una lettura generale della fase storica, con una serietà di analisi e un impegno teorico di cui rimpiangere il livello.
Chi ritualmente ripete che il marxismo è sempre stato prigioniero di uno schema e per sua natura sempre incapace di cogliere le continue trasformazioni del sistema che avversava, può qui trovare una delle possibili smentite: parlo del grande dibattito sull’imperialismo, nel quale il problema della guerra era parte e conclusione proprio di diverse analisi della grande trasformazione del capitalismo intervenuta negli ultimi decenni. Questa trasformazione già obbligava a rivedere molte delle previsioni contenute nel Manifesto di Marx, e delle strategie a esso legate, investiva e collegava fenomeni diversi e contraddittori. Tanto per citare i più importanti: il salto tecnologico, allora rappresentato dall’introduzione sistematica delle nuove scienze nella produzione (chimica, elettricità, comunicazioni a distanza, meccanizzazione agraria); la nuova composizione sociale, per la concentrazione del lavoro operaio in grandi impianti industriali e le differenziazioni nelle sue capacità professionali, cui si affiancava il declino del ceto artigianale e commerciale, ma anche la crescita di un nuovo e non meno numeroso ceto medio legato a funzioni impiegatizie e ancor più a funzioni pubbliche; lo spazio maggiore per concessioni salariali, in parte offerto dai proventi di uno sfruttamento coloniale meno primitivo; la finanziarizzazione dell’economia con le società azionarie e i grandi trust sostenuti dalle banche. E poi l’istruzione generale, che riduceva l’analfabetismo ancora dominante ma creava barriere di classe non meno rigide; la rapida accelerazione degli scambi commerciali mondiali e l’esportazione di capitali anche oltre i confini degli imperi, che riapriva una competizione per l’egemonia, spingeva al riarmo e accresceva il peso politico delle caste militari per sostenerla; infine, l’allargamento del suffragio che imponeva e permetteva di cercare, e spesso di ottenere, il consenso con nuovi strumenti ideologici come il nazionalismo e il razzismo.
Molto di tutto ciò fu avvertito dai gruppi dirigenti del movimento operaio con una serietà e un impegno scientifico invidiabili, ma li spingeva a interpretazioni diverse e a conclusioni, all’inizio non cristallizzate ma via via divaricanti (Lenin, Luxemburg, Hilferding, Kautsky, Bernstein e dietro di loro, partecipi, intellettuali e operai, partiti e loro frazioni, sindacati). Da una parte il nuovo capitalismo fu visto come conferma della possibilità di una via graduale, tutto sommato indolore, al socialismo, quasi un esito naturale dello sviluppo, da cui si deduceva la priorità affidata al parlamentarismo e al tradeunionismo: autoritarismo e guerra potevano intervenire nel percorso, ma erano evitabili e non l’avrebbero comunque interrotto. Da un’altra parte l’imperialismo fu visto come fase suprema e putrescente del capitalismo, l’avvio di una degenerazione: concentrazione del potere effettivo dietro la maschera di un parlamentarismo screditato e corrotto, sviluppo sempre più ineguale del mondo, antagonismo tra grandi potenze, proteso a cercare all’esterno risposte alle ricorrenti crisi di sottoconsumo, a raccogliere intorno a sé ceti medi oscillanti con il furore patriottico, e a isolare la classe operaia e i contadini. La guerra in questo caso era nel conto, ne andava denunciato il carattere imperialistico e poteva offrire un’occasione rivoluzionaria o sprofondarsi in una inutile strage. Entrambe le parti però non ritenevano la guerra imminente e, per ragioni opposte, non pensavano che avrebbe cambiato profondamente il corso delle cose. Perciò fu possibile per tutto il movimento socialista assumere un solenne impegno contro la guerra, ma non sviluppare una campagna di mobilitazione di massa che forse, data l’incertezza dei governi, avrebbe potuto almeno rinviarla o permettere di non esservi coinvolti.
Ma quando la guerra, quel tipo di guerra, scoppiò, travolse il mondo e travolse la Seconda internazionale. La maggioranza dei più importanti partiti che la componevano (con la timida eccezione di quello italiano) tradì l’impegno a opporvisi e a denunciarla. Lenin rimase solo. La parola tradimento non mi piace, e la sua ripetizione ossessiva rappresentò un ostacolo grave, successivamente, a ogni tentativo di dialogo o di convergenza, possibile e necessaria; in quel momento però era fondata. Non mi riferisco solo al voto dei parlamentari socialdemocratici sui crediti di guerra e al sostegno dei governi belligeranti, né solo alla passività e anzi allo stimolo con i quali i gruppi dirigenti contribuirono al furore patriottico dei loro militanti e dei loro elettori, all’equivoco della difesa della patria che ormai diventava volontà di vittoria. Mi riferisco al fatto che anche quando – di fronte ai morti, alla fame, all’uso cinico della «carne da macello» da parte delle caste militari – i popoli, non solo nei paesi perdenti, cominciarono ad aprire gli occhi e si produssero delusione, rabbia, diserzione, scioperi (anzi, anche dopo la conclusione della guerra), quei gruppi dirigenti mantennero ferma un’intesa con gli apparati burocratici e con la casta militare, per garantire la loro continuità e chiamarli a «garantire l’ordine». Rifiutarono sia un’improbabile rivoluzione sia un serio tentativo di democratizzazione politica e di riforme sociali, ruppero cioè con le proprie stesse radici. E ne pagarono il prezzo: come forza politica e come pensiero quella che ancora si chiamava socialdemocrazia rimase per decenni marginale, dispersa, impotente, e ritrovò un ruolo importante solo dopo la Seconda guerra mondiale, modificando in sostanza la propria identità socialista in liberaldemocratica, ala sinistra, nel bene e nel male, nel campo occidentale.
Dall’altro lato chi sulla guerra aveva avuto ragione, e dalle insorgenze popolari sperava di intravedere l’esito di una rivoluzione socialista, dovette constatare la propria minorità, cercare scorciatoie e subire sconfitte e repressioni nell’Occidente europeo, si raggruppò intorno al pensiero leninista (convinto richiamo e insieme revisione profonda del marxismo originario) e intorno alla sola eredità effettiva che la guerra aveva lasciato: la rivoluzione, in un grande paese arretrato e destinato a un lungo isolamento, la Russia. Qui dunque nacquero la forza e il richiamo, e altrettanto le difficoltà e i limiti, di un nuovo soggetto politico che decise di chiamarsi comunista, che ambiva a un ruolo mondiale, ed effettivamente lo esercitò per molti decenni.
Arriviamo così al tema più controverso ma ineludibile di una vera nuova riflessione sulla questione comunista. Quello che segna il limite estremo tra revisione, critica e abiura e, paradossalmente, è rimasto marginale e implicito nel dibattito storico e politico degli ultimi anni: la lettura e il giudizio sulla Rivoluzione bolscevica e il suo consolidamento in un grande Stato e in una organizzazione internazionale.
È stata una scelta sciagurata che portava già dall’origine in sé i cromosomi delle peggiori degenerazioni, e alla fine si è autodissolta dopo aver fatto danni pesanti? Allora non occorre spaccare il capello, ricostruire un processo storico nel suo contesto: basta individuare quei cromosomi, far parlare il fatto della sconfitta finale, lasciarlo al solo lavoro accademico, politicamente archiviarlo. La «spinta propulsiva» dell’Ottobre non si è mai esaurita, semplicemente non c’è mai stata. Oppure la Rivoluzione russa è stata un grande evento propulsivo per la democrazia e l’incivilimento, successivamente tradito dal potere personale e dalla burocratizzazione, senza rapporto con il contesto storico dal quale era originato e in cui si collocava? Allora basta una robusta denuncia dello stalinismo, una franca critica di chi non lo ha condannato in tempo, la fierezza dell’antifascismo, per sentirsi liberi di cominciare da capo, in «un mondo nuovo».
La mia indagine sul comunismo italiano nella seconda parte del secolo vorrebbe appunto contribuire a una valutazione più seria e circostanziata di quel che la Rivoluzione russa ha avviato. Ma non potrebbe neppure cominciare, e risulterebbe falsata, senza un breve accenno alle vicende di quella fase: gli anni tra le due guerre. Perché proprio su quelli si sono accumulate nella memoria censure ed equivoci di cui occorre sbarazzarsi. E perché in quella vicenda il comunismo italiano ha poi trovato sia le risorse, sia i limiti, per la costruzione di un grande partito di massa e la ricerca di una propria «via al socialismo».
3. La Rivoluzione russa non ci sarebbe stata, né avrebbe retto, senza Lenin, il Partito bolscevico, il suo insediamento nella pur minoritaria ma concentrata classe operaia, il livello e la saldezza del suo gruppo dirigente, non diviso ma allargato dalla confluenza del gruppo trockista e dal rientro di tanti esuli già formati in vari angoli dell’Europa. Ma ancor meno ci sarebbe stata senza la guerra mondiale. Furono la disgregazione dello Stato autocratico, la fame nelle città, i milioni di contadini semianalfabeti strappati ai loro villaggi per combattere, la loro insorgenza in un’armata in disfatta e la delegittimazione dei suoi vertici a renderla una scelta possibile. I soviet non furono l’invenzione di un partito, quanto una spinta organizzativa indotta dalla necessità e dalla rabbia, avevano alle spalle il 1905, e in essi si svolse un’effettiva lotta per l’egemonia nella quale si affermò un’autorità riconosciuta e prese forma un programma. Lenin, che pure aveva già elaborato la teoria dello sviluppo ineguale, e dunque della rottura a partire dagli anelli più deboli della catena, aveva resistito a lungo all’idea che essa potesse assumere un carattere socialista, tanto meno consolidarsi, in un paese economicamente e culturalmente arretrato (per questo aveva confutato l’idea trockista della rivoluzione permanente). Ancora all’inizio della guerra, era convinto che la Russia doveva e poteva essere il punto di innesto di una partita il cui esito si sarebbe giocato in Occidente, là dove il socialismo poteva contare su basi «più solide». La scelta di conquistare subito e direttamente il potere statale fu presa da lui, e contro molte esitazioni dei suoi compagni, quando non solo il potere esistente era in una crisi irrecuperabile. La maggioranza del popolo voleva fermamente la Repubblica, la terra, la pace immediata, che i partiti liberaldemocratici non volevano né potevano concedere. Il potere ai soviet e la conquista del Palazzo d’inverno avvennero su quel «programma minimo», cui si aggiungeva la nazionalizzazione delle banche, luogo e strumento del capitale estero. La rivoluzione non aveva alternative, se non la restaurazione del potere autocratico o la precipitazione nell’anarchia e nella dissoluzione dell’unità di uno Stato multinazionale. E infatti avvenne in forma relativamente incruenta (i feriti, nella presa del Palazzo furono meno numerosi di quelli che costò la ricostruzione successiva dell’evento per un film). E aveva, nel merito, un consenso nella popolazione larghissimo, per quanto poteva esserlo in un paese immenso, disperso, analfabeta, e mai unificato se non dal mito dello Zar e da una religione superstiziosa. Nulla a che fare con un atto giacobino, da parte di una minoranza che approfittando di un’occasione conquistava il potere. A quel programma ci si attenne, anche contrastando spinte più radicali, come nel caso della pace di Brest-Litovsk.
A dar però poi forma al nuovo potere (deperimento dei soviet, sistema monopartitico, limitazione delle libertà, esecuzione della famiglia imperiale, polizia segreta) fu la vocazione, come oggi si dice, autoritaria del leninismo, o la coerente ed estrema applicazione di alcuni concetti apertamente formulati da Marx («violenza come levatrice della storia», «dittatura del proletariato»)? A me non pare vero, o quanto meno mi pare una parte secondaria del vero. Basta rileggere e comparare due saggi di Lenin scritti a breve distanza tra loro per rendersene conto: Stato e rivoluzione, al cui centro c’è l’idea di una democrazia (che rimane pur sempre una dittatura come lo è ogni Stato) ma assume un carattere più avanzato perché fondato su istituzioni partecipative dirette, rappresenta la maggioranza del popolo e garantisce il contenuto di classe del nuovo Stato...