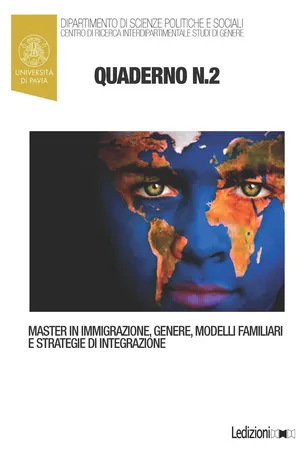![]()
“Accogliamoli tutti”: Luigi Manconi dialoga
con Laura Balbo
“Accogliamoli tutti”. È questa l’unica politica efficace in materia di immigrazione. È la soluzione più utile e produttiva per gli immigrati, ma soprattutto per gli italiani (…) l’arrivo di donne e uomini stranieri è un’opportunità di salvezza per una società invecchiata e immobile come la nostra, per il suo dissestato sistema produttivo e il suo welfare in crisi.
Le politiche dei respingimenti e della repressione, dietro cui si cela spesso un’ostilità intrisa di xenofobia e tentata dal razzismo, sono disastrose perché contrarie alle esigenze profonde dell’economia e della società. Sono politiche costose, che favoriscono l’aumento della criminalità e il lavoro nero.
Riconoscere diritti e offrire occasioni di inserimento agli immigrati è invece la scelta più opportuna per la sicurezza collettiva, per risolvere i drammatici problemi demografici e rilanciare industria e agricoltura. Non solo badanti, infermieri e pizzaioli: i dati testimoniano che già oggi i lavoratori stranieri sorreggono interi settori, senza entrare in competizione con i lavoratori italiani. Valorizzando i numerosi esempi di “piccole virtù” e buone prassi locali e inserendoli in un quadro meno incoerente e frammentato dell’attuale, i benefici saranno tangibili per tutti.
Certo, l’integrazione è un processo faticoso e spesso doloroso, che solleva molteplici dilemmi sociali e culturali. Accogliamoli tutti è un’utopia: una concretissima e possibile utopia”.
(da L. Manconi, V. Brinis, “Accogliamoli tutti. Una ragionevole proposta per salvare l’Italia, gli italiani e gli immigrati”, Il Saggiatore, 2013).
In occasione dell’inaugurazione della VI edizione del Master in “Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione” tenutasi il giorno 28 marzo 2014, il Senatore Luigi Manconi, Presidente della Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani del Senato e docente di Sociologia dei Fenomeni Politici insieme alla dott. Valentina Brinis, ricercatrice, hanno dialogato sul tema dell’immigrazione in Italia con la prof. Laura Balbo, sociologa e già Ministro delle Pari Opportunità durante il Governo D’Alema nel corso della XIII legislatura.
BALBO
Pur nella consapevolezza dell’impossibilità materiale di analizzare in maniera approfondita in questa sede il fenomeno migratorio, possiamo sfruttare questa occasione per sottolineare l’importanza che tale fenomeno andrà assumendo nei prossimi anni attraverso uno sguardo al contesto europeo e internazionale. Questioni, queste, che, soprattutto ai giovani, non devono restare sconosciute.
MANCONI
Propongo di introdurre la conversazione ricordando il ruolo svolto dall’emigrazione italiana nel mondo per lo sviluppo sociale e globale: è significativo e grave che tali eventi rischino l’oblio nella memoria collettiva, che ciò si traduca in una diffusa inconsapevolezza circa il nostro passato di migranti e che tale inconsapevolezza sia alla radice di molti dei fenomeni di intolleranza e pregiudizio che vediamo oggi accadere nella vita sociale del nostro Paese.
Le stime relative all’immigrazione italiana nel mondo ci dicono che in centoventi anni dal nostro Paese sono partiti più di trentacinque milioni di italiani diretti verso altri Paesi europei, le Americhe, l’Australia.
Intendo introdurre così una considerazione che accomuna in un rapporto di causa ed effetto la mancanza di un’autoriflessione sulla nostra storia, la diffusa ignoranza su tale storia e l’attuale atteggiamento in tema di immigrazione e di immigrati. Il nostro essere stati emigranti in simili proporzioni dovrebbe costituire motivo di riflessione per determinare l’atteggiamento che oggi noi abbiamo verso coloro che emigrano in Italia.
Ma nel nostro Paese non si è fatta tradizione popolare ed etica di tale passato perché la classe intellettuale non vi ha lavorato adeguatamente e la classe politica non ne ha colto il senso.
Un tipico esempio della mancata elaborazione a livello di tradizione identitaria del processo migratorio e delle relative cause è dimostrata da tragici accadimenti declassati ad episodi marginali, come la tragedia avvenuta nella miniera di carbone di Marcinelle in Belgio dove la mattina dell’8 agosto 1956 persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. Tragedia di cui restano pochissimi documenti storici.
I dati numerici che fotografano l’attuale condizione dello Stato italiano mostrano un Paese in cui la fascia di cittadini italiani che supera i 65 anni d’età costituisce il 12% dell’intera popolazione e dove dunque, a fronte di un italiano ultra sessantacinquenne ogni cinque persone, vengono attualmente impiegati nei settori della cura e dell’assistenza domiciliare 1.700.000 badanti, quasi tutte straniere. Numero al quale va aggiunto il dato sommerso relativo alle presenze non regolarmente denunciate.
A fronte di un’organizzazione familiare che non è in grado di rispondere a tali bisogni e della proiezione che, alla luce dell’allungamento della durata della vita media, individua un aumento nel futuro del fabbisogno di assistenza ai non autosufficienti, è ragionevole ritenere che il lavoro straniero, nella sua forma regolare, possa rappresentare un valido se non indispensabile sostegno al sistema previdenziale e di welfare.
Alla luce di queste considerazioni, potremmo concludere affermando che, se noi ci limitassimo a considerare anche solo questo segmento del mercato del lavoro, apparirebbe evidente l’assoluta necessità dell’apporto del lavoro degli immigrati in un tipo di attività che i lavoratori italiani non hanno interesse a svolgere.
È vero che gli stranieri hanno bisogno dell’Italia, ma è altrettanto vero che l’Italia ha bisogno degli stranieri.
Giunto a questo punto mi pare opportuno spiegare il principio che ha guidato la realizzazione del libro di cui sono autore insieme a Valentina Brinis, principio che è contro la retorica dei buoni sentimenti ed in particolare contro il buonismo. È nostra opinione, infatti, che i buoni sentimenti che costituiscono la categoria etica della solidarietà debbano ascriversi unicamente alla sfera delle motivazioni personali.
L’atteggiamento di accoglienza che si ispira alla solidarietà è virtù che riguarda il singolo, la sua sfera privata. Le tesi sostenute in Accogliamoli tutti, al contrario, si basano su calcoli e dati di natura economica, sociale, demografica e giuridica e si misurano unicamente con questi.
BALBO
L’analisi del processo immigratorio in Italia risale alla metà degli anni ‘80 del secolo scorso quando, nell’arco di poco meno di un lustro, la presenza straniera nel Paese passò da 50.000 ad un milione di presenze e non occorre certo sottolineare come sia il dato demografico a determinare le politiche pubbliche e le chance offerte agli immigrati.
Vorrei ricordare quando io e Luigi Manconi abbiamo cominciato a studiare il fenomeno, le formule che adoperavamo per inquadrare la fatica della relazione fra italiani e stranieri e le esperienze della partecipazione ai comitati di quartiere a Milano dove venivano per la prima volta affrontate a livello popolare le problematiche legate alla presenza immigrata. La consapevolezza che l’Italia stava diventando una società razzializzata e il rischio di una fuorviante retorica delle parole.
MANCONI
La questione del razzismo: alcune formule che allora usavamo… una ruvida consapevolezza che si sperava si diffondesse, alcune nostre posizioni venivano non solo criticate ma anche combattute da molti della nostra stessa parte politica, perché sembravano minimaliste, troppo deboli rispetto al rischio che si potessero sviluppare in Italia comportamenti razzisti. In realtà, l’opera che si cercava di svolgere con un intento pedagogico era di sottolineare la fatica della relazione tra italiani e stranieri perché ritenevamo che certe formule usate da una certa parte politica tendessero a sottovalutare i problemi, a non vedere le contraddizioni implicite al cambiamento sociale in corso, ad assumere una nuova retorica che gratificava l’ego ideologico indicando l’orizzonte possibile di una società integrata d...