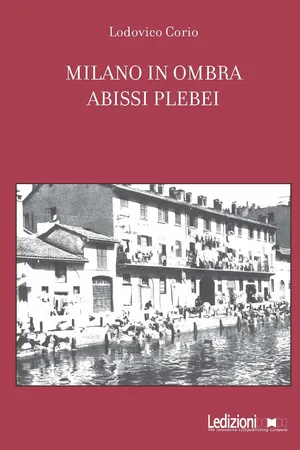Il carcere
La miseria, il delitto, il rimorso, il sospetto, il timore continuo della punizione, non rendono così incresciosa la vita alla feccia plebea quanto la perdita della libertà. è questa un bene tanto prezioso che, in qualunque modo limitato, quanto ne resta è pur sempre un bene assai pregevole, e la minaccia e il dubbio continuo di perderla sono cagione di farla reputare carissima.
Fino a pochi anni or sono in Milano gli oziosi, i vagabondi, i ladruncoli venivano ritirati in carceri grandiosi a sistema in comune o di famiglia come erano appunto le carceri di San Vittore.
Quantunque la vita che vi si conduceva non fosse molto noiosa, tuttavia, quando il lôcch vi entrava, aveva la faccia rabbuiata e stravolta, gli occhi invetriti o mobilissimi secondo le passioni, da cui era commosso. Sempre al momento d’essere rinchiuso in prigione, nell’animo del captivo sovr’ogni altro sentimento domina non dirò il dolore, ma il dispetto per la perduta libertà.
La Chiesa da’ Cappuccini di San Vittore da gran tempo era stata divisa in grandi celle, ciascuna delle quali poteva capire fin cento individui. Queste prigioni quasi sempre rigurgitavano di detenuti, perché quella disgraziata parte del genere umano sempre si riproduce, nè altrove si afforza tanto, quanto nelle carceri che la società costrusse per annientarla.
Le prigioni, tenute con questo sistema, non hanno mai raggiunto lo scopo che per mezzo loro il legislatore si propone di ottenere. Infatti la privazione della libertà è, secondo lo spirito della legge, una pena, non già una vendetta, e come pena deve tendere a sviare l’animo dell’uomo dal delitto, verso il quale l’uomo è spinto dalle sue prave passioni. La pena è in conclusione la controspinta, e perciò deve essere logica e morale. Il carcere a sistema di famiglia non è nè logico nè morale. Non è logico, perché per punire dei delinquenti di niun conto li accomuna con altri di peggior conto, e questi servono di scuola a quelli, e quindi invece di reprimere il male lo favorisce e quasi lo promuove; non è morale, perché impedisce a colui che fu arrestato di ridiventare galantuomo, giacché quando viene rilasciato in libertà esce dal carcere inviluppato da conoscenze infami, dalle quali non gli è facile liberarsi.
Poiché (diceva l’illustre Carlo Cattaneo riassumendo alcune idee del Romagnosi intorno a siffatta materia) se il progresso dei tempi e il predominio della ragione introdussero nel carcere la disciplina, la salubrità, la nettezza, la luce, il lavoro, non giunsero ancora a togliere la convivenza depravatrice.
Il carcere riceve il novizio del delitto, reo forse d’una lieve infedeltà, tutto ansante di vergogna, di spavento, di rimorso e lo dimette dopo pochi mesi, indurato nel cuore, dotto nei misteri dell’iniquità, abbronzato nell’impudenza, consumato e disperato al pari de’ suoi insegnatori.
La promiscuità fra giudicati e giudicandi, fra colpevoli e innocenti, fra i trasgressori di qualche frivola disciplina politica o civile e gli esseri più abbominevoli od infami non giova certo ad impedire il male.
La pena del carcere è una tremenda necessità sociale, bisogna quindi ch’essa venga inflitta con criterio indipendente da ogni passione e scevro da ogni pregiudizio, affine di non aggravare l’infelice condizione di tanti sventurati.
Non v’è anima bennata la quale, pensando alla serie indefinita di dolori, che dalla istituzione di siffatta pena insino ad oggi si soffersero nelle carceri senza la pausa d’un’ora sola, non senta quanto grave sia il còmpito dell’uomo che s’accinge a calcolare con austerità scientifica la quantità di miseria e d’angoscia che deve infliggere a moltissimi de’ suoi simili, come pena de’ loro mancamenti, pena che non sarà e non potrà dirsi legittima, se non quando la società abbia provvidamente procurato di volgere al comun bene le umane passioni. E la nostra società non vi ha ancora provveduto.
Ora, scrisse il grande pensatore testè citato, egli è certo che gli allettamenti e gli stimoli al mal fare sono maggiori, dove le plebe è disperata per miseria, o cresce ineducata e brutale, o i magistrati non vegliano a scoprire i delitti, o il braccio di una debole giustizia si abbassa dinanzi ai protetti del potente. Nè ciò basta, perché dove gli uomini sono onesti solo entro il limite della paura, e nella società non circola uno spirito largo e vigoroso di morale e di probità, il fragile edificio delle pene non regge al peso morto della corruzione universale.
Perocchè bisogna coltivare negli uomini quell’impulso d’onore che non solo rattiene dal delitto, ma ne rende insopportabile il minimo sospetto; bisogna infliggere quanto più raramente si può l’ignominia, e far quasi economia delle erubescenze del popolo; bisogna promuovere fra gli uomini i vincoli dell’azienda civile, perché sentano il bisogno della mano altrui e della buona opinione...
Le leggi al presente puniscono ma non prevengono il delitto; e correrà gran tempo ancora prima che la società pensi al miglioramento dei membri che la compongono, e tuttavia seguiterà a colpire in egual modo gl’infelici ed i colpevoli. Giacché moltissimi operai sono dalla miseria tratti al delitto, e molti fra essi ignari del valore assoluto e relativo di un’azione criminosa.
La maggior parte dei delinquenti sono analfabeti; essi non hanno altra guida delle opere loro che l’istinto, poiché nessuno s’è curato di ridestare in essi il sentimento morale, epperò trovansi quasi alla condizione di bruti. Per costoro le leggi sono lettera morta, sanno che esistono delle leggi, perché tratto tratto vengono dal rigore di esse colpiti, ma non sanno il perché queste leggi esistano, nè da chi siano state fatte, meno poi se ve n’ha qualcuna che favorisca i miserabili. Tratto tratto questi vengono arrestati, poscia rilasciati per essere indi a poco arrestati di nuovo, tanto che trovandosi sempre in carcere sono costretti a dire tra loro che quelli che vanno in carcere sono sempre gli stessi; quelli che vanno all’ospitale sono sempre gli stessi; detti questi che non si riducono ad altro che a varianti del vecchio adagio: Sono sempre gli stracci che vanno alla folla.
I pensatori assai di leggieri s’accorsero che la mescolanza dei detenuti era dannosa alla morale e che la prigione invece di correggere i tristi, pervertiva i buoni. Si pensò di imporre il silenzio a tutti i carcerati, e questo sistema punitivo dalla città di Auburn, in America, che prima l’applicò, trasse il proprio nome. Ma il sistema di Auburn non raggiunse lo scopo, perché, se soppresse la voce, non potè sopprimere le relazioni tra i carcerati, i quali acuirono sempre più il loro ingegno, affine di communicare tra loro, e studiarono e studiano tutti i mezzi per eludere la vigilanza dei loro, custodi.
Che più? I dolori stessi, la stessa severità della pena ritemprano l’animo di que’ disgraziati, i quali s’avvezzano a sopportare con altiera indifferenza persino le sferzate, per non dare spettacolo a’ compagni della loro timidezza ed è naturale che talora pensino a reagire. Nel che bene spesso sono eccitati da qualche anima ribelle e determinata a tutto osare, la quale fa nascere all’impensata terribili ribellioni. E lo spettacolo della crudeltà della pena e la smania di reazione distruggono e sviano il carcerato dal meditare sulla propria colpa e lo allontanano dal pentimento: e il lavoro impostogli quale aggravio di pena, gli riesce disamabile anzi odioso. Queste cose ben videro le Autorità preposte alle carceri, e perciò studiarono il modo, affinchè fosse tolta questa infame comunanza.
Si cominciò dal dividere i detenuti, oltrechè per sesso, per età, per delitti, per disciplina, ma questa divisione non è sempre possibile, perché ad attuarla occorrerebbero carceri assai grandiosi, giacché si verrebbero ad avere in tal guisa circa quaranta classi di prigionieri, i quali difficilmente poi potrebbero ancora essere invigilati. Inoltre perché la divisione sia ragionevole, bisogna particolareggiare sempre più nella scelta dei prigionieri destinati a restare insieme, e a forza di suddividerle è facile capire che si è obbligati di concludere che il sistema più logico è quello di tenere i detenuti separati ad uno ad uno, che è appunto ciò che fa il sistema segregante o di Filadelfia detto anche di Pensilvania, oppure di Cherry-Hill.
Questo regime è il più opportuno pei condannati, il più provvido o il più giusto pe’ giudicandi. Quelli possono riflettere alle loro colpe o mettersi sulla via del bene, questi non soffrono l’avvilimento di trovarsi con tristi, prima ancora che i tribunali abbiano pronunciata sopra di loro una sentenza di reità o d’innocenza, nel quale ultimo caso essi ritornano alla libertà incontaminati, come quando per soddisfare alle gelose ricerche della giustizia furono gettati in carcere. Il condannato poi trova nel sistema segregante il modo di ottenere il proprio miglioramento morale.
Abbandonato a sè nella solitaria cella (nota Carlo Cattaneo), a prima giunta per lo più si abbandona al furore, agita pensieri di vendetta, e sfoga la sua rabbia in maledizioni. Ma alla violenza succede l’esaurimento e la stanchezza; il silenzio che segue ai vani suoi clamori, a poco a poco gli fa intendere quanto siano infruttuosi e insensati; egli vede tutta la sua impotenza e la sua nullità in faccia alla legge che senza percosse, senza catene, senza insulti, con mano invisibile lo assedia e lo stringe. L’idea della sua colpa, ch’egli fuggiva, ch’egli sommergeva nel tumulto della vita e delle passioni gli s’affaccia da ogni parte, e a poco a poco si allarga nel suo pensiero, e dilegua tutte le vanità che lo ingombravano.
Tra il rimorso e l’impazienza e il tedio, per sottrarsi agli odiosi pensieri e dissiparsi pure in qualunque modo che gli è possibile, egli afferra rabbiosamente la proposta d’un qualsiasi lavoro. Ben pochi hanno la forza di resistere a quattro o tutt’al più ad ...