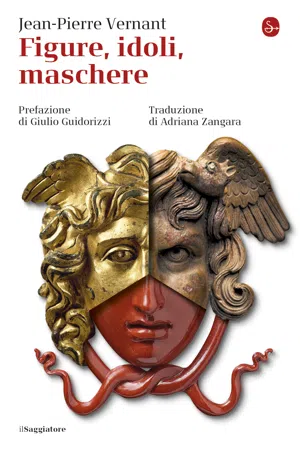![]()
PARTE SECONDA
![]()
4. La figura degli dèi I: Gorgone
Dopo la figura dei morti quella degli dèi. Nel quadro della nostra indagine sui diversi tipi di figurazione delle potenze divine in Grecia, abbiamo scelto di iniziare dalla maschera: le sue forme, i suoi valori, le sue funzioni in quanto espressione simbolica di alcuni aspetti del soprannaturale. Sono stati immediatamente distinti tre livelli di analisi. Innanzitutto, la Potenza che opera attraverso la maschera, che non possiede altra forma che la maschera, che si presenta dunque interamente come maschera: Gorgone. In seguito, la divinità che, pur senza essere essa stessa maschera, riserva, negli aspetti essenziali del suo culto, un ruolo privilegiato alla maschera e ai portatori di maschera: Artemide. Infine, la Potenza sacra le cui affinità con la maschera sono talmente profonde, da tutti i punti di vista, che il suo posto, nel pantheon greco, è quello del dio della maschera: Dioniso. Tra queste tre entità dell’aldilà gli scarti e i contrasti, ma anche le connivenze e gli slittamenti, permettono di porre il problema generale della maschera nell’universo religioso dei greci.
1. La maschera della Gorgone
Il corso di quest’anno è stato dedicato alla prima parte della nostra ricerca: la maschera della Gorgone.
Il modello plastico della Gorgone, nella sua doppia forma di gorgoneion da una parte (la maschera soltanto) e di personaggio femminile dal volto gorgonico dall’altra, non è rappresentato esclusivamente nella serie dei vasi. Compare anche, a partire dall’epoca arcaica, sul frontone dei templi, come acroterio e antefissa. Lo si trova pure sugli scudi, nella forma di episema, come decorazione su utensili domestici, appeso nelle officine degli artigiani, fissato sui loro forni, innalzato in abitazioni private, e infine inciso su monete. Questo modello, apparso all’inizio del VII secolo, si delinea nelle sue caratteristiche fondamentali intorno al secondo quarto di questo secolo. Al di là delle varianti presentate dall’iconografia corinzia, attica, laconica, è possibile distinguere, in prima analisi, due caratteristiche principali della rappresentazione della Gorgone. Anzitutto, la frontalità. In contrasto con le convenzioni figurative che regolano lo spazio pittorico greco in epoca arcaica, la Gorgone è rappresentata sempre, senza eccezione, di faccia. Pura maschera ο personaggio intero, il volto della Gorgone è sempre posto di fronte allo spettatore che lo guarda. In secondo luogo, la «mostruosità». Applicando diverse modalità di distorsione, la figura utilizza sistematicamente gli elementi comuni tra l’umano e il bestiale, associati e mescolati in maniere diverse. La testa, allargata, arrotondata, evoca un aspetto leonino, gli occhi sono sgranati, lo sguardo fisso è penetrante, la capigliatura è presentata come la criniera di un animale oppure irta di serpenti, le orecchie sono ingrandite, deformate, spesso simili a quelle del bue, la testa può portare corna, la bocca, aperta in un ghigno, si allunga sino a tagliare tutta la larghezza del volto, scoprendo la fila dei denti, con zanne di animale feroce ο di cinghiale, la lingua, proiettata in avanti, sporge al di fuori, il mento è coperto di peli ο di barba, la pelle è spesso solcata da profonde rughe. Questa faccia appare più come una smorfia che come un volto. Nello stravolgimento dei tratti che compongono la figura umana, essa esprime, per un effetto d’inquietante estraneità, una mostruosità che oscilla tra due poli: l’orrore del terrificante e il ridicolo del grottesco. Ugualmente, tra la Gorgone, che è dalla parte dell’orrore, e i Sileni ο i Satiri, che nel registro del mostruoso si situano dalla parte del grottesco, è possibile notare contrasti evidenti e al tempo stesso significative connivenze. Queste due categorie di personaggi possiedono d’altronde affinità esplicite con quel tipo di rappresentazione capace di provocare, al pari del volto mostruoso di cui per certi aspetti è l’equivalente, tanto un fremito di sacra angoscia quanto un riso liberatore.
Frontalità, mostruosità: questi due tratti pongono il problema delle origini dello schema plastico della Gorgone. Antecedenti sono stati cercati nel Vicino Oriente (Bernard Goldman), nel mondo cretese-miceneo (Spyridon Marinatos), sumero-accadico (Ernest Will). Accostamenti sono stati proposti rispetto alla figura del Bes egizio e soprattutto del demone Humbaba quale viene rappresentato nell’arte assira (Clark Hopkins). Abbiamo citato questi lavori sottolineando che, nonostante il loro interesse, non offrono ciò che per noi costituisce l’essenziale: la specificità di una figura che, qualunque siano stati i prestiti e le trasposizioni, si profila come una nuova creazione, molto diversa dalle precedenti. La sua originalità non può essere colta al di fuori delle relazioni che, nell’ambito dell’arcaismo greco, la legano a pratiche rituali, a temi mitici, e infine a una potenza soprannaturale che si libera e si afferma nel momento stesso in cui viene costruito e fissato il modello simbolico che la rappresenta nella forma particolare della maschera gorgonica.
A questo proposito, sembrano essere vani i tentativi di Jane Harrisson di fondarsi su una qualche analogia figurativa tra le Arpie, le Erinni e le Gorgoni, per connetterle tutte quante a un medesimo fondo religioso «primitivo», e farne specie diverse di Chere, spiriti nefasti, fantasmi, lordure. Non è un buon metodo quello di unire in una stessa vaga categoria figure differenti, senza preoccuparsi degli scarti che, distinguendole chiaramente, conferiscono a ciascuna una propria significazione e una particolare posizione all’interno del sistema delle potenze divine. Le Erinni non hanno né ali né maschere; le Arpie hanno ali ma non maschere; le Gorgoni soltanto, oltre alle ali, presentano anche una facies di maschera (cfr. Eschilo, Eumenidi, 48-51). Più suggestive sono le affinità, sottolineate specialmente da Theodora G. Karagiorga, tra la Gorgone e la Signora della selvaggina, la Potnia. Tra questi due tipi di personaggi esiste una certa familiarità, così come esistono similitudini ο, quanto meno, parallelismi tra le loro rappresentazioni figurate. Occorrerà tenerne conto. Per alcuni aspetti, la Gorgone appare come l’altra faccia, il volto inquietante della grande dea di cui Artemide, in particolare, assumerà l’eredità. Ma anche qui, la constatazione delle divergenze, delle distanze tra i due modelli, deve metterci in guardia nei confronti della pura e semplice assimilazione. La cosa essenziale è comprendere come e perché i greci hanno elaborato una figura simbolica che, congiungendo in una forma singolare frontalità e mostruosità, si distingue così nettamente da tutte le altre da farsi immediatamente riconoscere per quello che è: la faccia della Gorgone.
Per illustrare questi concetti un po’ astratti, ricorriamo a un esempio. Sul vaso François (risalente circa al 570 a.C.) tutti gli dèi sono rappresentati come su un repertorio; sono tutti di profilo, a eccezione di tre personaggi: la Gorgone, raffigurata sulla faccia interna delle due anse, Dioniso, che porta un’anfora sulle spalle, e Calliope, una delle Muse. Per quanto riguarda la Gorgone e Dioniso, il cui volto è rappresentato come una maschera, la frontalità non ci sorprende; in un certo qual modo, va da sé. Per Calliope, invece, potrebbe costituire un problema se la Musa non fosse rappresentata, nel corteo divino, mentre suona un flauto doppio. Ora mostreremo, prolungando le osservazioni di Paul M. Laporte a questo proposito («The Passing of the Gorgon», in Bucknell Review, 1969, n. 17, pp. 57-71), che soffiare in un flauto equivale, per molte ragioni, ad assumere la faccia della Gorgone. Alle Gorgoni dipinte all’interno delle anse corrispondono, sulla faccia esterna, le immagini della Signora della selvaggina. I due tipi di potenze si trovano quindi plasticamente associate e al tempo stesso opposte. Il loro contrasto si afferma su molti piani. Anzitutto, e soprattutto, le Gorgoni sono presentate di faccia, le Signore della selvaggina sono presentate di profilo, come tutti gli altri dèi ο eroi del vaso. Inoltre, le Gorgoni sono in atteggiamento di corsa, con le ginocchia piegate, le Signore invece sono immobili, poste diritte in atteggiamento ieratico. Le Gorgoni hanno un chitone corto, le Signore una lunga tunica che le avvolge sino ai piedi. La capigliatura delle prime, irsuta, si oppone a quella delle altre, normalmente trattenuta all’indietro sulle spalle con una fascia. Il valore della maschera dal volto gorgonico, dunque, va di pari passo nell’iconografia con tutta una serie di indizi che segnalano ambiguamente uno scarto rispetto al modello della Potnia.
È all’esplorazione della rete degli indizi e alla costruzione della combinatoria degli elementi significativi dell’immagine, del loro gioco all’interno delle diverse serie omogenee, stabilite in funzione del luogo d’origine, della natura degli oggetti, dei temi raffigurati, che dovrebbe applicarsi uno studio iconografico. Non essendo noi archeologi, ci siamo limitati a un’analisi del ruolo riservato agli animali (serpenti, ma anche lucertole, uccelli, belve, perfino ippocampi), e specialmente al cavallo, rispetto alla Gorgone. Nell’iconografia, il cavallo – ο i cavalli quando sono due in posizione simmetrica – si associano alla Gorgone a volte come parte di quella, suo prolungamento ο emanazione, a volte come il piccolo che essa nutre e protegge, a volte come la progenie che essa partorisce, ο anche come l’animale che essa a volte cavalca secondo il mito di Perseo, come il cavallo Pegaso che scaturisce dalla testa mozzata della Gorgone. Riguardo alla familiarità della Gorgone con il cavallo, esiste dunque nella rappresentazione figurata, rispetto alla leggenda, un surplus e un eccesso di senso.
In senso opposto, abbiamo interrogato i testi per domandare loro, attraverso le indicazioni circa i miti e gli elementi del rituale apparentati alla Gorgone, di illuminare la personalità, i modi d’azione, gli ambiti d’intervento, le forme di manifestazione della potenza fatta maschera.
A partire da Omero, il teatro su cui la Gorgone farà la sua apparizione e giocherà i suoi vari ruoli è già costruito. Nell’Iliade, la scena è guerresca. I testi sono Iliade, V, 738 sg.; VIII, 348; XI, 36-37. La Gorgone compare sull’egida di Atena e sullo scudo di Agamennone; d’altra parte, quando Ettore, seminando la morte nella folla, fa voltare in tutte le direzioni il suo cavallo, «i suoi occhi hanno lo sguardo della Gorgone». In questo contesto di scontro senza pietà, la Gorgone è una Potenza del terrore, associata a «Spavento, Disfatta, Inseguimento che gela i cuori». Ma questo terrore di cui essa incarna la presenza e che in un certo qual modo richiama, non è «normale»; non è connesso alla particolare situazione di pericolo nella quale ci si trova. È lo spavento allo stato puro, il terrore come dimensione del soprannaturale. Infatti, questa paura non è né secondaria né motivata, come quella che la coscienza può provare di fronte a un pericolo. È primaria. D’improvviso e per se stessa, la Gorgone produce un effetto di spavento perché si mostra, sul campo di battaglia, come un prodigio (teras), un mostro (pelor) in forma di testa (kephale), terribile e spaventosa (a vedersi e a udirsi), deine te smerdne te, con il volto dall’occhio terribile, blosyropis, lanciando uno sguardo di terrore, deinon derkomene. Maschera e occhio gorgonico, se ci si attiene all’Iliade, operano in un contesto molto definito; appaiono come elementi indispensabili all’armamentario, alla mimica, alla smorfia stessa del guerriero (uomo ο dio) posseduto dal menos, il furore guerresco; simboleggiano in qualche modo questa potenza di morte irradiata dalla persona del combattente, coperto di armi e pronto a manifestare il proprio straordinario vigore nel combattimento, e la forza, alke, che lo abita. Lo sfolgorare dello sguardo della Gorgone agisce congiuntamente al brillare del bronzo splendente, la cui lucentezza, dall’armatura e dall’elmo, sale fino al cielo e diffonde il panico. L’aperta bocca del mostro evoca con il suo spalancarsi, il formidabile grido di guerra che Achille, splendente nella fiamma che Atena fa scaturire dalla sua testa, emette a tre riprese prima del combattimento. «Come quando si leva chiaro nell’aria lo squillo di una tromba», così questa «voce di bronzo» nella bocca dell’eacide è sufficiente a scuotere di terrore le linee dei nemici (Iliade, XVIII, 214-221).
Per riconoscere le connotazioni sonore della maschera della Gorgone non è necessario accettare la tesi di Thalia Phillies Howes (A.J.A., 1954, vol. LVIII, n. 3, pp. 209-221, ripresa sotto il nome di Thalia Feldman in Arion, 1965, vol. IV, n. 1, pp. 484-494) che fa risalire Gorgo, gorgos, gorgoumai al sanscrito garg. Thalia Phillies Howes scrive: «È chiaro che un qualche suono terrificante era la forza che originariamente si trovava dietro alla Gorgone: un suono gutturale, un urlo d’animale che usciva, con un gran soffio, dalla gola, e che richiedeva lo spalancarsi della bocca». Le nostre osservazioni saranno più circoscritte e precise. Sappiamo da Pindaro (XII Pitica, 6 sg.) che dalle mascelle rapide delle Gorgoni all’inseguimento di Perseo si eleva un lamento acuto (eriklagtan goon), e che queste grida escono tanto dalla bocca delle giovani donne quanto dalle teste orribili dei serpenti loro associati. Questo grido acuto, disumano (klazo, klagge), è quello che i morti nell’Ade fanno udire dall’oltretomba (klagge nekuon, Odissea, XI, 605). Avremo occasione di tornare sulla portata di queste notazioni uditive. Ma per sottolineare, sul doppio registro visivo e sonoro, i legami della maschera della Gorgone alla mimica facciale del combattente in preda alla frenesia guerresca, insisteremo su un dettaglio significativo. Tra gli elementi che conferiscono terrore guerresco, accanto al grido spaventoso, la lucentezza del bronzo, le fiamme che si sprigionano dalla sua testa e i suoi occhi, il testo dell’Iliade (XIX, 365) aggiunge, nel caso di Achille, un’osservazione che già attirò l’attenzione di Aristarco: il battere ο il digrignare dei denti, odonton kanache. Françoise Bader, in uno studio in attesa di pubblicazione, ha illuminato di senso questo ghigno sonoro connettendolo, attraverso parallelismi con la leggenda irlandese, all’immagine del guerriero indoeuropeo che Georges Dumézil ha saputo restituirci. Ora, nello Scudo, che evoca «le teste di orribili serpenti» che seminano terrore (phobeeskon) sulle tribù degli uomini, Esiodo riprende nel verso 164 l’espressione omerica: «Il battere dei loro denti risuonava, odonton kanache pelen»; e nel verso 235, riferendosi questa volta ai serpenti sulle teste delle Gorgoni lanciate all’inseguimento di Perseo, scrive che questi mostri «dardeggiavano la lingua, digrignavano i denti per il furore (menei d’echarasson odontas), lanciando sguardi selvaggi». Fiammeggiante nelle sue armi, con...