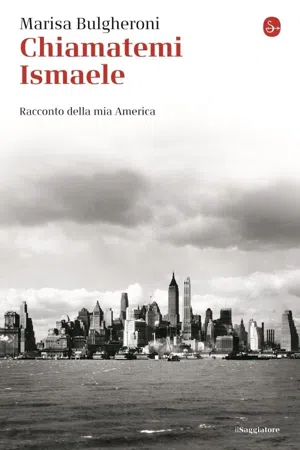![]()
Alla ricerca dell’America
America! Ognuno di noi – nati dopo la Prima guerra mondiale, cresciuti durante la Seconda – ha sognato di salpare per l’America come un solitario Cristoforo Colombo alla ricerca di un suo continente da esplorare, da raccontare, di cui verificare l’esistenza.
Io sono partita così, sola e per mare, quando l’occasione, a lungo vanamente inseguita, si è presentata inattesa: non una borsa di studio, il consueto lasciapassare dell’epoca per la mia generazione, ma il contratto con un editore, Arturo Schwarz, che mi impegnava a consegnare entro l’anno, il 1959, un’inchiesta sul romanzo americano del dopoguerra per la sua collana Enciclopedia moderna. Dovevo scrivere un libro sull’America, io che dell’America mi ero innamorata sui libri come di un luogo estremo dell’immaginazione, che un giorno mi sarebbe toccato abitare.
Ognuno di noi – nati in quella tregua tra le due guerre – si portava dentro un suo fantasma di nuovo mondo, un modello di letteratura, di democrazia, di utopia. Come Cristoforo Colombo – pensavo – avrei trovato una terra che, se non corrispondeva a quella fantastica della mia ricerca, mi avrebbe forse rivelato una parte sconosciuta di me: una vocazione al rischio, all’improvviso.
Partivo senza pregiudizi, senza impegni con le istituzioni culturali dei due paesi. Non portavo, dissimulata nei miei bagagli, la nostalgia di un’Europa con la quale confrontare continuamente la nuova terra. Viaggiavo come una clandestina che non è certa del ritorno. L’America mi aveva sedotto molto prima di conoscerla: forse più che un “amore” – come, ieri per Mario Soldati, oggi per Alberto Arbasino – un sortilegio, incanto e disincanto, sistole e diastole di un altro cuore. Dal momento in cui Manhattan apparve al mio orizzonte nella sua sghemba corona di luci desiderai possederla, esserne posseduta, a qualunque prezzo. Soldati parla di una «lontananza» liberatrice dai luoghi familiari. Al contrario, a New York io mi sentii subito “a casa”, come se lontani fossero gli altri, i rimasti in patria.
Oggi mi chiedo perché, nella mia biografia, l’America sia stata l’avventura decisiva. Mi chiedo per quale alchimia il viaggio nella terra del possibile sia coinciso per me con un’iniziazione a potenzialità inesplose. Altri viaggi mi avevano precipitato dalla provincia italiana nel mondo, trasformandomi per sempre in nomade: il deserto del Sahara, disseminato di relitti di guerra, i kibbutz israeliani, laboratori di uguaglianza, e l’inquieta Mosca di Krusciov. Soltanto l’America fu il paese a cui ritornare, la lingua mentale a cui strappare parole.
L’America era entrata nella mia infanzia con Piccole donne di Louisa May Alcott, letto per la prima volta a otto anni, e riletto poi nell’adolescenza fino ad abitarlo come un mondo alternativo, ricco di discontinuità esistenziali, guerra e pace, amore e morte, viaggi e ritorni. Quell’insospettabile saga domestica della famiglia March conteneva un seme di dissenso, diffondeva un bagliore eversivo. Quelle pagine invitavano alla ricerca di un’identità, in un gioco di travestimenti, prove, divinazioni di destini. Come tutte le future scrittrici della mia generazione, mi identificai con Jo, la seconda sorella, modello di femminilità irrequieta, riluttante ai ruoli di genere. Per Jo la vocazione alla scrittura definisce lo spazio del sogno, incrociandosi con l’impossibile desiderio americano di un’eterna giovinezza, libera dai condizionamenti di una società iniqua. Quando, cresciuta, nel secondo volume della saga, scoprirà che la parola è esplosiva, che è «polvere da sparo», Jo rinuncerà a scrivere, obbediente al canone vittoriano che le impone il ruolo di moglie e di madre. Ma non convincerà le sue lettrici: nelle pagine di Piccole donne la passione letteraria, proibita, soffia come un vento scardinante: si trasmette integrale come un progetto politico. Nella storia, in apparenza sentimentale, della famiglia March, era possibile percepire oscuramente quella forza del dissenso democratico che in quegli anni Cesare Pavese ed Elio Vittorini coglievano nella grande letteratura americana.
Quando, nell’autunno 1964, visitai Fruitlands, il luogo dello sfortunato esperimento comunitario di Amos Bronson Alcott, il padre di Louisa May, colsi da un albero una mela e la mangiai in memoria della scrittrice che aveva saputo trasformare la fumosa utopia paterna in ribelle energia narrativa, salvandomi dalla povertà delle scelte offerte a un’adolescente dalla cultura fascista.
Prima ancora che imparassi a leggere, un altro grande motivo di incantamento mi aveva avvinto a quel nome, America: il cinema muto, quasi una “lanterna magica”, immensa e impazzita, una pura seduzione visiva prodotta dal buio. Quelle immagini veloci, trascorrenti sullo schermo, si sono impresse nella mia memoria infantile come un arcano tatuaggio in bianco e nero. Conobbi Charlot, familiare, con bombetta e bastoncino, come un bizzarro parente cosmopolita, e le sue storie comiche e tristi accompagnate, nella sala del Teatro Sociale di Como, dal coro di sussurri di una parte del pubblico che ansiosamente decifrava le lunghe didascalie. Poi, con l’avvento del sonoro, arrivarono le facili risate con Stanlio e Ollio, la giungla di Tarzan, attraente come un giardino proibito. E, anni dopo, i film di Capra, È arrivata la felicità, L’eterna illusione, in cui splendeva un’America fugace che noi credevamo durevole, mentre uscivamo dal buio complice del cinema con la voglia di correre e ridere senza motivo.
Negli anni del liceo scoprii tra gli scaffali di una libreria il Moby Dick di Herman Melville tradotto da Pavese per Frassinelli: in copertina la balena bianca su un polveroso sfondo azzurro. Più che una traduzione, era una delle grandi “riscritture” dell’epoca, destinata a orientare per decenni la visione di chi, come me, si iniziasse, in solitudine, alla letteratura americana. L’intimità dell’incipit: «Chiamatemi Ismaele», estranea alla tradizione del romanzo europeo, quasi che la voce del narratore rompesse il silenzio della carta stampata, mi incatenò per ore alle seicento e più pagine del testo.
Vivendo in una città di lago, conoscevo lo sguardo sperduto dei «contemplatori dell’acqua» di cui Melville scrive nel primo capitolo per giungere alla fulminea equazione: «Acqua e meditazione sono sposate in eterno». E io stessa, nel desiderio di essere altrove – non in quella città, non in tempo di guerra –, finii per perdermi in fantasie oceaniche di fronte a uno scorcio di lago che l’immaginazione trasformava in insenatura atlantica. Melville, il baleniere letterato, scardinava la nostra idea di sistema scolastico: l’avventura della baleneria era stata per lui, maestro di scuola come Ismaele, «Harvard e Yale»; gli aveva suggerito, come mai avrebbero potuto fare gli studi universitari, narrazioni in cui imprigionare non solo le ombre e gli echi dei grandi libri del passato, ma l’alito selvaggio dei grandi spazi. I miti non appartenevano esclusivamente all’antichità: nascevano dal divenire di esperienze nuove, uniche. La storia, di cui noi liceali eravamo saturi, sembrava qui iscriversi nella natura, fissarsi rapidamente nel mito: quasi un inganno da cui scuotersi quando la balena emergeva, come il biblico Leviatano, da onde immemoriali.
Leggendo Moby Dick appresi d’istinto quanto diversa, quanto anomala, fosse la letteratura americana: il rapporto tra parola scritta e dato reale si presentava, come mai in altre, immediato, fisico: il mitico oceano di Melville sapeva di sale. Di quell’anomalia, Pavese indagò, nei suoi saggi, i motivi. E segnalò, in Melville, in Hawthorne, in Thoreau, in Whitman, l’esigenza di un linguaggio nuovo che distruggesse la barriera fra cose e parole: «fra il comune lettore e la realtà simbolica o mitica più vertiginosa». Vittorini, negli stessi anni, intuì la «grandiosa contraddizione» per cui una letteratura coloniale dalle origini dotte si liberava, nel corso dell’Ottocento, dai vincoli del culturalismo, per nascere «moderna», con una «forte voce nuova», con una «nuova leggenda».
L’America, così riscritta nei saggi di Pavese e nell’Americana e nel Diario in pubblico di Vittorini, era insieme «allegoria politica» di libertà e paese «reale» che rappresentava tutta la terra, che parlava una lingua in continuo mutamento, carica degli «aromi» di voci straniere.
Quest’immagine seducente, prodotto di una geniale mediazione, si delineò con forza eversiva contro l’orizzonte chiuso del nazionalismo fascista, delle sue ideologie, delle sue poetiche, forzando il canone ad accogliere i nuovi modelli. E perdurò a lungo nella mente dei lettori più giovani, anche quando fu sconfessata, negli anni quaranta, dai suoi stessi autori, consapevoli che, con la fine della lotta antifascista, la cultura americana andava perdendo «l’ingenuo e sagace furore» attribuitole da Pavese, e che le nuove possibili leggende annunciate da Vittorini – di un Saroyan o di un Caldwell – erano morte sul nascere. Rimase, quest’immagine, come la mappa fantastica schizzata da viaggiatori immobili sulla base di documenti certi, e generò in noi l’ansia di verificarla in un viaggio di ricerca.
Ci fu un’ultima esperienza decisiva per la mia formazione di americanista: il soggiorno di un mese – il febbraio 1954 – nel castello rococò di Leopoldskron, a Salisburgo, trasformato in laboratorio di cultura e di pedagogia americane nell’Europa divisa tra la lealtà ai liberatori degli Stati Uniti e le tentazioni ideologiche del socialismo reale. Non si parlava, allora, di molestie sessuali, punibili per legge; dubbi e sospetti rimanevano ironicamente personali; e la vita al castello, caldo di presenze intriganti e di caminetti accesi, induceva a un’imprevista intimità tra i docenti americani e gli ospiti europei – scrittori, studiosi, giornalisti – che ne ascoltavano le lezioni. Lawrance Thompson, illustre critico melvilliano, seduto tra noi sui gradini di legno di una scala a chiocciola, poteva sussurrare, sorseggiando un vino del Reno: «Chiamatemi Larry», quasi ignaro di citare il celebre incipit di Moby Dick. Un tacito incoraggiamento veniva dagli organizzatori americani che intuivano come un’esatta miscela di amore e letteratura potesse provocare uno sballo di emozioni utili alla convivenza internazionale. Difficile sfuggire ai giochi di seduzione nel chiuso del castello, o nel parco, dove, passeggiando lungo il laghetto gelato, i fiati s’incrociavano come le parole. Si favoleggiava che l’anno precedente Robert Lowell, il poeta del New England, famoso e sposato, impazzito d’amore per una ragazza italiana, fosse fuggito dal castello nella notte.
Nel 1954 il grande Edmund Wilson teneva a Leopoldskron un ciclo di lezioni sulla letteratura della Guerra civile, tema del suo futuro libro Patriotic Gore. La fama e ancor più l’apparente altero distacco lo isolavano, con la moglie e la figlia bambina, a un grande tavolo nella sala da pranzo apparecchiato per chi volesse confrontarsi con lui. Ma nessuno osava farsi avanti. Un giorno, d’impulso, presi posto sulla sedia accanto alla sua. S’interessò al mio lavoro: gli parlai di un mio recente articolo su H.L. Mencken, il «Lucifero della critica americana», che volle leggere e di cui, il giorno seguente, mi segnalò, puntualmente, alcune imprecisioni, invitandomi nel suo appartamento all’ora del tè. Conversai con Helaine, paziente e curiosa della frenetica vita al castello, che la sfiorava appena. Inventai giochi per Ellen, la solitaria bambina, tanto somigliante al padre nell’alta fronte e nello sguardo intransigente. Con Wilson ridiscussi di Mencken e m’interessai al tema delle sue lezioni: il rapporto tra guerra e romanzo. Nacque un’amicizia destinata a durare: una prima prova, per me, di come in America le emozioni di un incontro obbediscano a cadenze più rapide, come di una musica che s’imprima subito nella memoria.
Leopoldskron mi rivelò i fondamenti della pedagogia americana, antitetici rispetto ai codici delle nostre università: lo studente era soggetto, non oggetto dell’insegnamento, autorizzato a domande imprevedibili o inopportune; la lezione non poteva dirsi conclusa se non era seguita da una vivace discussione; la passione comune circolava tra gli ascoltatori come energia erotica. Le ombre di Socrate e di Platone si aggiravano per i corridoi bui, si affacciavano alle sale trasformate in aule. Nella mia futura carriera di docente, il modello di Salisburgo mi avrebbe suggerito strategie pedagogiche radicalmente diverse da quelle sperimentate nei miei anni di studio alla Statale di Milano. A Catania il mio campus si estese dalle aule barocche dell’università alle barche in secca nel piccolo porto di Santa Maria la Scala.
Prima di partire per l’America volli incontrare un maestro italiano. Non avevo mai conosciuto Pavese, ma conoscevo Vittorini, leggendario, per me, al pari dei suoi americani, quando lo vidi per caso la prima volta. Ero ferma, da ammaliata provinciale, davanti alla libreria Einaudi, nella Galleria Manzoni, ed eccolo apparire al di là della vetrina, come in un ritratto urbano di luci e riflessi: alto, elegante, un lieve sorriso nel bel volto saraceno. Fu lui a invitarmi a collaborare alla sua Enciclopedia, edita da Mondadori, con voci americane da O’Neill a Saroyan, e a darmi in lettura per la sua collana Il Tornasole autori di cui intuì precocemente la genialità, come William Gaddis. Quando gli chiesi quali romanzieri mi suggerisse di intervistare nel mio viaggio, esitò. Per lui, l’ardore della scoperta si era spento. Le opere più significative degli ultimi anni gli sembravano Il vecchio e il mare di Hemingway e Una favola di Faulkner; la letteratura americana era ferma a quei due innovatori. Tra i narratori che si erano imposti dopo il 1941, come Nelson Algren o Truman Capote, lo interessava, in quel momento, l’italoamericano John Fante – destinato, come mai avremmo immaginato, a una lunga fama postuma –, forse perché lo attraevano ora le sperimentazioni dei giovani scrittori italiani. Mi augurò di scoprire sul campo nomi e opere ancora sconosciuti in Italia. Erano passati i tempi degli amori a distanza: in terra americana si doveva cercare.
Scelsi di raggiungere gli Stati Uniti per una rotta inconsueta. Non mi sarei imbarcata a Genova su una nave italiana, ma a Cherbourg, in Normandia, sul Queen Elizabeth, e, su quel frammento galleggiante d’Inghilterra dove ogni mattina si leggeva l’Ocean Times, stampato a bordo, avrei attraversato l’Atlantico settentrionale tra tempeste e bianchi fantasmi di iceberg, per costeggiare la gelata Terranova e sbarcare a Manhattan arrivando dal Nord.
New York, New York
Non dimentico l’attimo in cui vidi per la prima volta l’isola di Manhattan sorgere dall’acqua: dapprima in costellazioni, in anelli, in nebulose scintillanti, poi in castelli, in fortilizi, in alte torri, finché si accampò, dura nell’aria: una metropoli di luci ritagliata nella notte. Ogni viaggiatore che arrivi, così, per nave, può credere che la visione emerga dall’oceano per la forza del suo sguardo: simile a un miraggio che l’occhio strappa al deserto. Perché New York è storia; ma è, anche, natura. Le foreste abbattute per concederle uno spazio avaro, verticale, esposto a tempeste di neve e raffiche d’afa premono come fantasmi che spingano i grattacieli sempre più in alto. Chi ama Manhattan ama la wilderness indiana presente nel suo nome, imbrigliata nel suo skyline frastagliato, montano, che si tinge di rosso nei tramonti. Quella stessa immaginazione che l’ha modellata deve possedere il visitatore perché la ami…
Ero arrivata alla fine del viaggio. Ero sbarcata, a sorpresa, a Hoboken, alla foce del fiume Hudson, nel New Jersey, confusa alla folla degli altri passeggeri che sparivano rapidamente coi parenti e gli amici venuti ad accoglierli. Ancora trasognata, mi guardavo intorno, quando mi accorsi di essere rimasta ultima tra i moli silenziosi come fondali di teatro dove le luci si andassero spegnendo. Nessuno dei portentosi taxi gialli newyorkesi, su cui avevo imprudentemente contato per raggiungere i miei ospiti a Brooklyn, era in vista. Sentii alle spalle la pugnalata della solitudine che Manhattan riserva ai visionari come antidoto ai suoi incantesimi: quella solitudine che, per altri viaggiatori, è la nota dominante di un’angosciosa sinfonia. In Poeta a New York, Federico García Lorca affida a un verso sconvolgente – «assassinato dal cielo» – la sua esperienza di spaesamento, di esilio, di dannazione nell’inferno della metropoli.
Per me quella notte ci fu un Virgilio: da un taxi uscito dal nulla scese Mauro Calamandrei, allora corrispondente dell’Espresso, venuto, inatteso, a salvarmi. Sarebbe stato, da quel momento, la mia guida e mi avrebbe affidato ad altre guide, esperte degli arcani della New York letteraria: primo fra tutti Dwight Macdonald, rapido, spericolato, un folletto per cui nessun incontro, nessun dialogo parevano impossibili, autore di un saggio allora molto citato, Masscult e Midcult. Il suo nome fu il mio lasciapassare per la comunità intellettuale newyorkese, inquieta, divisa, dopo i conflitti brucianti del maccartismo, da dissensi politici e rivalità personali, ma viva e consapevole del proprio ruolo cruciale in Occidente, attiva nelle riviste e nelle case editrici. Incontrai, così, altre guide: autorevoli, come Alfred Kazin, o emergenti, come il giovane Norman Podhoretz.
New York è, in apparenza, una città aritmetica, quasi pitagorica, dove streets e avenues sembrano rispondere a una celeste progressione numerica, dove i disorientati, quali io sono inguaribilmente, s’illudono di avere nella testa una bussola o un navigatore.
Ma l’ordine non cancella una sottostante fantasmagoria di nomi – Broadway, Amsterdam, Madison… – che esplodono da una storia urbana sepolta, di angoli che si mutano in curve, di piazze che, come Times Square, impongono una loro sghemba geometria. Mentre mi preparavo a incontrare i nuovi scrittori, perlustrai la città, non da turista, con metodo, ma con la sregolatezza di un’appassionata principiante. Presi a morsi la Grande Mela, là dove il caso me la offriva. M’immersi nella folla di Broadway, di Times Square, della Fifth Avenue, trascinata dall’onda violenta della vita collettiva, lungo i vasti marciapiedi, sotto un cielo di nuvole alte e veloci, tra gli odori aspri di mattoni bruciati, di fumi emergenti dal sottosuolo, di hot dog e pretzel caldi serviti al volo da bancarelle e carrettini, di brusche nevicate. Era il mese di marzo, instabile, il cielo e i fiumi balenanti di riflessi d’argento.
D’impulso, mi trovai a seguire i passi del giovane Holden di Salinger. Visitai il Museo di Storia naturale, riposandomi, dopo la frenesia delle strade, tra le grandi bacheche di vetro che racchiudono in un ordine immobile il remoto passato della terra americana. Nella Sala degli indiani riconobbi la squaw che tesse una coperta, l’esquimese che pesca, i cervi che si abbeverano alle fonti in un’inalterabile fissità… Entrai nel bar di un grande albergo, il Vanderbilt: una pianista stanca e isterica eseguiva i suoi pezzi all’ombra di finti alberi, mentre grosse margherite di stoffa fiorivano sui cappelli di matrone di mezz’età che bevevano il tè in una penombra di artificiale primavera. Volli assistere, un pomeriggio, al varietà di Radio City Music Hall, dove ballerine tutte uguali, le Rockettes, tenendosi abbracciate per la vita, eseguivano danze di precisione su un fondale scuro: l’equivalente cronometrico, in bianco e nero, delle rutilanti Folies Bergère parigine.
E mi persi infine nel South Central Park alla ricerca del lago che suggerisce a Holden Caulfield l’assillante domanda: «Dove vanno le anitre d’inverno?». Tra i cespugli e i prati ancora gialli giovani coppie, ragazze con le calze nere e ragazzi in giacche di pelle, stavano sdraiate o amorosamente avvinghiate sotto un sole intermittente… Gli anni cinquanta sembravano finire com’erano cominciati: in quel clima di vana ribellione e di ipocrita opulenza che Salinger aveva catturato nel suo romanzo. In breve mi sarei accorta che gli anni sessanta si stavano già delineando, che esisteva un’altra New York, sotterranea, clandestina, ma già visibile.
New York è un mosaico di quartieri sconfinanti l’uno nell’altro, ma separati da distanze siderali nelle abitudini e negli stili di vita.
«Uno dei viaggi più lunghi al mondo è il viaggio tra Brooklyn e Manhattan» scrive Norman Podhoretz, per cui lo spostamento coincise con il successo letterario e l’ascesa sociale. Accettando gli inviti di amici vecchi e nuovi, decisi a ogni acrobazia pur di preservarmi dallo straniamento di un soggiorno in albergo, nel giro di qualche settimana traslocai da un quartiere all’altro, attraversando ogni volta, d’un balzo, gli invisibili confini di classe, di censo, di etnia. Da Brooklyn – dove, la notte, uscendo dalla subway alla fermata di Coney Island, mi sorprendevano insieme il respiro fresco dell’oceano e i passi pesanti dei ragazzi delle gang locali – mi trasferii in un brownstone dell’Upper East Side, poi ebbi la fortuna di stabilirmi al Greenwich Village, nella West Tenth Street, quieta e alberata. Negli anni settanta avrei abitato nell’Upper West Side, al margine del Central Park, e di nuovo al Village, in Perry Street, negli ottanta ...