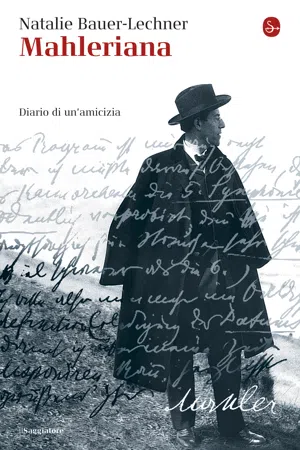La stagione 1897
Da maggio all’estate
Debutto
11 maggio 1897
Si temeva che la resistenza maggiore potesse venire dall’orchestra. Mahler aveva fama di affaticare le persone con prove minuziose e con lo studio approfondito delle opere, e si diceva che i musicisti si sarebbero ribellati e avrebbero guastato il suo debutto mostrandosi apertamente riluttanti. Invece, dopo la prima prova, si era già conquistato l’intera orchestra, oppositori compresi.
Per il debutto, gli era toccato il Lohengrin, e gli venne concessa una sola prova, durante la quale egli temeva soprattutto una cosa: il discorso che gli era stato chiesto di rivolgere ai musicisti. Benché fosse un oratore estremamente chiaro e vivace quando improvvisava, Mahler provava un autentico terrore dei discorsi ufficiali, e cercava in ogni modo di evitarli, a meno che non fosse strettamente indispensabile. Per preparare questo, vagò per giorni rompendosi la testa e imprecando, ma poi, come ammise lui stesso, tutto andò benissimo nonostante il suo imbarazzo. Con il Preludio del Lohengrin, svanì tutta la tensione. Dopo averlo provato una volta, spiegò loro che cosa avesse in mente, discusse i dettagli e ridefinì tutto, dalla A alla Z.
In seguito disse di non aver mai visto un’orchestra così capace di imparare e di assecondare le sue intenzioni musicali. «Ho ottenuto di più con loro dopo la prima prova che con altri dopo anni. Probabilmente il teatro viennese idealizzava il suono in modo incredibile, mentre altrove l’acustica pessima rende tutto più materiale e grossolano. Ma il merito principale è dei musicisti austriaci: dello slancio, del calore e della grande predisposizione naturale che ciascuno mette nel suo lavoro.»
Nonostante quest’unica prova fosse insufficiente – oltre al Preludio, egli poté solo rivedere alcune cose con il coro e fare un po’ di esercizi con i solisti –, l’esecuzione dell’intera opera fu straordinaria, come se Mahler, al pari del sacro genio creatore, fosse riuscito a entrare nel Lohengrin. Dopo il Preludio e tutte le parti in cui la differenza tra quella esecuzione e le altre era particolarmente netta, si levò uno scroscio spontaneo di applausi entusiasti.
Terminata la rappresentazione, Mahler lasciò il teatro passando per l’uscita degli artisti e trovò ad attenderlo alla porta una folla di giovani (probabilmente studenti di conservatorio o un’analoga famiglia di musicisti); lo circondarono, gli tesero la mano e lo salutarono con «Evviva», che lo rallegrarono più di qualsiasi altra cosa, comprese le recensioni unanimemente splendide che apparvero il giorno seguente. «A questi ragazzi è toccata la stessa esperienza che feci io alla loro età» disse. «Il desiderio di sentire come suonassero dal vivo le opere di cui conoscevo la partitura fu sempre amaramente frustrato, perché perlopiù emerge la minima parte di ciò che è scritto in quelle opere. Ma quando finalmente riusciamo a sentirle interamente, l’effetto supera di gran lunga l’idea che ce ne eravamo fatti, e l’entusiasmo e la gratitudine per chi ci ha condotto fin qui non ha limiti.»
Lettera anonima
(Questo scritto, privo di qualsiasi altra implicazione, è un documento autentico del debutto di Mahler, e merita quindi di essere pubblicato in questa sede.)1
12 maggio 1897
Illustrissimo!
Egregio Signor Direttore!
Queste righe le giungono da una persona che ha buoni motivi per non presentarsi, e forse addirittura non può farlo, perché la vita, la carriera eccetera spesso fanno di noi ciò che non vorremmo essere. O almeno, si è ostacolati nel parlare liberamente, e si deve dunque ricorrere a uno scritto, per giunta in forma anonima. Spero che mi vorrà scusare, dunque, perché questa lettera non ha altro scopo se non comunicarLe la gioia e l’entusiasmo che ieri la Sua direzione del Lohengrin ha procurato non solo a un vecchio musicista e wagneriano della prima ora, ma a chiunque sia un artista nel senso di Wagner. Da ventuno o ventidue anni l’autore di queste righe non sentiva più eseguire ben due terzi di quest’opera come nel Suo concerto di ieri.
I Suoi tempi, le Sue sfumature e accenti erano «wagneriani» nel vero senso della parola: così li ha interpretati il Maestro stesso, così venivano suonati all’epoca sotto la sua direzione, e putroppo, da allora, mai più.
Per cominciare, il Preludio era lento al punto giusto; il coro, dopo l’addio di Lohengrin al cigno, meravigliosamente tenero, come pure l’esecuzione del passaggio: «Seht, seht, welch seltsam Wunder» (Guardate, guardate! Che miracolo singolare!).2 Il climax della preghiera era magnifico, anche nella parte cantata, intonata nonostante l’assenza di accompagnamento, anche se ieri sera i cantanti erano un po’ esitanti; poi, nel secondo atto, il passaggio: «In ferner Einsamkeit des Waldes» (Nella lontana solitudine del bosco)3 – che viene quasi sempre tirato per le lunghe – l’entrata di Lohengrin in «Oh Himmel schirme sie vor Gefahren» (Oh Cielo proteggili dai pericoli)4 e «Euch, Helden» (Voi, eroi);5 nel terzo atto, il Preludio, la scena d’amore rifinita splendidamente e tantissimi altri particolari: da anni qui non si ascoltava niente di simile.
Il Suo modo di dirigere è davvero «wagneriano», perché sa modificare il tempo restando estremamente fedele alle intenzioni del Maestro. Nessun dettaglio va perduto, privando l’insieme di equilibrio. Per esempio, il rallentamento quasi impercettibile nel coro introduttivo del terzo atto, al momento di: «Rauschen des Festes seid nun entronnen» (Abbandonate ora i bagordi).6
Signor Direttore, da conoscitore dell’opera di Wagner, ricorderà sicuramente l’episodio che il Maestro racconta nel suo scritto Del dirigere: quando, diciotto anni dopo la morte di Weber, diresse al Teatro di Corte di Dresda Il franco cacciatore, prendendo con un tempo molto più lento dei suoi predecessori l’Adagio all’inizio dell’ouverture. «Sì, anche Weber la prendeva così; è la prima volta ora che lo sento di nuovo nel modo esatto».7
Ieri, chi le scrive si è sentito esattamente come Dotzhauer. Dai tempi di Wagner e Bülow non ho più assistito a una direzione pregevole come la Sua di ieri.
Voglia dunque accettare il più sentito ringraziamento e i migliori auguri per il suo futuro da un devotissimo
vecchio musicista
Le dimensioni dell’orchestra
Oltre alla preparazione dell’Olandese volante, Mahler si dedicò per prima cosa al Flauto magico. Durante la prima prova – in un delicato passaggio al violoncello che continuava a risultare troppo forte nonostante i suoi ripetuti inviti ad attutirlo – si accorse con stupore di essere circondato da un’orchestra adatta a un’opera di Wagner. A Vienna era sempre stato così, nonostante in quel modo si eliminasse la patina di leggerezza che aleggia sull’opera. Mahler congedò quindi metà dell’orchestra, che lo applaudì e gli gridò: «Bravo!». «Si direbbe un successo!» disse lui ridendo. «Ma non dovete credere, cari signori, che si tratti di una gentilezza nei vostri confronti. Dipende piuttosto dalla mia convinzione che un’orchestra così grande distrugga la fragranza e la magia della composizione di Mozart.»
«Il franco cacciatore»
Quella stessa sera Mahler mi invitò a una rappresentazione dei Maestri cantori con Hans Richter;8 aveva prenotato un palco. Dopo lo spettacolo mi disse: «Il primo atto, che mi è piaciuto moltissimo, l’ha diretto come un Maestro, il secondo come un maestro di scuola, il terzo come un mastro ciabattino».
«Quante opere, anche tra le più famose, vengono straziate e rovinate!» mi disse. «Dovresti sentire Il franco cacciatore diretto da me, e non lo riconosceresti più, semplicemente perché io uso dei tempi del tutto diversi – quelli giusti! –, e questo fa sì che si senta ciò che non si sente mai. Il secondo Finale, per esempio, viene sempre eseguito forte e veloce, mentre io lo prendo più lento e dolce, con risultati grandiosi: la confessione della propria colpa deve salire al cielo come un sospiro. E solo allora si innalza, con più forza, la preghiera: un contrasto meraviglioso che altrimenti si perde completamente. Weber è sempre stato così frainteso e tradito dagli esecutori, che ciò che si sente ha ben poco in comune con ciò che egli desiderava, come se il pittore di una scena agreste avesse dipinto un inseguimento selvaggio o Wotan con il suo esercito furioso, al posto di un idillio colmo di quiete e di pace.
«Se divento direttore, preparerò un nuovo allestimento del Franco cacciatore. E allora vedrai che sorpresa! Nessuno dei solisti conserverebbe la sua parte. Poiché io, per un ruolo, prendo sempre in considerazione le persone in sé, non solo le voci; se non trovassi gli interpreti giusti, preferirei ingaggiare9 un cantante esterno, piuttosto che lasciare la parte nelle mani sbagliate.»
Al riguardo, aggiunse poi: «Sotto la mia direzione verrebbe data assai poca importanza alle scene e ai costumi. Obbligherei il pubblico sviato e i suoi gusti ormai corrotti a seguirmi su altre strade. Sarebbe una fortuna, se ci si affidasse di più, o quasi interamente, alla loro fantasia e capacità di immaginazione. Mi piacerebbe prendere a modello il Teatro shakespeariano di Monaco; in tal modo arriverebbero a sentire tutto con me, cosa che finora non hanno ancora mai sperimentato».
Il furore musicale
Una sera – c’era un meraviglioso tempo primaverile – Mahler mi venne a prendere per fare una passeggiata al Prater. Andammo in vettura fino al Sophienbrücke e di lì proseguimmo poi per il «Prater selvaggio»,10 con i suoi splendidi prati, le antichissime macchie boschive e i romantici pascoli in riva al Danubio, dove a ogni passo affioravano infiniti e grati ricordi della nostra prima giovinezza.
Eravamo ancora eccitati per la rappresentazione dell’Olandese volante del giorno precedente,11 e io dissi a Mahler che mi sembrava meraviglioso come avesse trasformato i solisti, l’orchestra e il coro apponendovi il suo marchio. «È merito del furore»12 mi rispose, «senza il quale non riesco a immaginare nessun vero direttore d’orchestra, perché è il furore a guidarlo per ottenere ciò che sente riguardo a un’opera, e per riuscire a ricavarlo, a estorcerlo anche al più imbranato o incompetente organico di orchestra, coro e cantanti. Così si spiega anche la mia rabbia indescrivibile quando non eseguono come voglio io, ma suonano e cantano male o in modo scorretto.
«Nella vita, questo mi ha spesso limitato anche nei rapporti personali, perché se una cameriera che mi piaceva cantava una nota sbagliata o poco musicale, ogni mia inclinazione nei suoi confronti finiva all’istante, trasformandosi, anzi, in odio. Al contrario, naturalmente, una bella voce o altre manifestazioni di un talento musicale mi hanno spesso attratto profondamente. Mi ricordo, per esempio, quando, da ragazzino, ho sentito la Wilt13 (dalla quarta galleria non credo, infatti, di averla potuta vedere): ero fuori di me e per giorni vagai follemente innamorato di lei, perché questi slanci possono essere paragonati solo all’amore.»
Tempo disuguale
Mahler sembrò essersi procurato una recrudescenza dell’angina, da cui si era appena ripreso, cominciando troppo presto le prove della Valchiria. Al posto dell’infiammazione appena superata, si formò un ascesso, più serio e doloroso. E in queste condizioni, doveva dirigere Il flauto magico.14 Allo scopo lasciò il letto, nonostante fosse particolarmente stanco e sofferente, non riuscisse quasi a dire una parola e si sentisse così spossato che fino all’ultimo – contrariamente alle sue abitudini – esitò ad alzarsi. Lo accompagnai all’Opera in carrozza, e non appena salì sul podio, lo vidi di nuovo talmente fresco, vivace, sollevato dai dolori, che ascoltandolo io stessa mi liberai di ogni ansia e preoccupazione, e potei seguire indisturbata la straordinaria rappresentazione fino alla fine.
Rientrando a casa, gli dissi che era stata un’esecuzione meravigliosa, diversa da tutte le altre.
«Hai notato?» chiese. «Ho soltanto preso l’ouverture due volte più lenta degli altri, eppure sembra più veloce, perché si sente il movimento delle crome:
ecc.,
che di solito si perde completamente, mentre si sente:
ecc.»
La cosa più strana, però, era che di solito le rappresentazioni di Mahler duravano meno delle altre, nonostante lui eseguisse ogni cantilena e ogni passaggio melodico molto sostenuto, senza mai correre. (Con un’opera di Wagner poteva esserci anche mezz’ora di differenza!) «Dipende dal fatto che la maggior parte dei direttori non sa distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è, e dà quindi a tutto lo stesso peso, invece di sorvolare in modo più leggero su ciò che non è particolarmente significativo», mi disse Mahler.
Quella sera, non appena svanirono l’eccitazione e la gioia dell’azione, si scoprì che la gola era peggiorata e il medico individuò il principio di un secondo ascesso. La...