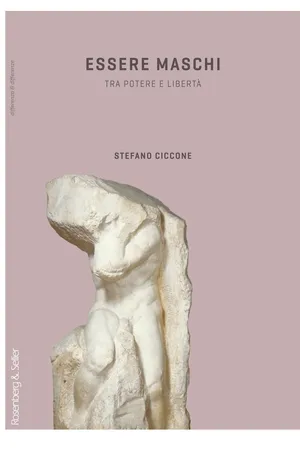
- 256 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
È possibile una parola di uomini che esprima l'esperienza maschile nella sua parzialità, la sua aspirazione a differire rispetto a modelli, forme di relazione, percezioni di sé costruiti storicamente? È possibile una critica di questo ordine oppressivo pensata ed espressa da uomini che rompa con la storia del maschile?
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Essere maschi di Stefano Ciccone in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Studi di genere. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1. Di fronte alla violenza maschile
Donne stuprate, uccise dai loro mariti, compagni, amanti; donne sottoposte a ricatti sessuali sul lavoro, o ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi; donne violentate in guerra o in operazioni militari; donne relegate con la forza in casa, oggetto di abusi, minacce e umiliazioni; donne sottoposte a mutilazioni genitali: la cronaca non riesce a rendere la pervasività della violenza maschile contro le donne, che segna la nostra quotidianità a ogni latitudine geografica, sociale e culturale. Nessuna area della nostra società è esente da questa tensione distruttiva e oppressiva. È possibile continuare a relegare la violenza maschile in cronaca nera o considerarla questione di cui si occupino le donne? È possibile limitarsi a una condanna tanto scontata quanto inefficace? In queste pagine tenterò di mostrare come la mera denuncia della violenza non solo si riveli insufficiente, ma mostri spesso un'ambigua contiguità con i modelli culturali in cui questa si genera o addirittura venga utilizzata per alimentare spinte politiche e interventi normativi che riaffermano modelli identitari regressivi e nemici della libertà femminile.
Di fronte allo stupro di una donna o a un'aggressione di gruppo ricorriamo alle categorie di aberrazione o di disumanità per esprimere la nostra partecipazione emotiva. L'indignazione che proviamo di fronte alla violenza è certo una risorsa da non accantonare; tuttavia essa può paradossalmente nascondere rischi di ambiguità e tentazioni di rimozione, proponendo una percezione di questo fenomeno come estraneo alla nostra realtà relazionale e culturale. Così, quando la cronaca scopre il velo sulla storia di una donna picchiata dal marito, il quale si sente in diritto di imporle di non avere rapporti con altre persone, di tenere gli occhi bassi al ristorante, di non avere un lavoro proprio, tutti inorridiamo all'ascolto di anni di violenze e sevizie: si tratta di una gelosia patologica, è un malato incapace di stare in una relazione. Eppure non è una storia estrema, isolata. È la storia di migliaia di donne e di uomini.
La percezione diffusa della violenza di genere è basata sull'idea che la minaccia contro le donne derivi da un aggressore sconosciuto, un maniaco, un criminale. Eppure tutte le indagini confermano che nella stragrande maggioranza dei casi l'autore è un marito, un compagno, un amico di famiglia, un datore di lavoro, un educatore: un uomo, cioè, con cui la donna che subisce violenza ha una relazione di fiducia, di affetto o di consuetudine, quando non di amore. Se la violenza contro le donne non è riducibile al gesto di devianza di maniaci o marginali, le risposte meramente repressive ed emergenziali mostrano tutti i propri limiti. Non c'è un nemico oscuro, estraneo alla nostra società, da espellere: il problema è nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle relazioni e nell'immaginario sessuale che abbiamo costruito. Non basta inasprire le pene o illuminare gli angoli bui delle nostre città per renderle più aperte alla piena cittadinanza femminile; è necessario illuminare le relazioni quotidiane in cui la violenza si genera.
La violenza contro le donne è al tempo stesso solo marginalmente rinviabile ad arretratezza culturale, a retaggio di un passato premoderno: essa riguarda tutte le zone del nostro paese, la provincia come le grandi città, tutte le classi sociali e i livelli di istruzione. La frequenza di violenza nel Sud Italia e nell'evolutissima Svezia sono assolutamente simili, nonostante questo paese veda un livello molto più alto di emancipazione e di partecipazione delle donne al lavoro e alla politica. La violenza di genere interroga direttamente la nostra “normalità” e il nostro presente.
Se andiamo oltre le nostre reazioni individuali e guardiamo alle rappresentazioni cui ricorrono le campagne di sensibilizzazione prodotte da istituzioni, associazioni di donne, scuole od organizzazioni politiche troviamo spesso l'immagine di una donna sola, ripiegata su se stessa dopo una violenza, o che attraversa una strada buia seguita da un'ombra minacciosa. Difficilmente compare l'immagine di un uomo. Lo sguardo sociale su questa violenza rischia di vederne solo le vittime e non gli autori. Questo spostamento ha due implicazioni: ripropone un'immagine di minorità femminile, confermando una disparità tra i sessi, e occulta il maschile a uno sguardo critico. Queste immagini ci suggeriscono di nuovo l'idea che la violenza sia originata da un'entità invisibile, straniera, e rendono visibili solo le donne riducendole a una condizione di vittime. Coerentemente con questa impostazione donne e bambini vengono accomunati nella categoria delle vittime potenziali da difendere. Si riaffermano così due concetti: primo, la violenza non riguarda gli uomini che abitano la nostra quotidianità; secondo, le donne sono soggetti deboli che necessitano della tutela di un uomo o di un'istituzione.
Prima le donne e i bambini
Ogni storia di violenza ha una svolta quando quella donna smette di essere e di percepirsi vittima: la donna picchiata che chiede il divorzio, la prostituta schiava che denuncia il suo sfruttatore. Eppure la legge, l'immagine televisiva, il senso comune continuano a rappresentarle come vittime: donne bisognose di tutela più che portatrici di diritti e gli autori della violenza ridotti a marginalità, devianza, patologia.
Se scegliamo di approfondire ci accorgiamo, al contrario, che il fenomeno della violenza sulle donne non ci parla di una debolezza femminile a cui fornire (paternalisticamente) tutele – protezione delle donne dalla violenza come altrove sostegno alla loro presenza nello spazio pubblico tramite quote di garanzia – quanto di un universo maschile generatore di questa ferocia. La violenza è questione che riguarda innanzitutto gli uomini: sono uomini quelli che stuprano, picchiano, umiliano, fino a volte uccidere. Uomini come noi: simili a me.
La violenza contro le donne dimostra dunque radici così profonde nella nostra cultura – dalle forme di organizzazione della nostra società al nostro immaginario, dal nostro linguaggio alle nostre rappresentazioni dei ruoli sessuali – che anche le strategie istituzionali di contrasto, le nostre reazioni indignate e le nostre domande di punizione rivelano di condividere inconsapevolmente lo stesso universo simbolico, lo stesso substrato culturale, in cui quella violenza trova le sue origini e si sviluppa e in cui si genera quell'oppressione, quella miseria delle relazioni e delle emozioni.
La contiguità tra la rappresentazione delle donne come soggetti deboli da porre sotto tutela, da proteggere dagli altri uomini, e l'arbitrio che un uomo pensa di poter esercitare come capofamiglia è un esempio di quella cultura. Il nesso tra rappresentazione della donna come soggetto minore sotto la tutela maschile e uso della violenza maschile in famiglia è esplicitato in modo lampante dal nostro diritto di famiglia riformato solo nel 1975. L'art. 144 prevedeva che il marito proteggesse e tenesse presso di sé la moglie e che questa ubbidisse al marito e lo seguisse ovunque lui decidesse di porre il domicilio. L'accomunare moglie e figli in una condizione di minorità sotto la tutela e l'autorità paterna emergeva in sentenze dove questa disposizione rimandava, anche per le donne picchiate dal marito, all'articolo del codice penale che puniva «chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità» solo in caso di lesioni gravi, lasciandolo impunito a fronte di percosse, per quanto violente. Il segno paterno del controllo maschile ha ispirato anche il comportamento del sacerdote1 che ha rivendicato, con il rigore del padre di famiglia verso i figli deboli, la scelta di segregare per il loro bene le giovani albanesi presenti nel proprio centro di accoglienza colte a frequentare connazionali poco raccomandabili.
La protezione della propria donna, sovrapponendosi a una pulsione di controllo e di riaffermazione della propria identità virile, è alla radice di altre forme di violenza: dal controllo oppressivo e possessivo dei suoi movimenti alla rissa in discoteca per uno sguardo di troppo, dove il bene in gioco non è la sicurezza della donna ma l'onore dell'uomo. Ed è sempre l'immagine di una famiglia posta sotto la tutela di un uomo, dove esso si concede alla cura femminile ed esercita il controllo e l'uso del corpo della donna, tutelandola al tempo stesso dalla minaccia di altri uomini, che ne fa luogo che resta opaco alla legge e alla società, rendendo occulte molte violenze. Quanto ha a che fare questa rappresentazione con l'idea che un uomo si senta in diritto di imporre a una donna le proprie regole tra le mura di casa e con la resistenza sociale a registrare le violenze familiari?
Anche la risposta emergenziale, basata come abbiamo visto sulla rappresentazione di una minaccia esterna, risulta per molti versi fuorviante. Ha infatti paradossalmente l'effetto di marginalizzare il fenomeno, di occultarne il carattere strutturale e pervasivo, di rappresentarlo come frutto di patologia da reprimere, rimuovendo la necessità di una riflessione maschile e alimentando al tempo stesso una cultura xenofoba e identitaria che condivide e rafforza un universo culturale patriarcale e virilista comune a quella mascolinità violenta. La minaccia è attribuita all'estraneo per antonomasia: l'immigrato, l'altro, l'uomo nero. L'allarme violenza porta il governo nazionale e le comunità locali a inseguire iniziative basate sul controllo e la repressione: videocamere nelle strade, sistemi di allarme per le donne, inasprimento delle pene. L'intervento repressivo diviene occasione per una politica incapace di affrontare la dimensione sociale e complessa dei problemi a cui supplisce esibendo soltanto la tempestività di una risposta. La ricerca di una soluzione immediata e semplificata alla ricorrente emergenza giunge all'estremo di affrontare l'allarme bullismo nelle scuole con la proposta di abbassare la punibilità a 12 anni. Queste risposte incontrano una tensione regressiva in città e periferie dove lo spazio sociale non offre relazioni collettive e strumenti di lettura della realtà che permettano di rielaborare la propria frustrazione e di rispondere alle proprie paure, o di fare esperienza dei propri limiti, di concepire una forma relazionale della propria identità e della propria libertà.
La reazione all'uccisione di Giovanna Reggiani a Roma nel 2007 è esemplificativa di questi processi. Dopo l'aggressione da parte di Nicolae Romolus Mailat, ventiquattrenne rom, e la successiva morte della donna, esplode un'emergenza nazionale sul tema della sicurezza che porta la destra a chiedere espulsioni di massa a protezione delle donne dalla minaccia rappresentata dagli stranieri. Ma se la reazione della componente più razzista e xenofoba non stupisce, colpisce la rinuncia a rappresentare un'alternativa civile da parte di quella che dovrebbe essere la componente più democratica della società politica. Il sindaco di Roma, leader in pectore della coalizione nazionale di centro-sinistra, interviene chiedendo la convocazione straordinaria del Consiglio dei Ministri per prendere misure di emergenza: prima fra tutte la possibilità di espulsione dei cittadini comunitari che compiano reati. In seguito abbiamo assistito agli sgomberi di campi nomadi. Un omicidio a opera di un singolo, che dovrebbe essere trattato con il principio della responsabilità penale individuale, viene affrontato dalla politica criminalizzando una categoria di persone peraltro eterogenea: “rom, romeni, abitanti nei campi nomadi, senza fissa dimora, clandestini”. La rincorsa dell'emergenza porta alla semplificazione che accomuna rom e romeni, confondendo le decine di migliaia di rom italiani e le migliaia di romeni non rom presenti nel nostro paese; si dimentica che è rom anche la donna che ha denunciato l'aggressione e chiamato i soccorsi; si alimenta l'illusione che un intervento repressivo possa risolvere problemi complessi e profondi; si rimuove nella percezione dell'opinione pubblica il dato reale che vede le violenze contro le donne avvenire soprattutto per opera di mariti e compagni italiani. Sulla scorta dell'emozione per il tremendo fatto di cronaca si asseconda la rappresentazione di un incremento della violenza e dei reati nelle città e la richiesta repressiva dei cittadini, nell'illusione che rincorrere i peggiori istinti dell'opinione pubblica eviti di lasciarne la rappresentanza alla destra xenofoba e ne scongiuri una peggiore degenerazione.
Eppure i dati sulla criminalità registrano una riduzione dei reati violenti e degli omicidi. Il fatto che un governo e un'amministrazione comunale possano assecondare l'allarme sociale dopo un singolo fatto di cronaca, promuovendo interventi che sovvertono le garanzie democratiche e i principi della responsabilità individuale, e possano rivendicare al tempo stesso gli esiti positivi della propria amministrazione nelle relazioni annuali che registrano una diminuzione dei reati non può essere attribuito soltanto a schizofrenia o peggio a opportunismo. Questa apparente contraddittorietà è rivelatrice del fatto che la percezione di insicurezza non è direttamente in relazione con la condizione oggettiva di incidenza dei reati, ma è influenzata dalla condizione soggettiva caratterizzata dalla solitudine, dall'estraneità ai luoghi della città, dalla povertà di strumenti per comprendere l...
Indice dei contenuti
- Essere maschi
- Frontespizio
- Copyright
- Dedica
- Introduzione
- 1. Di fronte alla violenza maschile
- 2. Il corpo maschile
- 3. Virilità e culture identitarie
- 4. Critica ai modelli di mascolinità e critica della politica
- 5. Essere l’altro
- 6. Per una relazione politica tra donne e uomini
- 7. Maschile plurale
- Bibliografia