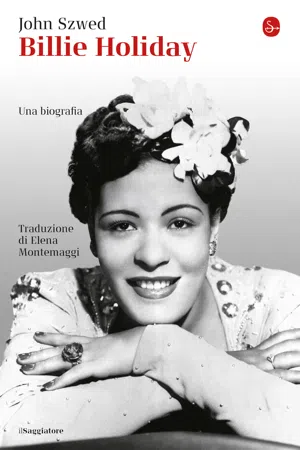![]()
PARTE SECONDA
La musicista
![]()
4. La preistoria di una cantante
Quando Billie e la madre si trasferirono da Baltimora a New York nel 1929, la borsa di Wall Street stava per crollare, il Proibizionismo stava cambiando radicalmente l’industria del divertimento e le glorie della Harlem Renaissance stavano svanendo. Come avrebbe scritto Langston Hughes: «Non andavamo più di moda, mi riferisco a noi negri. I newyorkesi sofisticati ora preferivano Noël Coward». Ma Hughes aveva ragione soltanto in parte. Gli scrittori, i pittori e i commediografi di Harlem potevano anche aver perso il loro fascino uptown, così come i suoi varietà elaborati potevano essersi ridimensionati o spostati nei teatri del midtown, ma la musica di Harlem, che non era mai stata l’elemento più forte dell’ideologia della Renaissance, trovava ora una nuova casa nei piccoli cabaret e cantine del quartiere, dove il divieto di servire alcol era meno pressante. In quei locali, si stava formando un’era del jazz contrapposta a quella dei bianchi di downtown, e un gran numero di cantanti donne che interpretavano generi diversi sembrò spuntare un po’ ovunque. Alcune erano delle artiste consolidate, come le cantanti blues, le coon shouters e le red-hot mamas, e tutte avevano un debito verso le tradizioni musicali afroamericane. Nel frattempo, nuovi stili, che affondavano sempre le loro radici nella comunità nera, continuavano a fiorire, come per esempio le flappers e le torch singers.
Il concetto di cantante di jazz non esisteva ancora quando Billie iniziò per caso la sua carriera di cantante. L’idea di un o una cantante con una propria carriera, indipendente da un’orchestra, da un teatro o da una compagnia di varietà cominciava a farsi strada allora. Tuttavia, non era ancora chiaro cosa una cantante jazz dovesse essere. Le artiste donne che oggi vengono da tutti riconosciute come le massime esponenti della canzone jazz femminile – Bessie Smith, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Betty Carter – erano molto diverse stilisticamente l’una dall’altra. Ognuna di loro aveva creato un approccio del tutto personale che non poteva essere adattato facilmente da altre cantanti senza che queste sembrassero delle imitatrici prive di immaginazione. Eppure, per forgiare il loro stile personale, avevano tutte attinto da un substrato culturale comune che apparteneva al passato.
A metà del diciannovesimo secolo l’impatto della canzone nera sull’America non era ancora stato percepito a pieno. Per molti bianchi americani al di fuori del Sud degli Usa l’unico canto nero che potesse essere giunto al loro orecchio proveniva da una chiesa in lontananza. Ma i pochi che avevano avuto occasione di ascoltare qualcosa di più erano convinti di aver sentito il futuro: la caratteristica predominante di un peculiare stile canoro americano che ancora doveva prendere forma. Già nel 1845 un giornalista di nome J.K. Kinnard dichiarava che il mondo non aveva ancora ascoltato i migliori poeti d’America, i poeti e i cantanti popolari neri, scarsamente conosciuti anche nel loro paese. Gli abolizionisti ritenevano che gli spirituals fossero la musica più singolare e potente che avessero mai sentito. Negli anni cinquanta dell’Ottocento Walt Whitman individuò nel linguaggio dei neri degli «accenni alla futura teoria della modificazione delle parole della lingua inglese, per scopi musicali, per un’opera lirica autoctona americana, in cui le parole mantengono il loro significato originario nello scritto e nel parlato, ma possono cambiarlo per aderire perfettamente a esigenze musicali…».
Dopo che la ferrovia e la radio avevano collegato buona parte del paese e la musica aveva iniziato a essere registrata, soltanto le persone più isolate non sapevano che stava emergendo un nuovo modo di cantare, malgrado la segregazione portasse a ignorarne facilmente le origini. Ma negli anni sessanta del Novecento c’era chi, come il critico musicale Henry Pleasants, dichiarava che la fonte dello stile della canzone americana era principalmente nera. Pleasants suggeriva, in maniera ancor più radicale, che quando in America cominciò a decadere la tradizione della musica classica europea, i cantanti afroamericani emersero come voci vitali del futuro reinventando «gli obiettivi, i criteri e tecniche dei primi grandi cantanti lirici italiani» trattando la canzone «come un’estensione lirica del parlato»: «Enfatizzano la dizione definita e il fraseggio conversazionale – e per ottenere questo effetto utilizzano le stesse tecniche dei loro illustri predecessori, incluse l’appoggiatura, il gruppetto, il legato e il rubato».
Pleasants evidenziò altri due fattori che contribuirono all’ascesa dei cantanti afroamericani. Primo, avevano la libertà di interpretare ciò che era stato negato alle loro controparti classiche, sempre più assoggettate al compositore e all’orchestra. E secondo, potevano usare il microfono per ripristinare il fascino, l’intimità e i virtuosismi che la canzone lirica aveva perso quando l’enfasi si era spostata dal retorico al lirico.
«Reinventare» era la parola che Pleasants aveva usato per descrivere questo passaggio di estetica musicale, anche se forse «creolizzazione» sarebbe stato il termine più indicato, poiché avrebbe richiamato l’attenzione sui modi in cui culture storicamente estranee l’una all’altra possono talvolta fondersi per dare forma a qualcosa di totalmente nuovo, senza preoccuparsi delle origini o delle rispettabili eredità del passato.
Gli afroamericani aprirono la strada alla rottura con la tradizione musicale europea, e, per quanto possa sembrare strano, questa rottura era stata anticipata, e forse anche incoraggiata, dallo spettacolo di menestrelli o minstrel show, la prima forma di teatro musicale diffusasi nell’intero paese. La sua storia negli Stati Uniti non è circoscritta a un periodo di ottant’anni circa, come si è sempre creduto; il suo retaggio è molto più complesso di un semplice popolo bianco che copia il popolo nero, tanto che ancora oggi le domande sulle fonti di questa musica e sulla sua influenza non trovano risposta. Alcuni minstrels erano neri, e alcuni di quelli che noi oggi consideriamo artisti bianchi erano allora categorizzati, in un modo o nell’altro, come non-bianchi. Tra gli artisti bianchi che si tingevano la faccia di nero, blackface, ve ne erano alcuni, come Al Jolson o Libby Holman, che erano molto popolari tra le persone di colore. Con il tempo la minstrelsy, l’arte dei menestrelli, ha varcato i confini americani per assumere significati diversi in ogni paese in cui è approdata. In Sudafrica, da più di un secolo ogni anno a gennaio, in occasione del Coon Carnival, tra i non-bianchi africani di Cape Town si tengono spettacoli di menestrelli in blackface. Eva Braun, l’amante di Adolf Hitler, posò con il volto truccato di nero per degli scatti professionali imitando il suo artista preferito, Al Jolson, il quale era di origini ebree. Billie Holiday, come tante altre artiste nere di quel tempo, almeno una volta fu costretta a scurirsi la pelle, per non sembrare troppo chiara rispetto ai musicisti neri che l’accompagnavano e potersi così esibire davanti a un pubblico bianco.
La musica e i balli dei minstrel shows non copiavano i neri più di tanto, poiché erano costruzioni di personaggi immaginari in ambientazioni immaginarie anteguerra a opera di compositori e coreografi bianchi che mettevano insieme vari ingredienti culturali. Se avessero creduto che quello che stavano presentando fossero simulazioni di gente reale, avrebbero fallito. Erano probabilmente consapevoli che si trattava di pastiches, o parodie, in particolare perché molte delle melodie dei menestrelli, e parte dell’umorismo, trovavano malcelate origini in quei teatri tenda e palchi del passato che avevano «ministrellizzato» gli irlandesi. Uno scenografo di New York, a fine Ottocento, rimarcò, dopo aver assistito a un minstrel show, che provava compassione per gli artisti neri perché dovevano competere con l’originale!
Il blackface continua ancor oggi ad affascinare e resta la materia di studio preferita dei teorici accademici, che con cadenza più o meno regolare trovano sempre nuove spiegazioni. Ma qualunque sia la sua storia e per quanto possa essere complessa e sgradevole, la minstrelsy ci dice che alla canzone americana mancava disperatamente qualcosa: la voce della gente nera che era stata esclusa. Le derivazioni della minstrelsy diedero corpo a stili e temi che in qualche modo sopravvivono ancor oggi. Nel 1961 il grande cantante R&B Jackie Wilson incise un album-tributo ad Al Jolson dal titolo You Aint’ Heard Nothin’ Yet. Il padre di Aretha Franklin, lo stimato reverendo R.L. Franklin, disse che i suoi cantanti preferiti erano Muddy Waters e Al Jolson, e la stessa Aretha incise alcune delle canzoni di Al Jolson e di Stephen Foster. Sin dai tempi d’oro della minstrelsy, la musica popolare ha continuato a essere una forma di maschera culturale, un passaggio misterioso, un ricettacolo di esotismo, un’arena per qualsiasi forma vernacolare e, in particolare, per l’eloquio musicale, un campo da gioco per chi si diverte a superare i limiti, a cambiare forma e a correre dei rischi.
* * *
Verso la fine dell’Ottocento i grandi e spettacolari minstrel shows cominciavano a sparire per essere rimpiazzati dai vaudeville o spettacoli di varietà, che vedevano una serie di artisti diversi – cantanti, giocolieri, ballerine, comici – esibirsi individualmente, abbandonando l’usanza tradizionale dei menestrelli in cui tutti i membri della compagnia comparivano sul palco allo stesso tempo. Tuttavia, esibizioni che richiamavano alla minstrelsy persistevano in nuove forme musicali chiamate «coon songs». Nel 1920 il catalogo della Victor Records spiegava in cosa consistesse la musica elencata sotto la voce «Coon Songs and Specialties»:
Per «coon songs» si intendono canzoni attuali in dialetto Negro. Buona parte di queste canzoni non presentano uno spirito raffinato, per questa ragione le abbiamo tenute distinte dalle vecchie darkey songs, catalogate alle voci «Fisk Jubilee Quartet», «Negro Songs» e «Tuskegee».
Le coon songs avevano lo scopo di caratterizzare i neri americani in modo che potessero divertire i bianchi. Era un divertimento particolarmente insidioso in cui l’umorismo spesso sembrava alimentare paure mai immaginate nei minstrel shows. L’ansia bianca nei confronti della liberazione degli schiavi e della minaccia della Ricostruzione erano audacemente messe in mostra. Le fantasie dei menestrelli sulla vita nelle vecchie piantagioni furono rimpiazzate da quelle di un popolo libero in competizione con i bianchi, nel lavoro e nello stato sociale. Canzoni con titoli come If the Man in the Moon Was a Coon e New Coon in Town ne erano un tipico esempio.
Pertanto, sul palco si venne a determinare un guazzabuglio di cocomeri, abiti pacchiani, rasoi a serramanico, giocatori d’azzardo, bari, ladri di polli, buffoni, arrampicatori sociali falliti, bulli e personaggi promiscui e libidinosi. Dal 1880 al 1920 le coon songs furono la moda del momento, come il ragtime e il blues che ancora dovevano arrivare, e si produssero centinaia di canzoni pop per soddisfare le richieste di mercato. «Canzoni pop» perché diedero origine a Tin Pan Alley, le fabbriche della canzone in serie nate per mantenere una produzione musicale stabile da vendere al pubblico. Le coon songs erano sciocche, offensive e crudeli, e talvolta bastava mettere la parola coon al posto di un’altra su una vecchia canzone per avere subito pronti degli spartiti in più da vendere. Ciò nondimeno, autori di maggior successo si specializzarono in questo genere di canzoni, e alcuni continuarono a scrivere con lo stesso spirito anche anni dopo: nel 1930, per esempio, Irving Berlin in Puttin’ On the Ritz prese in giro i pretenziosi neri della Lenox Avenue di Harlem. La canzone fu registrata da Fred Astaire nel 1930 e in seguito fu «sbiancata» con nuove parole per permettere ad Astaire di cantare della Quinta Avenue nel film Blue Skies del 1946. La versione originale sopravvive su YouTube in uno stralcio sfocato del film Puttin’ on the Ritz del 1930, con Harry Richmond che canta davanti a ballerini bianchi, i quali poi cedono il palco a un rumoroso ed esuberante gruppo di ballo in blackface composto da neri «veri». Questo tipo di revisione e di scaltra appropriazione delle coon songs perdurò nel ventesimo secolo in canzoni pop come Hard-Hearted Hannah, I Ain’t Got Nobody, Big Bad Bill (Is Sweet Liam Now), e Bad, Bad Leroy Brown.
Alcune coon songs erano simili a quelle che nei minstrel shows erano cantate da uomini che recitavano sia ruoli maschili sia femminili. Ora venivano interpretate da donne bianche, spesso in blackface, e perciò acquisivano un peso emotivo differente. Le cantanti di maggiore successo delle prime coon songs, come ad esempio May Irwin, erano in genere donne bianche corpulente e prosperose che vestivano abiti decorosi. Sul palco assumevano il ruolo di black mammies che rimproveravano aspramente i loro mariti, oppure recitavano il ruolo di uomini intenzionati a battersi con il tipo più duro della città. Nel 1895, il New York Times riportava che:
Quando [Irvin] cantava le sue nuove darkey songs […] ci si dimenticava dei suoi capelli biondi, della sua carnagione color panna e pesca, e dei suoi occhi azzurri; ogni intonazione della sua voce, ogni espressione del suo viso, ogni suo gesto e movimento, creavano insieme l’illusione di essere di fronte ora a una darkey disperata della Virginia, ora a una pericolosa «coon» del Tennessee.
In una recensione sull’esibizione della Irwin in Courted into Court a New York City nel 1896, il Times diceva:
Il Negro del Sud da lei impersonato in Crappy Dan e in The New Bully non è il vecchio darkey della piantagione, felice della sua schiavitù e primitivo nella sua semplicità, ma è il prodotto della nuova civilizzazione, il d...