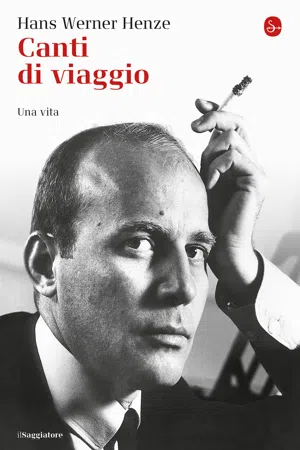![]()
I
Canti di viaggio
1926-1995
![]()
Capitolo 1
Tu credi, vecchio violino
che fai danzare le stelle,
con la forza delle tue corde,
che la nostra vita terrena,
una volta che sia finita
diverrà nuovamente musica,
ma più alta, sulla quinta?
NIKOLAUS LENAU, Der Steirertanz
Nell’ottobre del 1986, dopo più di cinquant’anni, sono ritornato nella mia città natale, Gütersloh, in Vestfalia. Ho pensato che avrei riconosciuto qualcosa – case, ruscelli e nuvole – benché me ne fossi andato quando avevo solo quattro anni. La casa dove sono nato in Brunnenstraße, costruita nel 1901 in una sorta di Jugendstil rustico, è davvero graziosa (l’ho riconosciuta dalle fotografie). Là, dopo più di mezzo secolo, sono stato invitato a prendere il tè dagli attuali abitanti, che mi hanno raccontato vari particolari sulla storia della casa. Per esempio, ho saputo che dopo la Seconda guerra mondiale era stata utilizzata come circolo dei sottufficiali dal vittorioso esercito britannico e che da allora era fornita di una stanza da bagno. Qui, al piano superiore, c’era l’appartamento in cui, nel 1926, si erano trasferiti i miei genitori – Franz e Margarete Adele Henze nata Geldmacher, entrambi di religione evangelica – perché io vi potessi vedere la luce del mondo.
Nell’autunno soleggiato del 1986, rimasi un’intera settimana a Gütersloh e venni festeggiato, in occasione del mio sessantesimo compleanno, con dovizia di concerti, conferenze e rappresentazioni d’opera. Ero commosso e anche piuttosto orgoglioso – nonché riconoscente, perché davvero non c’era nessuna anima insistente decisa a monopolizzarmi oltre misura. Mi avevano semplicemente lasciato in pace. Ero giunto a Gütersloh in treno con Michael Vyner – il direttore, nel frattempo defunto, della London Sinfonietta, in memoria del quale ho scritto un Requiem nel 1990-1992 – e, non appena arrivati, ci eravamo subito concessi un giro esplorativo della graziosa cittadina. Non passò molto che ci imbattemmo in un’enorme stele di pietra, con una menorah d’oro e un’iscrizione scolpita in tedesco. Michael, ebreo, mi chiese, leggermente turbato, di tradurgliela:
Alla memoria della comunità ebraica di Gütersloh
e della sua sinagoga, che non lontano da questo luogo
il 9 novembre 1938 venne distrutta dai cittadini.
A monito per noi tutti.
Dunque anche qui, nella mia città natale, c’erano stati assassini e folli! Interrompemmo il sopralluogo e andai a nascondermi, ferito e pieno di vergogna, nella mia camera d’albergo.
Tre anni dopo, sono ritornato a Gütersloh, dove sono rimasto un intero mese per dirigere un’accademia estiva, un workshop per giovani cantanti e strumentisti inglesi e per registi delle nuove generazioni provenienti da vari paesi. Venne anche rappresentata la mia opera comica The English Cat. La città mi mise a disposizione un appartamento con un pianoforte a coda, così fui libero di lavorare quotidianamente anche alle due scene conclusive di Das verratene Meer.
Ho voluto fissare nella musica la luce di questa Vestfalia orientale, che è di una malinconia silenziosa: non c’è mai un chiarore abbagliante come da me in Lazio. È tutta un’altra luce, che produce un’altra musica – naturalmente un altro pensiero. A volte, mentre mi recavo alle prove nel Teatro di Gütersloh, mi imbattevo in persone che andavano in chiesa, avvolte in impermeabili grigi, con questi cappelli austeri, questi ombrelli, tutte con un’espressione in volto come se dovessero andare dall’esattore delle tasse. Andavano a sentire la parola di Dio, il che, per i protestanti – secondo le mie decisamente imperfette conoscenze – ha comunque a che fare con la penitenza: le prediche evangeliche sono in qualche modo, quasi sempre, ammonimenti e reprimende. Mi veniva in mente che solo pochi giovani peccatori avrebbero voluto ascoltarle. Molto spesso le campane suonavano invano. Quelle della Martin-Luther Kirche, nella quale ero stato battezzato, azionate elettronicamente, erano in do minore, proprio come la musica conclusiva di Das verratene Meer, quando Noboru e i suoi compagni di scuola si accingono a giustiziare il marinaio Ryuji Tsukazaki, patrigno del giovane protagonista, da loro condannato a morte.
La distesa, l’assenza di interruzioni nella pianura e la mancanza di valli, alture e gole hanno sempre suscitato in me, ogni volta che trascorro un certo periodo in una zona come quella intorno a Münster, una forte – ma non sgradevole – impressione. O l’eternità si interrompe dove si vedono gli ultimi pioppi, o inizia proprio lì: l’infinita semplicità continua e continua nel modo più bello e discreto. Non lontano da Gütersloh, si innalza, in modo appena riconoscibile, la Selva di Teutoburgo, che è una sorta di duna; più in là, al centro di una specie di conca, si trovano località come Bünde, Detmold, Herford e Salzuflen – dove nel 1976 morì mia madre – che fu teatro di una spaventosa battaglia, nella quale, come narrano Tacito e Kleist, i germani sconfissero i romani nel 9 d.C. Per questo motivo, qui si trova anche il capolavoro dello scultore patriottico Ernst von Bandel, un monumento ad Arminio, meta molto popolare di gite scolastiche.
Pare che ancora oggi sia possibile arrampicarsi all’interno e scrutare in lontananza, da un’altezza vertiginosa, attraverso le narici dell’eroe, i campi di patate e di grano della conca di Ravensberg, un paesaggio – che ricorda la Marca brandeburghese – per lo più sabbioso, ricoperto di cespugli di erica e di ginepro e di alberi di pino, ma anche di campi di rape. Heine ha descritto con lievi tratti di penna gli uomini che vivono qui, o provengono da queste parti, in Deutschland, ein Wintermärchen (Germania, una fiaba d’inverno):
[…]
Ich dachte der lieben Brüder,
Der lieben Westfalen, womit ich so oft
In Göttingen getrunken,
Bis wir gerührt einander ans Herz
Und unter die Tische gesunken!
Sie fechten gut, sie trinken gut,
Und wenn sie die Hand dir reichen
Zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie;
sind sentimentale Eichen.
Noi siamo, in verità, un popolo flemmatico, incline alla malinconia e al pessimismo, mentalmente pigro e al tempo stesso bonario. In Vestfalia è diffuso anche il basso tedesco, che ha forti assonanze con l’olandese e che non avevamo il permesso di parlare, da bambini, benché cresciuti su questa terra. Un altro divieto consisteva nell’ingiunzione, da parte dei nostri genitori, di evitare i compagni di classe le cui madri fabbricavano sigari in casa a cottimo: secondo loro, avevano tutti la tubercolosi. Inutile dire che non potevamo nemmeno, in nessun caso, mettere piede in quelle catapecchie di piccoli contadini che profumavano di foglie di tabacco e nelle quali vivevano famiglie povere ma piene di figli. Perciò, a me e ai miei fratelli, in quanto a tradizioni locali, non rimaneva molto di più delle calze di lana e degli zoccoli di legno, chiamati anche “barchette di Mülheim”. Un paio durava per molti anni e veniva lasciato fuori dalla porta, prima di entrare in casa, un po’ come si usa in Giappone; indossavamo solo calze di lana nei locali domestici, i cui pavimenti, tirati a specchio da mia madre, invitavano a scivolare e a rompersi la testa.
In quel primo periodo dell’infanzia, quando avevo quattro o cinque anni, il mio aspetto era piuttosto deprimente: il quadro desolante cominciava dalle gambe – i piedi rivolti verso l’interno inciampavano spesso e volentieri l’uno nell’altro, la gamba sinistra era ed è otto millimetri più corta della destra, fonte, in seguito, di complicazioni di ogni tipo, anche con i sottufficiali che interpretavano come cattiva volontà il fatto che io non volessi stare dritto – e finiva in alto, sotto una specie di frangetta (che sarebbe piaciuta ai punk di oggi), con gli occhi strabici, che per anni cercarono di correggere utilizzando una benda nera. L’insieme non era reso più attraente dal fatto che, a causa di un’infelice caduta dalla credenza della cucina, mi ero prodotto una ferita tra il labbro superiore e il naso, la cui cicatrice è tuttora ben visibile. I miei occhi erano più verdi di quanto non lo siano oggi, ma già allora le pupille potevano contrarsi occasionalmente in due linee verticali di biasimo. Si deve anche dire che ero e sono una persona incline all’iracondia, che non può sopportare di non fare di testa sua. Da bambino, in simili casi, gridavo a lungo «lasciatemi solo!» sdraiato sul pavimento e picchiando a terra i pugni, finché mio padre stendeva dolcemente una coperta su di me. La piacevole oscurità doveva farmi bene, giacché venivo lasciato in pace e mi calmavo. E così, alla fine, l’avevo avuta vinta! Le punizioni corporali erano proibite; al loro posto vigevano il divieto di uscire e di leggere e la negazione dell’amore, vale a dire che i nostri genitori non ci parlavano per ore. Sembrava che durasse un’eternità: non si sapeva mai se sarebbe stato per sempre o solo per breve tempo. I motivi profondi della tensione verso la perfezione artistica, che mi ha accompagnato nel corso di tutta la vita, sono forse da ricercare in questi antichi difetti fisici, incidenti e malattie. Un impulso istintivo cerca di compensar il contrasto tra la riuscita nel lavoro e il fallimento nella vita: un po’ quello che è successo a uomini che hanno lavorato duramente come Michelangelo, Pontormo, Caravaggio e che sono riusciti, nel modo più alto, a farsi perdonare i peccati commessi su questa terra.
I miei amorevoli genitori, come tutti gli amorevoli genitori di allora, cercarono di costringere il loro primogenito mancino all’uso della destra. Poiché non volevano far vedere alla gente che i loro rampolli appartenevano al diavolo, causavano gravi danni fisici e psicologici agli sfortunati figli, confondendo loro le idee e rendendo loro impossibile il libero uso delle membra e delle capacità intellettuali. La Vestfalia un tempo apparteneva alla Prussia, dopo essere stata per breve tempo un regno, sotto Girolamo Bonaparte. È per questo, probabilmente, che abbiamo interiorizzato così tanto la “prussianità”, cioè la disciplina, il militarismo e il senso del dovere. Per lo stesso motivo, forse, mio padre mi scrisse, nel penultimo anno di guerra – quando ero ancora in caserma e mi lamentavo ripetutamente, nelle lettere, delle insopportabili miserie della vita militare – che il pagliericcio sarebbe ben presto diventato il mio migliore amico e che di lì a poco non avrei potuto immaginarmi nulla di più bello che combattere e morire per la patria e per la vittoria finale. Ci scrivevamo verso la metà del 1944, quando già si sentivano i cannoni tuonare sui fronti d’invasione, ogni notte altre città venivano bombardate, “cancellate”, come diceva Hitler, e migliaia di civili uccisi.
All’inizio, però, nella mia serena prima infanzia, tutto mi sembrava relativamente in ordine. I miei genitori erano giovani e sentivo che si amavano, il che si rifletteva positivamente su di me. Erano intelligenti, entrambi di origini modeste, ma pieni di aspettative. Mio padre proveniva dalla zona di Hannover. Nostra nonna, sua madre, Helene Henze nata Meinecke, era di Berlino. Poiché era stata una volta a Weimar, dove una sua amica aveva preso lezioni di pianoforte da Franz Liszt, si era da allora sempre vestita di seta come le signore raffinate. Suo marito Karl era stato impiegato delle ferrovie di Hannover e poi di quelle prussiane, ma io non l’ho mai conosciuto. La nonna mi dava un biscotto o due quando portavo per lei, all’ufficio postale, le molte lettere che scriveva quotidianamente. La sua capigliatura grigio argento era divisa a metà e raccolta in uno chignon con la nobile semplicità di una diaconessa. Leggeva molto la Bibbia, era completamente priva di senso musicale, ma ciò nonostante cantava a voce spiegata con grande fervore le sue note stridule e sbagliate nel coro della chiesa – mi pare ancora di sentirla. Emanava un gradevole profumo di lavanda. Infastidiva noi bambini con i suoi continui ammonimenti e rimproveri, che le avevano guadagnato il soprannome di “nonna pericolosa”.
Uno dei suoi molti figli, Franz, mio padre, era diventato maestro di scuola elementare, come quasi tutti i suoi fratelli. A Gütersloh ebbe il suo primo impiego. Nato nel 1898, era stato, durante la Prima guerra mondiale, a Verdun, dove rimase anche ferito – credo alla testa. Era alto un metro e settanta, magro, aveva capelli radi pettinati all’indietro, portava gli occhiali, amava gli animali e teneva, malgrado le proteste e il rincrescimento della nostra signora mamma, giganteschi alani, levrieri (dei quali è rimasta testimonianza in alcune foto) e tortore dal collare, che prendevano il volo dalla sua mano, sul dorso della quale – o sulla sua testa – ritornavano, da lontano, dopo avere descritto cerchi nell’aria. A Gütersloh e nei dintorni era più conosciuto come “Henze il musicista” che come zoologo: suonava infatti la fisarmonica durante le celebrazioni dei matrimoni, per esempio quello dei genitori del filosofo Jens Brockmeier, che sarebbe poi diventato mio amico, e in altre allegre occasioni, quando veniva chiamato per far ballare la gente. C’è anche una foto in cui si riconosce Franz Henze in mezzo a una squadra di giocatori di calcio di Gütersloh, tra cui Brockmeier padre, tutti in pantaloni corti, camicia con simbolo della squadra e scarpe da football. Non c’è da meravigliarsi se in un’altra istantanea indossano la camicia bruna dei nazisti.
Mia madre aveva lavorato fino al matrimonio come stenodattilografa presso la casa editrice Bertelsmann, che esisteva già allora anche se non era ancora così importante. È nata a Witten, nella Ruhr, nel 1907. Foto degli anni intorno al 1928, e anche successive, la mostrano come giovane signora con o senza la carrozzina dalle alte ruote, vestita alla moda della fine degli anni venti, incluso, naturalmente, il taglio di capelli alla maschietta, i tacchi alti e il cappello alla Pola Negri. Suo padre, nostro nonno, le aveva dato una volta uno schiaffo (così ci raccontava), perché, da adolescente, era arrivata a casa con un’ombra di belletto sulle guance. «Grete, rimani quello che sei!» le aveva detto (che cosa mai avrà voluto dire?). E così, Grete è stata ubbidiente per tutta la vita davvero e non si è mai truccata. Noi bambini provavamo una grande tenerezza nei suoi confronti, ci infondeva entusiasmo. Ci sforzavamo sempre, addirittura con ansia, di evitare tutto ciò che avrebbe potuto rattristare una creatura così dolce e sensibile.
Spesso ci raccontava del difficile inverno di guerra del 1917, durante il quale i bambini tedeschi soffrivano la fame e lei era stata accolta come ospite in una famiglia olandese di Scheveningen per recuperare la salute. Aveva ricordi estremamente piacevoli della gentilezza e del calore di cui era stata oggetto.
Da lei imparammo che gli olandesi sono persone molto speciali, la bontà personificata; anch’io, in seguito, ne ebbi ampia conferma. Frau Grete sapeva recitare versi strampalati e raccontare storie surreali, senza contare che mi aiutava amorevolmente e pazientemente a fare i compiti di matematica. Aveva anche guidato la mia mano nel mettere su carta, con penna e inchiostro, le prime sillabe in tedesco.
Ho fatto in tempo a conoscere personalmente suo padre, che si chiamava Karl Geldmacher, era minatore e veniva dalla Ruhr. Si trasferiva da una miniera all’altra, come allora usava, ammassando su un carro mobili, suppellettili e la famiglia, che di anno in anno cresceva in numero di figlie. A quei tempi ognuno cercava di vendere la propria forza lavoro al miglior prezzo possibile e alle condizioni più convenienti. Io lo trovavo imponente e mi metteva soggezione, con il suo sguardo selvaggiamente minaccioso che non conosceva sorriso e la lunga barba grigia ingiallita dal tabacco agli angoli della bocca. E infatti, quando penso a quest’uomo, mi sembra ancora di avere nel naso proprio l’odore di tabacco della sua lunga pipa – il cui fornello di porcellana, che arrivava fino al pavimento, noi nipoti, di tanto in tanto, inginocchiati davanti a lui, avevamo il permesso di riempire e accendere. Le donne, mia nonna materna e le sue figlie, vivevano in preda al timore, sotto il dominio di questo patriarca. In sua presenza osavano solo bisbigliare e anche quando, in sua assenza, alzavano la voce, era per lo più in toni lagnosi simili a lamentazioni: si sono talmente impressi nella mia memoria, con tutta la loro disperazione, che è possibile riaffiorino qua e là, come reminiscenze sonore, nelle mie partiture. «Kommt ihr Töchter, helft mir klagen» (Venite figlie, aiutatemi a piangere). Una foto in mio possesso mostra il nonno Geldmacher, di domenica, con il bastone da passeggio al braccio e la barba di cui non si vede la fine: porta in mano un mazzolino di erica e ha il nastrino di un qualche ordine all’occhiello. Nel 1871 aveva combattuto contro la Francia e aveva quindi partecipato attivamente all’affermazione dell’Impero – evento dal quale il genere umano non si è ancora oggi ripreso.
Lo zio Hugo, marito della zia Else, una delle tante sorelle di nostra madre, aveva la tubercolosi e amava Čajkovskij. Il che, in qualche modo, era coerente. Un quadro a olio incorniciato di nero, appeso nel nostro soggiorno sopra il pianoforte nero, mostrava una fanciulla con i capelli corti che suonava un pianoforte nero, mentre molta gente ascoltava assorta. Un uomo secco con le guance incavate si appoggiava a capo chino allo stipite della porta, con le mani in tasca: per me quello era il tisico zio Hugo.
Lasc...