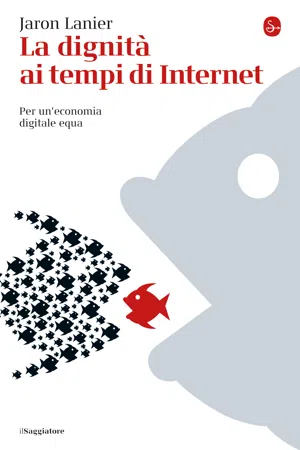![]()
OTTAVA PARTE
Le immagini dello scandalo (ovvero: aspetti pratici di una possibile alternativa umanistica)
![]()
19. Il progetto
Questo non lo puoi twittare!
Del problema abbiamo parlato abbastanza. È ora di proporre una soluzione.
Elevator pitch, «presentazione da ascensore», è un’espressione assai comune nella Silicon Valley, anche se da quelle parti pochi edifici sono sufficientemente alti da richiedere un ascensore. Si deve spiegare molto velocemente l’idea che sta dietro una startup, prima che l’interlocutore sia distratto dall’arrivo di un tweet sullo smartphone.
Non sarei credibile se cercassi di presentare il mio progetto per una nuova economia digitale in uno spazio tanto ridotto. Devo fornire un buon numero di dettagli, così da rendere il tutto abbastanza succoso da attrarre critiche e ragionamenti costruttivi. E però se provassi a entrare in ogni singolo dettaglio la mia presentazione sarebbe ridicola.
Penso che il giusto livello di approfondimento sia quella che chiamerò «presentazione da ascensore spaziale». Un ascensore spaziale è un’ipotetica tecnologia in grado di aiutarci a raggiungere lo spazio. Un cavo molto resistente agganciato a un satellite da un estremo e fissato a terra dall’altro, che consente di salire. Al momento non sappiamo come costruire un cavo abbastanza resistente, e questo è solo il primo dei tanti problemi. Ma in linea di principio l’idea un giorno potrebbe funzionare.
Anche la mia proposta è così: non fingerò neanche per un momento di conoscere tutti i problemi che potrebbe implicare, né tantomeno che siano risolti. Eppure potrebbe funzionare, e i suoi benefici per le persone sarebbero enormi, ugualmente a un sistema poco costoso per raggiungere lo spazio.
Un approccio meno ambizioso da scoraggiare
Posso già immaginare gli ingranaggi che girano nella testa degli analisti politici.
«L’idea di Lanier è ambiziosa. Politicamente la transizione sarebbe difficile. Ma ha ragione sul fatto che il valore sia sempre meno contabilizzato, concentrando la ricchezza in poche mani e contraendo un’economia sempre più legata all’informazione. Forse però esiste una soluzione più semplice al problema che pone. Non potremmo trattare lo spazio informazionale come una risorsa pubblica e tassare le imprese che beneficiano del suo utilizzo?»
Ci sono in vigore regole per tassare le aziende che sfruttano le onde radio pubbliche. Forse si potrebbe estendere il modello ai flussi d’informazione in generale. La giustificazione sarebbe che tutti i cittadini contribuiscono allo spazio informazionale, lo vogliano o meno. Nell’era digitale tutti sono tracciati e misurati. Allora perché i governi non dovrebbero esigere una compensazione da chi sfrutta quel contributo, usando il ricavato per finanziare lo stato sociale?
Se così fosse, per lanciare uno schema finanziario occulto, o per agitare l’esca della rete «gratuita» davanti agli utenti sperando di abbindolarli con la chimera della visibilità, servirebbero soldi veri. Una «tassa sullo spionaggio dati» generalizzata avrebbe il vantaggio di diminuire i casi di imprenditoria truffaldina e aumentare in proporzione i finanziamenti a nuove imprese genuinamente produttive. Inoltre, anche se con l’automazione si perdono sempre più posti di lavoro, la spesa sociale potrebbe dilatarsi grazie a nuove entrate, compensando il calo occupazionale.
Nell’attuale clima politico e culturale statunitense, quelle che ho appena riportato sarebbero bollate come «parole incendiarie». La maggior parte degli americani avrebbe timore che una politica del genere si traducesse in una crescita incontrollata della burocrazia statale, e dunque in una restrizione delle libertà individuali e in un rallentamento dell’innovazione. L’argomentazione contraria a queste misure suonerebbe più o meno così: poiché i processi sono sempre più mediati dal software, una tassa sullo spionaggio dati non creerebbe una burocrazia di dimensioni stabili, come quella che si occupa delle onde radio. Ogni giorno ci sarebbero nuovi tipi di dati e nuovi introiti da riscuotere, fino alla creazione di un’enorme agenzia di pianificazione centrale in grado di incassare denaro da ogni attività, per poi restituirlo con il contagocce ai cittadini. Sarebbe un buco nero di corruzione. Una burocrazia colossale che riassumerebbe in forma ancora più monolitica tutti gli aspetti negativi dei Server Sirena.
È altrettanto importante considerare una delle ragioni della sinistra. Se si deve pagare per sfruttare l’informazione in generale, allora esperimenti come Wikipedia non potrebbero sbocciare, perché prima dovrebbero dimostrare di meritare una licenza d’accesso in deroga. La concessione di tali licenze in numero limitato diventerebbe una sorta di guinzaglio politico alla libertà di espressione. Anche se ho criticato Wikipedia, detesterei qualunque sistema tentasse di limitare simili esperimenti.
Andare «fino in fondo» e trattare l’informazione come qualcosa di prezioso sin dal momento in cui viene generata dagli individui è l’unico modo per aggirare questi deprimenti e fallimentari modelli burocratici.
Naturalmente i sistemi informatici possono creare problemi, ma possono anche aprire nuove opportunità. L’esistenza di connessioni di rete avanzate offre le condizioni per retribuire direttamente le persone per il valore che immettono nello spazio informazionale, invece di avere un gigantesco mastodonte burocratico a fare da mediatore, praticando una versione approssimata, distorta e rozza dell’equità.
La strada che propongo non può essere presa alla leggera, perché siamo già avviati lungo tutt’altra direzione. Bisognerebbe affrontare una dura transizione. E anche al suo meglio la mia idea avrebbe comunque i suoi punti deboli.
Eppure, nonostante il titanico «attrito» della transizione e l’inevitabile imperfezione del risultato finale, penso che il percorso da me proposto sia l’alternativa migliore.
Un’economia dell’informazione sostenibile
A una prima annusata, un approccio umanistico alle future economie digitali potrebbe puzzare di redistribuzionismo, ma non è niente del genere. Alcuni contribuirebbero e guadagnerebbero più degli altri. Il punto non è creare una falsa dinamica competitiva in cui a tutti è garantita la vittoria, ma piuttosto misurare onestamente chi contribuisce ai successi per scoraggiare l’adozione di incentivi errati.
Le ragioni più forti per sostenere un approccio umanistico alle economie hi-tech non poggiano minimamente sul concetto progressista di equità, ma piuttosto su un equilibrio migliore tra rischi e risultati da premiare.
Ho già descritto il principale vantaggio economico di lungo termine, cioè un’economia che si espande di pari passo con gli aumenti di efficienza digitale. Attribuire valore a tutte le informazioni nelle reti (invece di attribuirlo perlopiù all’informazione presente nei principali nodi delle reti) creerà un’economia capace di continuare a crescere via via che le attività diventano più mediate dal software.
Al momento, dato che non stiamo contabilizzando il valore della maggior parte dell’informazione in Rete, può sembrare che l’efficienza tecnologica restringa il mercato anziché farlo espandere, pur se nel frattempo qualcuno accumula nuove e immense fortune. Una cosa veramente stupida.
Un’economia umanistica dell’informazione apporta ulteriori benefici agli affari, tra cui:
- una gamma più ampia di modelli di business a lungo termine;
- una gestione dei diritti di proprietà intellettuale più incrementale e leggera, anziché conflittuale o basata sulle eccezioni;
- responsabilità e obblighi più prevedibili in relazione alla privacy e ad altre politiche sulle configurazioni digitali potenzialmente fastidiose;
- infine, come ho già spiegato, un modello economico che può sopravvivere a un futuro in cui i bit estendono progressivamente la loro influenza sul mondo fisico.
Per di più, questi benefici favorirebbero sia gli individui sia le grandi corporation, dando vita a un interesse comune fra grandi e piccoli attori.
Una spiaggia migliore
In un’economia umanistica la sciocca storiella in spiaggia con cui ho aperto il libro si svolgerebbe in maniera ben diversa.
È un giorno di sole e stai facendo un castello di sabbia. «Si può costruire un ponte stabile sopra il fossato?» chiedi al gabbiano. «No, le informazioni a mia disposizione dicono che in passato nessuno è riuscito a costruire un ponte su un fossato così largo» è la replica. «I ponti di sabbia di tali dimensioni crollano sotto il loro stesso peso. Ma ovviamente potremmo aggiungere dei granelli robotici alla sabbia.»
«No» rispondi al gabbiano «non voglio barare.» E poi non te la senti di spendere soldi in nanorobot solo per giocare con la sabbia.
Costruisci con cura una collina di sabbia e cominci a scavare uno spazio al suo interno. Assomiglia vagamente a una versione in miniatura del gigantesco arco naturale di Kashgar. «Gabbiano, imposta una copia simulata di quest’arco.» Grazie ai tuoi occhiali per la realtà mista provi a sperimentare diverse simulazioni. Ed ecco la soluzione!
Chiami i tuoi amici per fargliela vedere. Sono tutti entusiasti.
«Gabbiano, presto! Postala prima che crolli.» Un momento dopo, il gabbiano ti informa: «Il tuo arco è stato replicato 58 volte nel mondo. Guarda questa versione gigante realizzata su una spiaggia di Rio». Attraverso gli occhiali per la realtà mista, tu e i tuoi amici vi ritrovate a far baldoria sulla spiaggia a Rio.
Wow, è stata una giornata fruttuosa. «Gabbiano, il casinò qui vicino ha un eccellente ristorante, vero? Non badiamo a spese!» Chiami i tuoi amici: «Ehi, qualcuno ha fame?».
—————
Per inciso, sto lavorando a un’alternativa migliore di un ascensore spaziale: una gigantesca catapulta ultraleggera per lanciare le astronavi nello spazio.
![]()
20. Inventarsi qualcosa di meglio degli argini ad hoc
Per gradi
Le tipiche aspirazioni della classe media hanno il problema che la ricerca di sicurezza tende ad avere caratteristiche «o tutto o niente». La tradizionale scalata verso la dignità della classe media è disseminata di grandi ostacoli. Hai conquistato il lavoro dei tuoi sogni o la promozione tanto agognata, oppure no. Sei riuscito a farti concedere un mutuo, hai acquistato una licenza di taxi, sei entrato nel sindacato, hai chiuso l’affare del secolo, oppure no. Non ci sono vie di mezzo. Chi non è riuscito a superare queste soglie può ancora sperare di farcela, ma con rischi maggiori e minor tranquillità.
Ciò che per qualcuno è il conseguimento della dignità economica (grazie a un argine), a un altro potrà sembrare una barriera artificiale che impedisce di ottenere lo stesso risultato. È una maniera un po’ assurda di gestire la società, e chi non desidera altro che una famiglia stabile o un piano per trascorrere serenamente la vecchiaia può sembrare il cattivo della situazione. Per esempio, spesso nei confronti dei sindacalisti sono state scagliate parole al vetriolo.
La tensione è stata esacerbata dall’arrivo di Internet, che ha reso i giovani ancora più impazienti. «Chi si crede di essere questa musicista per dirmi che non posso usare gratuitamente la sua musica nei miei video, solo perché ha il copyright?»
Il progetto che qui descrivo mira a sfruttare al massimo le potenzialità delle tecnologie di rete, per creare un percorso meno accidentato verso una sicurezza economica diffusa per la classe media.
Una tale sicurezza non sarebbe raggiunta a grossi blocchi, ma un mattoncino per volta, procedendo per gradi. Non sarebbe garantita a tutti, ma risulterebbe accessibile alla maggioranza delle persone che la desiderano. La sicurezza economica non sarebbe amministrata dai burocrati, ma emergerebbe dalle dinamiche di mercato.
Un percorso incrementale verso la sicurezza sociale non risolverebbe tutte le questioni filosofiche su concetti come il diritto d’autore, ma certamente le renderebbe meno controverse. In un mondo in cui le persone inizieranno a incassare royalty per le decine di migliaia di microcontributi forniti durante la propria vita attiva su Internet, i rari casi di conflittualità nell’attribuzione della paternità delle opere sarebbero molto meno rilevanti.
La creazione di una proprietà intellettuale più diffusa e generalizzata avverrà per consuetudine, su piccola scala. In un primo periodo di transizione questa forma di accumulazione incrementale della dignità economica potrebbe sostituire i sistemi più tradizionali, come il copyright, i sindacati e le carriere universitarie, per poi infine soppiantarli. O forse i due sistemi potrebbero coesistere per un tempo indefinito. Non sono in grado di scendere in tutti i dettagli in questo primo abbozzo di proposta.
In linea teorica, guadagnare ricchezza – in senso esteso e non solo in termini di soldi – diventerebbe sempre più simile al modo in cui già oggi si spende. La ricchezza di ciascuno verrebbe generata in una moltitudine di circostanze invece che per singoli balzi in avanti nello status economico.
In un mondo più gradualista, i compensi e l’attribuzione delle opere sarebbero ancora oggetto di conflitti e discussioni, non c’è dubbio, ma le risoluzioni delle dispute non sarebbero più una questione di vita o di morte. Le conseguenze subite perdendo una causa per la paternità di un’opera sarebbero analoghe a quelle del lasciarsi scappare un ottimo sconto. Ci saranno tante altre occasioni per rimediare.
Un altro problema dell’attuale sistema di argini è che spesso sono a somma zero. Se tutti possono ottenere una licenza per taxi, le licenze perdono ogni valore, e uno speculatore potrebbe facilmente accumularle per monopolizzare il mercato, mettendo in crisi la ragione stessa della loro esistenza. Quello che dovremmo cercare di costruire è invece un sistema in cui il valore delle cose cresce man mano che le persone vi partecipano.
Dunque il progetto potrebbe essere così riassunto: proviamo a immaginare come le reti informatiche possano aiutare a dar vita a un modello di creazione della ricchezza fluido e graduale, che prosperi insieme alla classe media e non sia a somma zero.
Sugli alberi non crescon...