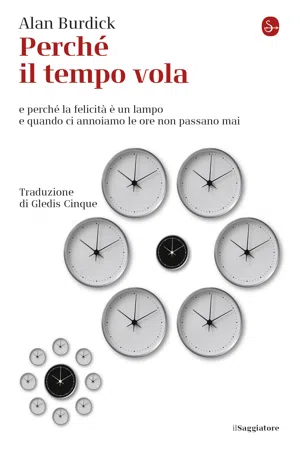Il presente
Nell’intossicazione da hashish avviene un curioso incremento dell’apparente prospettiva temporale. Pronunciamo una frase, e prima di raggiungere la fine l’inizio sembra già risalire ad un indefinito tempo precedente. Imbocchiamo una strada breve, e sembra che non ne raggiungeremo mai la fine.
William James, Principi di psicologia
Quanto dura adesso?
Mentre scrivo, sono seduto nella carrozza bar di un treno, di ritorno verso casa dopo aver visitato un amico in un’altra città. Occupo l’ultimo tavolo dell’estremità anteriore della carrozza e sono seduto con la mia schiena verso la locomotiva, guardando quindi verso la coda del treno. L’intera carrozza si apre davanti a me come un palcoscenico: a un tavolo vicino due universitari bevono caffè e discutono sui loro libri di testo; a un altro tavolo il controllore chiacchiera con la cameriera, che è in pausa; all’altra estremità diversi passeggeri sono raggruppati intorno al portatile di un uomo a guardare i tesi minuti finali di una partita di football. I miei occhi si spostano verso il lungo sfilare di finestrini della carrozza; mentre viaggiamo, nel tramonto sempre più buio, riesco ancora a distinguere le silhouette delle case e dei rari lampioni. Appaiono d’improvviso nell’angolo del finestrino alla mia destra, sfrecciano lungo la carrozza, poi scompaiono dalla mia vista e dalla mia mente, seguiti da altri lampioni e altre silhouette, in un fluire continuo, sempre più buio. Mi diverte il pensiero che ogni luce o casa che passa inizi a esistere solo da adesso, da qualche punto dietro la spalla destra. Sembra che scaturiscano da me mentre sfreccio nel futuro all’indietro, osservandolo attraverso il presente e nel ricordo.
Mentre sono a letto a casa, durante le ore buie che precedono l’alba, vivo l’esperienza opposta. La sveglia ticchetta e uno dopo l’altro i suoni dei secondi prendono forma davanti a me nell’oscurità, come pietre miliari su una strada di notte. Si avvicinano, mi attraversano, poi scompaiono da qualche parte dietro al mio cuscino, lasciandomi a pensare da dove siano arrivati e come ognuno lasci spazio al successivo. «Se fosse possibile scegliere un’ora di veglia in tutta la notte, sarebbe questa» ha scritto Nathaniel Hawthorne. «Abbiamo trovato uno spazio intermedio, in cui il momento fuggevole si trattiene e diventa realmente il presente.» Non posso dire dove porta la strada, ma a quest’ora, e solo a quest’ora, sembra che io abbia tutto il tempo del mondo per pensarci.
Per più di duemila anni le menti più brillanti del pianeta hanno discusso sulla vera essenza del tempo. È finito o infinito? È continuo o discreto? Scorre come un fiume o è granuloso, procedendo poco per volta come la sabbia in una clessidra? E nell’immediato, cos’è il presente? Ora è un istante indivisibile, una linea di puro vapore tra il passato e il futuro? O è un istante che può essere misurato – e se così fosse, quanto durerebbe? E cosa c’è tra i vari istanti? In che modo uno cede il passo al successivo: in che modo ora diventa il prossimo o più tardi o semplicemente non ora? «Invece, questa stessa natura dell’istante è qualcosa di stupefacente che si trova in mezzo tra il movimento e la quiete, perché non è in nessun tempo» osservava Platone nel iv secolo a.C..
Un secolo prima di Platone, Zenone di Elea ha condensato queste domande in alcuni impressionanti paradossi. Considerate una freccia in volo. In ogni istante lungo il suo tragitto, la freccia si trova in un qualche punto fisso; più tardi si trova in un altro punto fisso. Come – quando, in che arco di tempo – si muove da un punto a quello successivo? Per Zenone, un istante di tempo è irriducibilmente breve. La freccia non si può muovere in un tale istante; se potesse – se coprisse una qualche distanzia infinitesimale – allora l’istante dovrebbe avere una qualche durata, un inizio e una fine. E se l’istante ha una durata, allora è divisibile: in metà istante la freccia si muoverebbe per metà distanza, e così via fino all’indivisibilità. Peccato per il piè veloce Achille, sempre impossibilitato dal raggiungere il suo traguardo.
Aristotele, uno studente di Platone, era ossessionato dal paradosso. «Il primo paradosso intende dimostrare l’inesistenza del movimento» ha scritto riassumendo la logica di Zenone «per il fatto che un oggetto spostato deve giungere alla metà prima che al termine finale».
Se il movimento è impossibile, anche il tempo è impossibile; non può volare, perché non lascia mai il terreno.
Aristotele ha cercato di risolvere questo dilemma con la pura semantica, argomentando che tempo e movimento sono sinonimi. Il tempo non è un palco nel quale gli eventi vanno in scena; il movimento – l’arco del Sole, il volo della freccia – è il tempo. Ha anche argomentato che un istante ha una qualche durata reale misurabile nella quale ha luogo il movimento: «Il tempo non risulta composto da istanti indivisibili, e così neppure ogni altra grandezza». Ma così ha aperto un vaso di Pandora: ora fa qualcosa di più che semplicemente dividere il passato dal futuro? È sempre lo stesso ora, o cambia? E se cambia, quando avviene questo cambiamento? Sicuramento non ora, notava Aristotele, perché «non può esser trapassato in se stesso, per il fatto che esso in tal caso esisterebbe ancora». Tali preoccupazioni infinitesimali portano a paludi esistenziali. Se non riusciamo a spiegare come il tempo avanza da un momento all’altro, come possiamo giustificare il cambiamento, la novità, la creazione? Come può un qualcosa emergere dal nulla? Come può una qualsiasi cosa – la Creazione, il tempo stesso – avere inizio? La natura stessa dell’io viene messa in discussione: in che modo sono lo stesso individuo che ero un attimo fa, la settimana scorsa, o l’anno scorso, o da bambino? In che modo cambio ma rimango sempre me stesso? In una commedia greca precedente a Zenone, un uomo si avvicina a un altro per riprendersi dei soldi che gli deve. Il debitore dice, in effetti: «Ma tu non hai preso in prestito denaro da me! Non sono la stessa persona che ero allora, non più di quanto un ammasso di sassi al quale abbiamo aggiunto o rimosso dei sassolini sia lo stesso ammasso di sassi». Detto ciò, il primo uomo colpisce il secondo in faccia. «Perché l’hai fatto?» chiede il secondo uomo; «Chi, io?» risponde il primo.
Se c’è una cosa che piace agli esperti del tempo tanto quanto il tempo stesso è il modo in cui parliamo. Il tempo è codificato nel linguaggio che usiamo, come tempo verbale: passato, presente, futuro e le loro varie sottocategorie. Li impariamo fin da subito, in modo istintivo: a due anni, i bambini padroneggiano quasi del tutto l’uso corretto del tempo passato, anche se potrebbero non distinguere sempre «domani» da «ieri» e «prima» da «dopo». Il pirahã, la lingua parlata dalla popolazione brasiliana pirahã (e da una manciata di studiosi di linguistica), presenta pochissimi riferimenti temporali. I filosofi moderni, dal canto loro, si dividono tra tensers e detensers: quelli che sostengono che «passato» e «futuro» sono qualità reali contro quelli che non lo pensano.
Per Agostino era ancora più semplice. Prima o poi, quasi tutti gli scienziati che scrivono di biologia e della percezione del tempo citano Agostino, perché Agostino è stato veramente il primo a parlare del tempo come una esperienza interna – a chiedersi che cosa è il tempo analizzando come ci si sente a viverlo. Il tempo può sembrare sfuggente e astratto in modo esasperante, ma è anche profondamente personale. Agostino ha sostenuto che il tempo si trova in ogni nostra azione, in ogni nostra parola; dobbiamo solo smettere di ascoltare noi stessi parlare per cogliere l’urgenza del messaggio. Infatti, l’essenza del tempo, tutta la sua struttura e i suoi paradossi, può essere capita con un singolo verso, come:
Deus, creator omnium.
Dio, il creatore di tutte le cose. Ditelo ad alta voce, o ascoltatelo dentro di voi: in latino, otto sillabe, in alternanza brevi e lunghe. «Ciascuna di quest’ultime dura un tempo doppio rispetto a ciascuna delle prime» scrisse Agostino. «Le pronunzio, le ripronunzio, ed è proprio così come è chiaramente percepito dal senso.» Tuttavia, com’è possibile questa misurazione? Il verso è una serie di sillabe che la mente incontra in successione, una per una. Come può riuscire l’ascoltatore a considerare due sillabe in una volta sola per confrontare la loro durata? «Come potrò tener ferma la breve e come, misurandola, la confronterò con la lunga per arguire che questa è due volte tanto, dal momento che la sillaba lunga non incomincia ad aver suono se non quando la breve non ne ha più?» Del resto, come è possibile tenere la sillaba lunga in mente? La sua durata non può essere definita finché non è completata – ma allora entrambe le sillabe se ne saranno andate. «Entrambe diedero il loro suono, volarono via, passarono, non sono più» scrisse Agostino «Che cosa misuro allora?»
Riassumendo, cos’è il presente e dove ci troviamo noi rispetto a esso? Non il presente nel senso di questo secolo, di quest’anno, o persino oggi, ma il presente che è qui e ora davanti a noi, sempre in dissolvenza. Se siete mai rimasti svegli a letto di notte con la mente al lavoro, o avete ascoltato da vicino un ruscello gorgogliante, o semplicemente avete provato a catalogare i vostri pensieri mentre entravano e uscivano dalla vostra coscienza – quel rigagnolo che William James chiama «flusso di coscienza» – sapete di che cosa parlava Agostino. Partendo da Aristotele, Agostino sosteneva che il presente è tutto. Il futuro e il passato non esistono: l’aurora di domani «non c’è ancora»; la sua infanzia non esiste più. Rimane quindi il presente, una durata effimera, senza estensione che «perché sia tempo, deve tramontare nel passato». Tuttavia possiamo chiaramente misurare il tempo. Possiamo affermare che il suono di una sillaba dura il doppio rispetto a quello dell’altra; possiamo stabilire la durata del discorso di una persona. Quando misuriamo questo tempo? Sicuramente non nel passato o nel futuro; non possiamo misurare ciò che non esiste. «Lo misuriamo appunto quando passa» – quindi, nel presente. Ma come è possibile? Come si può misurare la durata di qualcosa – un suono o un silenzio – prima che si concluda?
Da questo paradosso Agostino è giunto a un’intuizione talmente importante da essere considerata un dato di fatto nella moderna scienza della percezione del tempo: il tempo è una proprietà della mente. Quando vi chiedete se un’effimera sillaba dura più o meno di un’altra, non state misurando le sillabe di per sé (che non esistono più), ma qualcosa «rimasto stampato» nella vostra memoria, indicò Agostino. Le sillabe sono passate ma hanno lasciato una traccia che persiste, che è ancora presente. Infatti, scrive, quelli che chiamiamo tre tempi sono uno solo. Passato, presente e futuro non esistono di per sé; sono tutti presenti nella mente – nella nostra attuale memoria di eventi passati, nella nostra attuale attenzione al presente e nella nostra attuale aspettativa di quello che verrà. «Tre sono i tempi: il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro.»
Agostino ha strappato il tempo dal contesto della fisica e l’ha messo esattamente in quella che ora noi chiamiamo psicologia. Scrisse: «In te, o anima mia, misuro il tempo». La nostra esperienza del tempo non è un’ombra in una caverna che nasconde una qualche verità assoluta; il tempo è la nostra percezione. Le parole, i suoni, gli eventi vanno e vengono, ma il loro passaggio lascia una traccia nella mente; il tempo è lì e da nessun’altra parte: «O questo è il tempo, o io non misuro il tempo». Oggigiorno gli scienziati studiano questo concetto tramite modelli informatici, topi, studenti volontari e macchinari per la risonanza magnetica da milioni di dollari. Agostino ha iniziato da dove iniziamo tutti, da un atto di parola e dalla volontà di ascoltare.
«Agostino non sta cercando di proporre una filosofia o una teologia del tempo» mi racconta il mio amico Tom un giorno a pranzo. «Sta cercando di rappresentare una questione psicologica: cosa si prova a essere nel tempo?»
Tom è uno dei miei vicini; i nostri figli hanno più o meno la stessa età e a volte giocano insieme cercando ognuno di imporsi sull’altro. Di giorno Tom è un teologo di una grande università; di notte suona il basso in band assordanti e tiene un blog sulla musica, la cultura popolare e la spiritualità. Non sono sicuro di sapere cosa sia la spiritualità, ma Tom riesce a farla sembrare sia intellettualmente stimolante sia alla moda. Siamo in un ristorante della nostra piccola cittadina e il locale è vuoto. È il venerdì prima del Memorial Day e il clima è perfetto, la primavera nella sua pienezza.
Tom spiega Agostino come parte della sua lezione introduttiva di teologia e i suoi studenti, dice, si identificano con la prospettiva personale del vescovo di Ippona. «Veniamo allenati a vedere il tempo come un qualcosa al di fuori di noi stessi – il tempo è quello che ticchetta, quello che vedi lampeggiare» dice Tom. «Ma è nelle nostre teste, nelle nostre anime, nel nostro spirito – nel nostro presente.» Il tempo non viene semplicemente osservato; è abitato, vissuto. O forse è lui che abita in noi; a un certo punto Agostino paragona il tempo al volume – noi siamo il suo contenitore. Quindi il tempo non è qualcosa di cui discutere in astratto; al contrario, guardatevi dentro, ascoltate quello che dite, sillaba per sillaba, parola per parola. Arrivate a conoscere il contenitore attraverso ciò che contiene.
È un sofisticato modello di argomentazione, quello che più tardi alcuni filosofi come Heidegger chiameranno fenomenologia: lo studio dell’esperienza cosciente dal punto di vista soggettivo. «Possiamo dire questo riguardo a noi stessi perché questo è come lo viviamo» dice Tom. È una tecnica retorica che ha un obiettivo: «Ha lo scopo di stimolarti e di cambiare la tua percezione, il modo in cui stai nel mondo.» Oggigiorno le persone seguono seminari nel weekend alla ricerca di nuovi modi di organizzare, vivere e relazionarsi al tempo. Agostino diceva: «Seguite le parole stesse».
Il piano di Agostino è di attuare un cambiamento psicologico nel lettore, di indurvi a trasformare voi stessi e la vostra anima, cosa che potete fare solamente agendo appieno nel presente. «Puoi solo sentire la bellezza nel particolare, nell’effimero, nel temporaneo, in relazione a quello che andrà via» dice Tom. «La domanda è: “In che modo trasformi quel sentire in un esercizio spirituale? In che modo puoi fare le cose giuste in tempo?”.» Siamo abituati a pensare al tempo come a una somma da spendere o a uno strumento da...