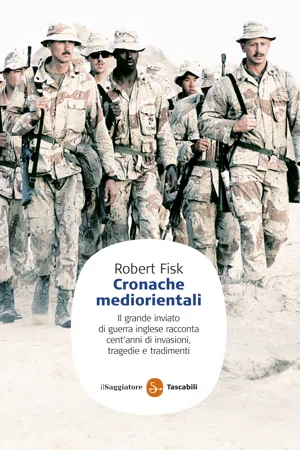1
«Uno dei nostri fratelli ha fatto un sogno...»
Combinano un folle amore per la patria con un’altrettanto folle indifferenza nei confronti della vita, la loro e quella degli altri. Sono astuti, senza scrupoli, ispirati.
Stephen Fisher in Il prigioniero di Amsterdam di
ALFRED HITCHCOCK (1940)
Sapevo che sarebbe andata così. Il 19 marzo 1997, davanti allo Spinghar Hotel di Jalalabad, con i prati ben curati e i cespugli di rose rosa, un afghano che imbracciava un kalašnikov mi invitò a fare un giro in macchina fuori città. Quella sera l’autostrada che porta a Kabul non era più una strada ma un ammasso di pietre e crepacci sulle tumultuose acque di un grande fiume. Una vasta catena montuosa incombeva su di noi. L’afghano ogni tanto mi sorrideva, ma non parlava. Sapevo che cosa voleva dire quel sorriso. Fidati di me. Però io non mi fidavo. Gli restituivo un rigido sorriso di falsa amicizia. Finché non avessi visto qualcuno di più familiare – un arabo piuttosto che un afghano – avrei tenuto gli occhi sulla strada per vedere se c’erano trappole, posti di blocco, uomini armati che erano lì senza uno scopo manifesto. Perfino dall’interno della macchina sentivo il fiume che scorreva attraverso le gole e le grandi secche di pietra grigia e straripava nei dirupi. Fidati-di-me aggirava con cura i massi disseminati sulla strada; ero ammirato dalla grazia con cui il suo piede sinistro, scalzo, alzava e abbassava la frizione come un cavaliere che incita il suo destriero ad arrampicarsi sulle rocce.
Una benevola polvere bianca copriva il parabrezza, e quando i tergicristalli la spazzavano via, il deserto assumeva un’uniformità aspra, spenta e implacabile. Quel paesaggio, pensai tra me e me, non doveva essere stato molto differente quando il maggiore generale William Elphinstone aveva guidato l’esercito britannico verso la catastrofe quasi 150 anni prima. Gli afghani avevano annientato uno dei più grandi eserciti dell’impero britannico proprio su quel tratto di strada, e lassù nei villaggi di montagna gli anziani ricordavano ancora le storie dei loro bisnonni che avevano visto gli inglesi morire a migliaia. Le pietre di Gandamak, raccontano, erano nere del sangue degli inglesi. L’anno 1842 segnò una delle più grandi sconfitte dell’esercito britannico. Non è un caso se abbiamo preferito dimenticare la Prima guerra afghana. Ma gli afghani non dimenticano. Farangiano urlò l’autista indicando con un ghigno in basso verso la gola. Stranieri. Angrezi (Inglesi). Jang (Guerra). Sì, ricevuto. Irlanda replicai in arabo. Ana min Irlanda (Io sono irlandese). Anche se lui aveva capito, avevo detto una bugia. Certo, avevo studiato in Irlanda, ma in tasca avevo un piccolo passaporto britannico nero in cui il ministro degli Affari esteri e del Commonwealth di Sua Maestà chiedeva a nome del sovrano che mi venisse permesso di «circolare liberamente e senza subire intralci» in questo mio pericoloso viaggio. Due giorni prima, all’aeroporto di Jalalabad, quel passaporto era stato controllato da un talebano adolescente, un soldato bambino di forse quattordici anni, che dopo averlo esaminato tenendolo capovolto, aveva schioccato la lingua e scosso la testa in segno di disapprovazione.
Si era fatto buio e continuavamo a salire, superando camion e file di cammelli che nell’oscurità volgevano la testa verso i nostri fari. Mentre gli sfrecciavamo accanto, il loro fiato condensato aleggiava sulla strada. I loro grandi zoccoli aggiravano le pietre con infinita attenzione e i loro occhi, illuminati dai fari, sembravano occhi di bambola. Due ore dopo, ci fermammo su un pendio sassoso, e di lì a pochi minuti vidi una camionetta scendere sobbalzando dal fianco argilloso della montagna.
Un arabo in abiti afghani venne verso la macchina. Lo riconobbi immediatamente, l’ultima volta ci eravamo incontrati in un villaggio in rovina. «Mi dispiace, signor Robert, ma devo farle la prima perquisizione» disse frugando nella mia borsa tra la macchina fotografica e i giornali. Poi ci avviammo su per la pista che Osama bin Laden aveva fatto costruire durante la sua jihad contro l’esercito russo all’inizio degli anni ottanta, in una terrificante, sdrucciolosa odissea di due ore in cui costeggiammo orribili burroni sotto la pioggia e il nevischio, con il parabrezza che si appannava sempre più man mano che ci arrampicavamo sulla gelida montagna. «Quando credi nella Jihad è facile» disse l’uomo lottando con il volante mentre le pietre schizzavano via da sotto le ruote e rimbalzavano lungo la scarpata verso le nuvole in basso. Di tanto in tanto, una luce lontana ci strizzava l’occhio nell’oscurità. «I nostri fratelli ci stanno facendo capire che ci hanno visti» disse lui.
Dopo un’ora, due arabi armati – uno con il volto coperto dalla kefiyah, gli occhi che ci scrutavano attraverso gli occhiali, un lanciarazzi anticarro sulla spalla destra – uscirono gridando da dietro le rocce. «Alt! Alt!» L’autista frenò bruscamente, io quasi battei la testa contro il parabrezza. «Scusate, scusate» disse l’uomo con gli occhiali, posando a terra il lanciarazzi. Estrasse un metal detector da una delle tasche della sua giacca da combattimento per perquisirmi una seconda volta, e la luce rossa cominciò a lampeggiare sul mio corpo. Man mano che proseguivamo, la strada peggiorava, la jeep continuava a scivolare all’indietro verso lo strapiombo, i fari proiettavano giochi di luce dall’altra parte del burrone. «La Toyota è una buona macchina per la jihad» disse il mio autista. Non potevo che essere d’accordo, pur sapendo che nella sua pubblicità la casa automobilistica non l’avrebbe menzionato tra le caratteristiche tecniche.
Era spuntata la luna e adesso si vedevano le nuvole, sia quelle nel burrone sotto di noi sia quelle che avvolgevano le cime delle montagne più in alto, mentre i fari illuminavano cascate congelate e pozzanghere coperte di ghiaccio. Osama bin Laden sapeva come costruire le strade durante la guerra; chissà quanti camion carichi di munizioni e quanti carri armati si erano arrampicati quassù durante la titanica lotta contro i russi. Adesso l’uomo che aveva guidato quei guerriglieri – il primo arabo ad aver tenuto testa a Mosca – era tornato tra le montagne che conosceva così bene. Ci furono altri posti di controllo, altre grida di «alt». Un uomo molto alto in uniforme da combattimento e occhiali da sole mi palpò delicatamente spalle, busto e gambe e mi guardò in faccia. Salaam aleikum, dissi io. La pace sia con te. Tutti gli arabi che avevo incontrato avevano sempre risposto Aleikun salama a quel saluto. Ma lui no. C’era qualcosa di gelido in quell’uomo. Ero stato invitato da Osama bin Laden ad andare a trovarlo in Afghanistan, ma quel guerriero non mi dimostrava la minima cortesia. Era una macchina che controllava un’altra macchina.
Non era sempre stato così. In effetti, la prima volta che avevo incontrato bin Laden, le cose non avrebbero potuto essere più facili. Nel dicembre del 1993 stavo seguendo un summit islamico a Khartoum, la capitale del Sudan, quando un giornalista saudita mio amico, Jamal Kashoggi, mi si avvicinò nell’atrio dell’albergo. Kashoggi, un uomo alto e leggermente corpulento vestito con una lunga dishdash bianca, mi guidò fuori dell’albergo tenendomi per una spalla. «C’è una persona che penso dovresti conoscere» disse. Kashoggi è un sincero credente – guai a chi prenda i suoi occhialini rotondi e il suo scanzonato senso dell’umorismo per segni di lassismo morale – e indovinai subito a chi si stava riferendo. Lui aveva incontrato bin Laden durante la sua guerra contro l’Armata Rossa. «Non ha mai parlato con un giornalista occidentale» mi annunciò. «Sarà interessante.» Stava tentando un piccolo esperimento di psicologia applicata. Voleva vedere come avrebbe reagito bin Laden davanti a un infedele. Anch’io.
La storia di bin Laden è istruttiva quanto epica. Quando nel 1979 l’esercito sovietico aveva invaso l’Afghanistan, la famiglia reale saudita – incoraggiata dalla CIA – aveva pensato di offrire agli afghani una legione araba, preferibilmente guidata da un principe saudita, che avrebbe condotto un esercito di guerriglieri contro i russi. In questo modo, non solo avrebbe smentito l’opinione diffusa e fin troppo esatta che la leadership saudita era corrotta e senza nerbo, ma avrebbe potuto ristabilire l’onorata tradizione dei guerrieri arabi del Golfo, pronti a perdere la vita pur di difendere la umma, la comunità dei fedeli islamici. Come era prevedibile, i principi sauditi declinarono l’invito a compiere la nobile missione. Bin Laden, infuriato sia per la loro codardia sia per l’umiliazione inflitta dai sovietici ai musulmani afghani, prese il loro posto e, con il denaro e i macchinari della sua impresa edile, diede il via alla sua personale jihad.
Era un uomo d’affari miliardario, anche lui saudita, sebbene di più umili origini yemenite, e negli anni successivi sarebbe stato oggetto di adorazione sia da parte dei sauditi sia da milioni di altri arabi, diventando la leggenda di tutte le scolaresche arabe dal Golfo al Mediterraneo. Da quando gli inglesi avevano glorificato Lawrence d’Arabia nessun altro avventuriero era mai stato ritratto in modo così eroico né aveva esercitato tanta influenza. Egiziani, sauditi, yemeniti, kuwaitiani, algerini, siriani e palestinesi raggiunsero la città di Peshawar, al confine con il Pakistan, per combattere al fianco di bin Laden. Ma non appena i guerriglieri mujaheddin e la legione araba di bin Laden erano riusciti a cacciare i russi dall’Afghanistan, gli afghani avevano cominciato a scagliarsi gli uni contro gli altri carichi di odi tribali. Disgustato da questa perversione dell’Islam – il dissenso originario all’interno della umma aveva portato alla divisione tra sunniti e sciiti – bin Laden era tornato in Arabia Saudita.
Ma il suo viaggio di amarezze spirituali non era ancora finito. Nel 1990, quando Saddam Hussein invase il Kuwait, offrì ancora una volta i suoi servigi alla famiglia reale saudita. Non era necessario che chiedesse agli Stati Uniti di andare a proteggere i due santuari più importanti dell’Islam, sosteneva. La Mecca e Medina, le città in cui il Profeta Maometto aveva raccolto e proclamato il messaggio di Dio, avrebbero dovuto essere difese dai musulmani. Bin Laden avrebbe guidato i suoi «afghani», i suoi mujaheddin arabi, contro l’esercito iracheno in Kuwait e avrebbe costretto Saddam a lasciare l’emirato. Ma il re Fahd preferì affidarsi agli americani. Perciò, mentre l’82a Divisione Aviotrasportata dell’esercito degli Stati Uniti raggiungeva la città di Dhahran, nella regione nordorientale dell’Arabia Saudita, e si schierava nel deserto a meno di 400 miglia da Medina – il luogo in cui si era rifugiato il Profeta e che aveva ospitato la prima società islamica – bin Laden abbandonava la corrotta casa regnante saudita per offrire il suo generoso aiuto a un’altra «Repubblica Islamica»: quella del Sudan.
Il nostro viaggio a nord di Khartoum ci portava attraverso un paesaggio fatto di deserto bianco e antiche piramidi inesplorate, tombe faraoniche scure e tozze più piccole di quelle di Cheope, Chefren e Micerino a Giza. Sebbene fosse dicembre, il deserto era spazzato da un vento tagliente e caldissimo, e quando Kashoggi si stancò dell’aria condizionata e aprì il finestrino gli svolazzarono i lembi del suo copricapo arabo. «La gente di qui ama bin Laden» disse come se stesse facendo un commento su un invitato a cena. «Ha trasferito qui le sue attività e la sua impresa di costruzioni e il governo è contento. Aiuta i poveri.» Questo lo potevo capire. Il Profeta Maometto, rimasto orfano in tenera età, era stato ossessionato dalla povertà dell’Arabia del sesto secolo, e la generosità nei confronti dei poveri è una delle caratteristiche più affascinanti dell’Islam. La trasformazione di bin Laden da «santo» guerriero a benefattore del popolo avrebbe potuto permettergli di calcare le orme del Profeta. Aveva appena completato la costruzione di una nuova via che dall’autostrada Khartoum-Port Sudan portava al minuscolo villaggio di Almatig, nel deserto settentrionale, usando gli stessi bulldozer che aveva impiegato per spianare le piste dei guerriglieri in Afghanistan; molti dei suoi operai avevano combattuto con lui contro l’Unione Sovietica. Come prevedibile, il dipartimento di stato americano non vedeva di buon occhio la beneficenza di bin Laden. Accusava il Sudan di «sponsorizzare il terrorismo internazionale» e lo stesso bin Laden di aver organizzato «campi di addestramento per i terroristi» nel deserto sudanese.
Ma quando io e Kashoggi arrivammo ad Almatig, bin Laden era lì, con la sua veste frangiata d’oro, seduto sotto una tenda davanti agli abitanti del villaggio in adorazione, guardato dai leali mujaheddin arabi che avevano combattuto con lui in Afghanistan. Quelle figure barbute e silenziose – disarmate, ma mai a più di pochi metri di distanza dall’uomo che le aveva reclutate, addestrate e poi spedite a sconfiggere l’esercito sovietico – osservavano senza sorridere i contadini sudanesi che facevano la fila per ringraziare l’uomo d’affari saudita il quale stava per completare la strada che per la prima volta nella storia avrebbe collegato i loro miseri villaggi a Khartoum.
La mia prima impressione fu quella di un uomo timido. Aveva gli zigomi alti, gli occhi piccoli e una lunga veste marrone, e quando i capi del villaggio si rivolgevano a lui distoglieva lo sguardo. Sembrava a disagio di fronte a tutte quelle manifestazioni di gratitudine, incapace di rispondere con un sorriso aperto quando le bambine nei loro minuscoli chador gli danzavano davanti e i predicatori lodavano la sua saggezza. «Abbiamo aspettato di avere questa strada durante tutte le rivoluzioni del Sudan» annunciò uno sceicco barbuto. «Abbiamo aspettato fino a perdere ogni speranza – e poi è arrivato bin Laden.» Notai che bin Laden, con il capo ancora chinato, aveva alzato gli occhi per scrutare il vecchio, si era reso conto della sua età e non era affatto contento di starsene seduto tranquillo di fronte a lui, di essere un giovane rilassato davanti a un anziano in piedi. Ed era ancora meno contento della presenza di un occidentale a pochi passi da lui, e di tanto in tanto girava la testa per guardarmi, non con malevolenza ma con profondo sospetto.
Kashoggi lo abbracciò. Bin Laden lo baciò sulle guance, erano entrambi musulmani, e consci dei pericoli affrontati insieme in Afghanistan. Se Jamal Kashoggi aveva portato lì quello straniero doveva esserci un motivo. Probabilmente era a questo che stava pensando. Perché mentre Kashoggi parlava, bin Laden mi guardava e di tanto in tanto annuiva con il capo. «Robert, voglio presentarti lo sceicco Osama» gridò quasi Kashoggi per sovrastare le grida dei bambini. Bin Laden era alto, e mentre stringeva la mano al giornalista inglese si rese conto di essere in una posizione di vantaggio. Salaam aleikum. La sua stretta era ferma, non forte, ma indubbiamente mi sembrò un uomo della montagna. I suoi occhi ti scrutavano. Era magro, aveva le dita lunghe e un sorriso che – anche se non si poteva certo definire dolce – non sembrava neanche maligno. Disse che avremmo potuto andare a parlare nel retro della tenda, avremmo evitato gli strilli dei bambini.
Ripensandoci oggi, sapendo quello che sappiamo, e che figura mostruosa e bestiale sarebbe diventata bin Laden nell’immaginario collettivo, cerco di ricordare qualche particolare, un indizio che avrebbe potuto farmi minimamente sospettare che quell’uomo potesse ispirare un’azione che avrebbe cambiato il mondo per sempre – o meglio, consentire a un presidente americano di convincere il suo popolo che il mondo era cambiato per sempre. Sicuramente il suo formale ripudio del «terrorismo» non lo lasciava intuire. La stampa egiziana sosteneva che bin Laden aveva portato a lavorare con sé in Sudan centinaia dei suoi guerrieri afghani, mentre nell’ambiente delle ambasciate occidentali di Khartoum si diceva che alcuni arabi «afghani» che questo imprenditore saudita aveva fatto arrivare in Sudan fossero piuttosto occupati ad addestrare uomini per nuove jihad in Algeria, Tunisia ed Egitto. Bin Laden era consapevole di questo. Le definiva «la spazzatura che raccontano i media e le ambasciate». «Sono un costruttore e un imprenditore agricolo. Se avessi dei campi di addestramento qui in Sudan, non potrei certo fare questo lavoro.»
Un «lavoro» sicuramente ambizioso: non solo il collegamento con Almatig ma anche una nuova autostrada da Khartoum a Port Sudan. I 1200 chilometri che separavano le due città con la vecchia strada sarebbero diventati solo 800 con la nuova, e sarebbe stato possibile raggiungere la capitale in un giorno. In un paese disprezzato dall’Arabia Saudita quasi quanto dagli Stati Uniti per l’appoggio che aveva offerto a Saddam Hussein dopo l’invasione del Kuwait, bin Laden stava usando le sue attrezzature per costruire uno stato paria. In effetti mi ero chiesto perché non avrebbe potuto fare altrettanto nel desolato Afghanistan, ma all’inizio, mentre se ne stava seduto nel retro della tenda a pulirsi i denti con uno stecchino di mishwak, rifiutò di parlare della sua guerra. Alla fine però arrivò a parlare di quella guerra che aveva vinto per gli afghani, con l’aiuto degli americani, dei sauditi – e dei pachistani – contro i russi. Voleva parlarne. Pensava che gli avrei fatto domande sul «terrorismo» e quando si rese conto che gli stavo chiedendo dell’Afghanistan – nonostante tutte le sue riserve e i suoi sospetti nei confronti dello straniero – volle raccontarmi di come quell’esperienza aveva cambiato la sua vita.
«Quello che ho vissuto lì in due anni» disse «altrove non avrei potuto viverlo neanche in cento. Quando cominciò l’invasione dell’Afghanistan, ero furioso e andai lì immediatamente – arrivai nel giro di pochi giorni, prima della fine del 1979, e continuai a tornarci nei nove anni successivi. Ero indignato per l’ingiustizia che si stava commettendo nei confronti del popolo afghano. Mi aiutò a capire che nel mondo le persone che hanno il potere lo usano sotto nomi diversi per sovvertire i regimi di altri paesi e imporre le proprie idee. Certo, io ho combattuto laggiù, ma i miei fratelli musulmani hanno fatto molto di più. Molti sono morti e io sono ancora vivo.» Di solito l’invasione russa si fa risalire al gennaio del 1980, ma i primi soldati delle Forze Speciali sovietiche entrarono a Kabul prima del Natale 1979, quando loro stessi – o i loro alleati afghani – uccisero il presidente comunista in carica Hafizullah Amin per sostituirlo con il loro fantoccio, Babrak Karmal. Osama bin Laden si era mosso in fretta.
Con l’aiuto dell’ingegnere iracheno Mohamed Saad, che adesso stava costruendo l’autostrada per Port Sudan, aveva scavato enormi tunnel nelle montagne Zazai, nella provincia di Pakhtia, da usare come ospedali per i guerriglieri e come depositi di armi, poi aveva aperto una pista per i mujaheddin che attraversava tutto l’Afghanistan e arrivava a 25 chilometri da Kabul, una maestosa opera di ingegneria che i russi non riuscirono mai a distruggere. Ma quale lezione aveva tratto bin Laden dalla guerra contro i russi? Era stato ferito cinque volte e 500 dei suoi guerrieri arabi erano morti in combattimento – le loro tombe si trovano a Torkham, appena all’interno del confine afghano – e neanche lui era immortale, o no?
«Non ho mai avuto paura della morte» rispose. «Noi musulmani siamo sicuri che dopo la morte andremo in paradiso.» Aveva smesso di stuzzicarsi i denti con lo stecchino di mishwak e parlava lentamente e ininterrottamente, piegato in avanti, con i gomiti sulle ginocchia. «Prima di una battaglia, Dio ci manda la seqina, la tranquillità. Una volta sono stato a soli trenta metri dai russi che cercavano di catturarmi. Sono stato spesso sotto i bombardamenti, ma in cuor mio ero così sereno che mi sono addormentato. Abbiamo parlato di questa esperienza della seqina nei nostri primi libri. Ho visto un proiettile di mortaio da 120 millimetri atterrare di fronte a me, ma non è esploso. Altre quattro bombe sono state sganciate da un aereo russo sul nostro quartier generale senza esplodere. Abbiamo battuto l’Unione Sovietica. I russi sono scappati... Quel periodo in Afghanistan è stato l’esperienza più importante della mia vita.»
Ma che cosa mi diceva dei mujaheddin arabi che aveva portato in Afghanistan – di quell’esercito di guerriglieri che era stato armato dagli Stati Uniti e incoraggiato a combattere i russi, e poi era stato dimenticato dai suoi protettori appena la guerra era finita? Sembrava che bin Laden si fosse aspettato quella domanda. «Personalmente, né io né i miei fratelli abbiamo mai visto una traccia degli aiuti americani» disse. «Quando i miei mujaheddin han...