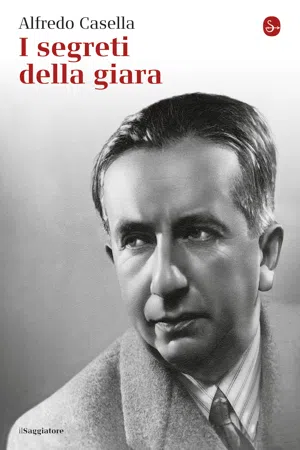![]()
parte terza
Roma (1915-1938)
Si giunse a Roma di sera, a notte fatta. La città era quasi al buio, i fanali essendo velati di azzurro per precauzione anti-aerea. Regnava poca animazione per le strade, e la bruttissima via Nazionale (che purtroppo è la prima che si offre allo sguardo impaziente dello straniero che giunge nuovo a Roma) era molto triste di aspetto.
Dopo pochi giorni passati da una cugina, trovammo un appartamento in via Basilicata, vicino a Porta Salaria. Io presi subito contatto col Liceo Musicale di Santa Cecilia (il quale non era allora Regio Conservatorio, ma semplice istituzione municipale). Conobbi il mio direttore Marco E. Bossi, che mi accolse con vivissima cordialità. Cominciai le mie lezioni, e trovai alcuni buoni alunni, che subito presero a volermi molto bene. E poco a poco, cercai di penetrare nell’ambiente musicale ed anche in quello sociale.
Roma era allora qualcosa di totalmente diverso dalla ampia e «tentacolare» metropoli odierna. Era una città nella quale – accanto alle mirabili vestigia del passato (mancavano però tutte quelle di scavo recente che il Fascismo ha avuto il merito immenso di ridare alla luce, e che erano allora sepolte sotto povere e luride casupole), si trovavano interi quartieri mediocri e di aspetto provinciale, ai quali naturalmente non badava nel suo entusiasmo lo straniero di passaggio, ma che opprimevano l’abitante. Per fortuna, allora come oggi, la magnificenza della natura e del cielo facevano dimenticare il lato debole della città ed un artista poteva essere felice di contemplare tante cose belle e di vivere in mezzo a simile magnificenza storica rimasta viva nella testimonianza della pietra.
La Roma del 1915 differiva anche molto da quella odierna per il carattere della sua popolazione, la quale era ben lungi, a quei tempi, dall’aver assorbito il mezzo milione di emigrati dalla rimanente Italia che si riversò sulla capitale dal 1917 in poi. Allora il «Romano de Roma» era ancora padrone in casa propria e guardava non dico gli stranieri, ma persino gli altri italiani, con quel senso di orgoglio atavico che non si spense mai nei figli di Roma nemmeno nei tempi più duri. E l’italiano calato giù dall’Alta Italia andava a sbattere – e sempre a spese sue – contro quel senso di cruda satira, di sprezzante fierezza, di indifferenza verso tutto ciò che non fosse romano, per la semplice ragione che nulla al mondo avrebbe mai potuto esistere di più grande che romano. In questo senso, il trovarsi in quella Roma, riusciva, per un piemontese vissuto a Parigi, più problematico che stare all’estero, tanta era la differenza di carattere, di costume e di civiltà che mi divideva da quelli.
In quei primi tempi romani, i più frequenti contatti furono quelli col Conte San Martino e Valperga. Di millenaria stirpe piemontese, questo gentiluomo era stato da giovanissimo amico dei miei genitori ed aveva anche fatto musica in casa di mio padre. Ho già accennato – nel proemio di questo libro – alle aderenze del Conte San Martino con quell’ambiente musicale torinese così eletto e superiormente colto, che era stato floridissimo soprattutto alla fine dello scorso secolo ed all’inizio di questo. Questa base culturale fu sempre guida al Conte in ogni sua azione. Organizzatore di qualità eccezionale, quando egli si accinse a quella fondazione che legherà il suo nome alla storia: l’Augusteo romano, aveva dietro di sé una enorme esperienza ed una conoscenza consumata dei valori internazionali. Nessun criterio di malinteso, gretto nazionalismo ebbe mai a porre limiti alla sua azione, ma egli comprese sempre che, volendo che l’arte strumentale nostra potesse dapprima risorgere e quindi rendersi indipendente, occorreva lasciare entrare l’ossigeno da fuori. Uomo di estrema modernità, l’ho sempre trovato disposto ad accogliere qualsiasi tentativo di novità, qualsiasi «avvenirismo» purché sincero; in mezzo alla sua Accademia, egli fu sempre il più giovane di spirito. E, per quanto mi riguarda, debbo dire che la sua amicizia verso di me rimase sempre inalterata come la sua fiducia nella mia arte; e questo malgrado tutti i tentativi esercitati durante tanti anni da persone interessate a turbare quella amicizia e quella fiducia a scopi non sempre confessabili. Qualche rara volta fummo discordi. Ma le nostre discussioni non abbandonarono mai il tono più elevato e, rapidamente terminate quelle, l’amicizia reciproca si ritrovò più salda di prima.
Diaghilef era rimasto a Roma sin dall’autunno del 1914. Aveva affittato un appartamento all’ultimo piano del n. 9 in via del Parlamento, e viveva con Leonida Massin e con un bellissimo cameriere italiano che rispondeva al nome di Beppe. Massin aveva portato con sé molti quadri ed altri ne andava acquistando. Dimodoché la casa – della quale Beppe lasciava sempre la porta spalancata – era un continuo andirivieni di pittori soprattutto futuristi (gli altri non ci si arrischiavano) che salivano ad offrire ai due russi i loro prodotti artistici. Strawinski viveva in Svizzera a Clarens, ma veniva spesso a Roma e talvolta passò anche parecchi mesi in quella città che sempre predilesse.
La vita musicale aveva subito una forte scossa colla guerra, dato soprattutto che la grande maggioranza degli interpreti sino allora venuti a Roma erano tedeschi, austriaci ed ungheresi. Il grave compito di assicurare la vita dell’Augusteo venne tutto a pesare sulle spalle di Bernardino Molinari, il quale però seppe mandare avanti la barca con una energia davvero ammirevole e – non dimentichiamolo – di fronte ad una ostilità e ad una impopolarità che durarono parecchi anni e che erano in parte frutto del naturale scetticismo romano, ma anche opera sotterranea e subdola di musicisti maligni e malcontenti. In quel 1915, vennero all’Augusteo – oltre ai nostri Guarnieri, Gui e Mascheroni – gli stranieri Baton e Beecham. Quest’ultimo era un curiosissimo tipo. Giunse senza programma, ma recando con sé un vagone di materiali. Leggeva musiche una dopo l’altra e non sapeva decidersi a scegliere. Quando poi aveva scelto, si seccava a provare. Molinari propose allora a Beecham di fargli tutte le prove meno l’ultima. Beecham fu felicissimo, se ne andò in giro per la campagna romana e tornò il giorno della prova generale. È un uomo di grandissimo talento naturale, che eccelle soprattutto in Mozart. E siccome è pure ricchissimo (la sua fortuna, come è noto, proviene da quelle celebri Beecham Pills contro le affezioni del fegato che furono creazione del padre) ogniqualvolta il custode dell’Augusteo gli infilava il cappotto, gli regalava venti lire (dell’epoca), di modo che quello divenne in pochi giorni un anglofilo spaventoso.
Concertisti di fama non ne mancarono neppure quell’anno: Thomson, D’Albert, Prokofief, Gemma Bellincioni, ecc. Ma soprattutto era interessante il fatto che, malgrado la guerra, continuavano a figurare sui programmi i grandi maestri tedeschi ed austriaci: Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, ecc., sintomo questo di singolare larghezza di spirito che sola con noi dimostrava l’Inghilterra.
Deciso a buttarmi a capofitto in quella azione rinnovatrice per la quale mi ero armato da tanto tempo, cercai di fondare un giornale di battaglia. Riuscendo questo momentaneamente impossibile, tentai – previo consiglio del Conte di San Martino – di mettere la mano su un settimanale musicale romano che si chiamava Musica e che era diretto da Raffaello De Rensis. Dopo alcune conversazioni, pareva che tutto andasse a gonfie vele ed infatti una quantità di nuovi collaboratori entrò a far parte, almeno come promessa, del rinnovato giornale. Ma trascorse poche settimane, i dissensi tra me e De Rensis – il quale non aveva nessuna simpatia per il mio movimento né per le mie iniziative e che doveva più tardi, per molti anni, contribuire a svalutare la mia arte e creare equivoci sulla mia figura di artista – divennero tali che abbandonai Musica alla sua triste sorte e ripresi la mia libertà.
Nell’autunno del 1915, un fortuito incontro avvenuto in treno mi fece conoscere un giovane cinese, del quale non ricordo il nome. Era un ragazzo appena ventunenne, di una intelligenza sorprendente. Mi interessava particolarmente l’avvicinarlo, non avendo io sino allora frequentato nessun giallo estremo-orientale. Dotato di una facilità incredibile per le lingue, aveva imparato il tedesco in tre mesi, il francese in due ed in tre altri si impadronì dell’italiano. I nostri rapporti divennero subito cordiali e rimasero frequenti per tutto il tempo che egli trascorse a Roma. Egli mi diceva della impressione di ripugnanza fisica che produce sui gialli il nostro naso, ai loro occhi una vera mostruosità. Mi spiegava che la musica europea era per loro un rumore privo di senso e che persino un’aria di Bellini suonava al loro orecchio come un teorema cacofonico. Le nostre conversazioni sulla guerra erano straordinariamente interessanti, tanto egli vedeva le cose da una distanza per noi incolmabile. Alla fine dell’anno egli lasciò Roma per recarsi a Ginevra. Mi inviò dalla Svizzera un bellissimo pezzo di seta sul quale aveva scritto o meglio disegnato con un pennello una antica poesia cinese. Ed ai primi del 1916 mi mandò una lettera nella quale egli diceva:
Ginevra, gennaio 1916.
Ho molto riflettuto alle nostre conversazioni sul conflitto europeo, ed eccovi la mia opinione: se la guerra verrà vinta dagli Imperi centrali, sarà il trionfo della forza bruta; se invece vince l’Inghilterra, sarà il trionfo del denaro. Dunque in tutti i modi, il risultato di questa guerra non può essere che immorale. In tutto questo io non vedo che una pennellata artistica (un coup de pinceau artistique), ed è l’intervento dell’Italia.
Nell’anno 1916, ebbimo pochi artisti stranieri. Ma in compenso parecchi italiani di eccezione, fra i quali Toscanini e Busoni. Toscanini diresse nel febbraio Petrouchka, il quale rinnovò il successo dell’anno precedente. Nel febbraio, diedi a Santa Cecilia un concerto a due pianoforti con Gino Tagliapietra, nel quale venne eseguito per la prima volta in Italia En blanc et noir di Debussy. Il 2 marzo, Molinari diresse la suite sinfonica del mio Convento veneziano, la quale fu accolta glacialmente e senza l’ombra di un applauso. Facevo melanconicamente il paragone di questa incomprensione ostile col successo schietto che questa suite aveva già incontrato all’estero e misuravo con crescente apprensione la strada che mi rimaneva da percorrere per essere accettato in patria come altrove. A Santa Cecilia ebbero luogo alcune sedute da camera col nuovo quartetto «accademico» creato dal Conte San Martino e composto di Serato, Corti, Dudovich e Magalotti, sedute alle quali partecipai come pianista e che riuscirono molto belle. Nel precedente gennaio avevo pure «debuttato» come pianista all’Augusteo, eseguendovi un concerto di Mozart e le Variazioni sinfoniche di Franck.
I rapporti con Busoni subirono in quei tempi una interessante evoluzione. Sino allora Busoni mi aveva dimostrato, a traverso una cordialità piuttosto formale, una certa diffidenza (la quale del resto è documentata da parecchie lettere pubblicate dal prof. Dent nella sua biografia busoniana). Un giorno però (ed era precisamente nel marzo 1916) la mamma volle essere presentata dopo il concerto al grande pianista. Quando Busoni vide quella piccola vecchietta, si commosse moltissimo e le fece una accoglienza veramente figliale, dicendo che gli pareva di rivedere sua madre. Da quel giorno, egli prese veramente a volermi bene, ma, cosa curiosa, perché aveva indovinato che cosa fosse stata per me quella eccezionale donna. Conservo infatti una sua lettera, in data 21 luglio 1923, nella quale egli scriveva:
Non occorre che io ripeta che Le voglio un gran bene, che ammiro la Sua energia ed intelligenza. Ma so anche che Lei è buono; e non ho dimenticato quel momento, quando Ella entrò nel camerino accompagnato dalla Sua Signora Madre! L’amor filiale, la devozione all’arte: ecco i due punti, che mi legano a Lei.
Il 24 marzo (1916) apparve alla sala accademica una pianista quattordicenne napoletana che produsse una impressione straordinaria: Tina Filipponi Siniscalchi. I doni naturali di questa ragazza erano eccezionali, tanto dal lato musicale quanto da quello tecnico. Una anima calda, passionale, tutta meridionale, servita da un suono di una rara bellezza, da un meccanismo di una perfetta nitidezza, facevano delle interpretazioni di questa fanciulla qualcosa di veramente superiore e di altissima classe. È certo che se Tina avesse vissuto, avrebbe avuto ben poche rivali non solamente in Italia ma anche nel mondo intero. Purtroppo Dio – che forse le era stato troppo prodigo di doni – la riprese a sé pochi anni dopo. Ma essa ha lasciato, come artista e come donna, in tutti coloro che ebbero la fortuna di avvicinarla e di udirla, un ricordo incancellabile, un ricordo di una creatura fatta di bellezza, di luce, di passione, di gioia e di profonda melanconia, una autentica figlia di quella terra napoletana tutta sole eppur così misteriosa, così tragica nella sua anima.
Le composizioni di quegli anni furono (dopo i Nove pezzi per pianoforte) le Pagine di guerra ed i Pupazzetti per pianofor...