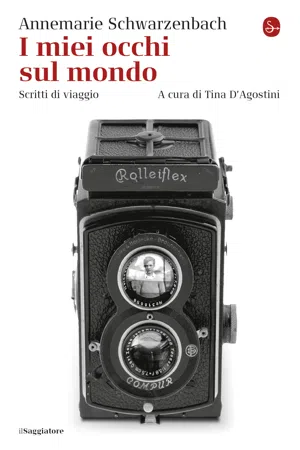![]()
Sul viaggiare
Lettera dalla Costa Azzurra
Che cosa si può fare qui? Stare tutto il giorno sdraiati sulla spiaggia? È quello a cui si dedicano quasi tutti, sentendosi perfettamente a proprio agio. E, va notato, nessuno sembra sentirsi in colpa. Eccoli là, senza pensare all’ora, anzi senza pensiero alcuno, seminudi, abbronzati e in alcuni casi di aspetto assai gradevole. Stanno là a oziare, sprecando il tempo prezioso donatoci dal buon Dio. Sono abbastanza privi di scrupoli da affermare che a Lui non importi. Anche un pesante nordico, schiavo del lavoro e oppresso dalla nebbia si adegua in fretta a questo modo di vedere le cose.
Forse dipende dai vestiti. Certo che dipende dai vestiti, avrebbe detto Gottfried Keller. Si getta dunque in un angolo il proprio abbigliamento quotidiano o lo si nasconde in fondo all’armadio. Si acquistano ampi pantaloni alla marinara, che non costano molto e valgono poco. Personalmente consiglio il blu scuro, ma si può anche essere di un altro avviso. Al momento il rosso è molto apprezzato, benché anche l’azzurro sia piuttosto diffuso.
Con addosso simili pantaloni e una camicia colorata e aperta (che da queste parti chiamano chemise d’Antibes) ci si trasforma radicalmente: si diventa più coraggiosi o perfino sfrontati. Si diventa spensierati e noncuranti, non si rispettano più i regolari orari dei pasti e si mangia quello di cui si ha voglia. Al momento viviamo di asparagi e fragole. Klaus si ostina a ordinare ogni giorno fagiolini, perché tende allo sperpero. A volte siamo presi da un vero e proprio attacco di fame. Ieri sera verso mezzanotte una ragazza si è introdotta in una cucina. Mentre noi stavamo nascosti timorosamente sotto una tettoia di bambù, lei saliva, ridendo come un folletto (come una contadina ubriaca, ha detto il giovane poeta), su sedie e armadietti, il berretto calato sull’orecchio destro e, reprimendo un grido di trionfo, brandiva con orgoglio pane, vino e alcune gaufre terribilmente secche.
Oggi abbiamo mangiato capesante con aragosta tagliata fine passate in forno. Erano eccellenti e per un po’ ci tratterranno dagli eccessi.
Ma stavamo parlando di vestiti. Oltre all’abbigliamento alla marinara, si vedono diverse altre tenute da spiaggia. Alcune signore ne inventano di molto carine, altre invece non se ne preoccupano proprio ed escono semplicemente in pigiama, come se fosse fatto apposta per questo. La Riviera è lunga e molto varia. Se si è interessati si può leggere un libro sull’argomento, in uscita per l’editrice Piper di Monaco, scritto da Erika e Klaus Mann.
Bandol (dove vivo al momento) è una cittadina quasi mondana, con un casinò, un Grand Hôtel des Bains e parecchi inglesi. Dista circa sessanta chilometri da Marsiglia, e Tolone, un porto della marina francese che vale la pena di vedere, è facilmente raggiungibile. Nelle vicinanze c’è anche Sanary, dove vivono molti personaggi famosi. Qui la gente non è poi così pigra come si potrebbe credere. A Sanary e a Bandol si scrivono romanzi e resoconti di viaggio. Ogni mattina dunque, qualche capitolo vede la luce. Firmato Wilhelm Speyer per esempio, o Klaus Mann. Su tutti però spicca l’inglese Huxley, che abita a Sanary e di cui i locali vanno molto fieri.
Si può anche segnalare che Mistinguett, sempre giovanile e abile negli affari, sta facendo costruire un hotel da queste parti. Maurice Chevalier si concede spesso qualche giorno di riposo qui, l’attrice Cécile Sorel e il marito, il conte di Ségur, sono anche loro della partita. Moïse Kisling, il pittore, non l’ho visto, ma in compenso ho incontrato la moglie che all’inizio ho scambiato per un bizzarro marinaio.
Da Suzie si incontrano persone di tutti i tipi. Suzie è il locale di Bandol. Ci vengono habitué e veri marinai, e donne molto eccitanti mandate non si sa da chi. Al tavolo accanto sono seduti il nostro parrucchiere e l’uomo molto abbronzato che dopo il bagno ci rifornisce di asparagi e di capesante all’aragosta.
Dato che è Pentecoste, arrivano anche molte automobili piene di gitanti in cerca di svago. Si fermano da Suzie e osservano stupiti le donne che portano i pantaloni.
In realtà il locale non si chiama così. Ha un nome molto grazioso: Fortuné Cadet. Suzie è la proprietaria ed Ernest, il barman, è il suo amante. Il signor Cadet è morto otto giorni fa, ecco perché Suzie è vestita di nero e a volte piange. I clienti li saluta con un «ma chérie» o un «mon petit».
Passeggiare di giorno per Bandol è molto interessante. Ci sono palme, barche a vela, gente snob e pescatori. I pescatori però escono in mare solo quando non hanno più un soldo in tasca. La maggior parte degli autoctoni parla in modo incomprensibile. Sono belli, abbronzati, hanno l’aria da analfabeti. Fumano, appoggiati al muretto del molo, o giocano a bocce.
Arrivo a Maiorca
Le isole sono mete di viaggio inadatte. Spesso è difficile e complicato raggiungerle e ancor più difficile lasciarle. La decisione di prendere un treno o l’automobile dipende dalla nostra energia, dalla voglia di partire. Questa voglia però si paralizza e si logora nel confuso viavai del porto e nelle lunghe ore di attesa a bordo di una nave che scivola esitante verso il mare aperto solo molto dopo che la nostra impaziente nostalgia è già corsa avanti, verso nuove coste, montagne blu, città straniere e strade bianche che ci portano tra le colline: verso dove? Perché viaggiare è partire senza meta, con uno sguardo fugace si abbraccia un villaggio, una valle, e ciò che si ama di più, lo si ama già con il dolore dell’addio. Esiste certo un altro modo di viaggiare, con il Baedeker in mano e il programma di viaggio completo in tasca. La strada da percorrere tra la cattedrale di Chartres e la famosa località balneare di Biarritz diventa allora soltanto una inevitabile e noiosa necessità e si sa già che cosa ci si può aspettare da questa esperienza. Quale magia c’è invece nell’essere davvero in viaggio, nel vedere i nomi acquistare vita e significato, un sogno diventare realtà! Quale gioia si prova nello scoprire che una città, di cui si è letto il nome sulla carta geografica, esiste davvero ed emerge con le sue chiese e le sue porte dalla nebbia della sera! Quanto è grande l’incanto nel trovarsi davanti la costa accarezzata dal vento e il mare blu coronato di spuma dopo aver viaggiato per giorni nella calura dell’entroterra.
Ho scoperto Maiorca. Cent’anni fa, prima di me, altri l’avevano già fatto, alcuni giovani inglesi originali, poeti e pittori. George Sand vi soggiornò in un convento, dal quale scriveva lettere piene di noia e nostalgia agli amici: non ci si può accontentare per sempre della bellezza della natura… Da allora Maiorca è conosciuta come gradevole luogo di vacanze per gli uni e rifugio per gli altri, una bella isola romantica mediterranea, non troppo difficile da raggiungere, ma ai margini dell’Europa. A buon mercato, con un clima mite, magnifiche spiagge di sabbia e un’arena per le corride a Palma… Tutto questo già lo sapevo dai dépliant. Il nome di Maiorca mi affascinava, era stranamente familiare e così cedetti alla tentazione: sarei andata a Maiorca! Quando presi la decisione? Come avvenne che mi ritrovai una sera a bordo di un piccolo piroscafo bianco? Era ancora nel porto di Barcellona, era ancora possibile cambiare idea, scendere, immergersi nei vicoli bui e rumorosi del porto, nel clamore della folla della Rambla, ma io partii per Maiorca. La bianca chiglia della nave fendette le acque morbide e schiumose del Mediterraneo, mentre la falce della luna tra le nubi apriva davanti a noi una strada luminosa, larga e tenue. Fu una notte meravigliosa e di primo mattino arrivammo a Palma. Ho visto città simili sulla costa della Siria e sulle isole greche, con le loro case bianche sui pendii verde oliva, i giardini che si estendono fino alle colline, le ville sulle lingue di terra, i sobborghi e le nuove strade asfaltate alle due estremità della baia. Le torri di guardia saracene si ergono sulle scogliere, la cattedrale grigia, immensa, con i suoi magnifici archi rampanti, sembra stranamente galleggiare nella pienezza della luce chiara e iridescente del mattino. Sulla banchina si trovano balle di merci, taxi polverosi, edicole, cumuli di arance. Vicino alle ciminiere tozze e gialle delle navi oscilla un esercito di piccoli alberi di barche a vela delicati, argentati, trasparenti come i rami dei pioppi. Vengono issate bandiere che si srotolano e crepitano nel vento. Ah, la gioia che ci donano questo arrivo, questa ora del mattino, la freschezza salata e l’odore del mare. Quale spettacolo unico e meraviglioso ci offre questa terra del sud!
Mentre facevo colazione sulla terrazza di un albergo, nel quartiere residenziale di El Terreno, sapevo che il mio arrivo sull’isola era già un dato di fatto, che non sarei ripartita tanto facilmente, che sarei rimasta. Questo paesaggio mi era familiare, questi nomi erano pieni di ore e giorni già trascorsi qui. All’inizio tutto sembrò facile da inquadrare: come Palma assomigliava alle città costiere siriane, così le colline rocciose e al contempo fertili mi ricordavano i versanti del Libano. Nel grigioverde degli ulivi, nella terra rossastra e nei pascoli secchi sulle alture battute dal vento si ritrovava l’aspra dolcezza dei paesaggi meridionali. C’erano villaggi di pescatori e piccole località portuali dietro baie protette come nel sud della Francia. Le antiche torri di guardia erano state costruite dai mori, come le torri di Amalfi dai loro parenti saraceni. Perfino la singolare cattedrale grigia faceva parte di questa costa latina come i castelli dei crociati. La sera, rientrando, si incontravano pastori e pecore intente a pascolare tra i cespugli, tra i lauri e gli ulivi, e si sognava la Grecia… Questa non era una terra sconosciuta, non era l’esilio, l’avventura, era l’Europa: con la sua parte di eredità orientale, la sua legittima discendenza da Roma e dall’Ellade, il suo mare civilizzatore, la sua lingua latina, il suo carattere immortale e magnifico. Tutto questo univa e rafforzava, era ricco di passato e confortante per il futuro. Era necessario andare a Maiorca per sentirlo nel modo più puro e vivo?
Ma quello che vivevo e scoprivo aveva anche il sapore della novità: perché ciò che questa piccola isola ha di unico, di specifico, si è fuso con l’elemento europeo in un felice connubio che ne ha esaltato il fascino. Vidi gli abitanti di un villaggio ballare. Conoscevano molti balli: solenni danze contadine spagnole accompagnate dal suono delle cornamuse; danze orientali e moresche su melodie in semitoni singolarmente melanconiche ereditate dagli arabi, conservate e praticate da cantanti di flamenco; e infine la danza locale, più aggraziata e insieme più scatenata, più libera, più sensuale e più allegra delle altre. Dal suo ritmo trascinante e complicato è nato il bolero. Gli abitanti di Maiorca hanno il loro dialetto, il loro costume tradizionale, le loro abitudini a cui restano tenacemente attaccati. Sono contadini e pescatori, e hanno la loro capitale, Palma di Maiorca. Le sue strade sono così strette che le automobili vi restano incastrate, i carretti a due ruote tirati da asini avanzano traballando sul selciato sconnesso e le sigarette portate qui di contrabbando da Gibilterra costano meno che in qualsiasi altro paese del continente europeo. Alcuni stranieri si sono costruiti una villa a Maiorca. Altri, giunti come rifugiati, vivono ora in un piccolo villaggio sulla costa, dove siedono sotto i leggeri ombrelloni dei caffè, discutono, scrivono libri e forse rimarranno qui per il resto della loro vita: in esilio in questo mare Mediterraneo, il grande fecondatore dell’Europa. In questo luogo si percepisce un’indolente placidità. Si è vicini ai paesi natali e lontani da tutto ciò che ci minaccia e ci si gode le baie e le scogliere, la verde trasparenza del mare, il vento e il gioco delle nuvole. Un giorno dovrò ripartire e lasciare l’isola, spinta dalla mia impazienza, dall’irrequietezza, dall’impulso irrefrenabile e dalla volontà di andare verso mete senza nome. Ma quanto sarà bello e pieno di rimpianti il ricordo di Maiorca! Quanto la amerò allora!
Oriente
1934-1935
Palmira
Il nome di questa città ha un suono meraviglioso: evoca un’intera epoca e, in particolare, è il simbolo della parte orientale dell’impero di Roma, dove le guarnigioni romane e la cultura ellenistica si spinsero in quelle profondità del deserto che sembrano essere riservate in eterno soltanto ai nomadi con le loro tende e le loro greggi. Là, persiani, parti, discendenti di Alessandro e generali di Roma combatterono battaglie che decisero le sorti del mondo.
Il suo nome è meraviglioso quanto il suo aspetto: è paragonabile per imponenza forse soltanto a Baalbek, la romana Eliopoli, con i suoi due giganteschi templi, le colonne rovesciate, la foresta di capitelli spezzati, i resti delle mura di difesa arabe, alte e lisce. Ma Baalbek era soltanto un luogo di culto, consacrato a un’antichissima trinità locale siriana, adottata dai romani e poi sostituita da tre divinità latine. Palmira invece, l’antica città semitica di Tadmor, che divenne grande con Roma e come avversaria di Roma, ha una sua propria storia, è un microcosmo su una minuscola oasi in mezzo al vasto e morto deserto siriano. In questo singolare isolamento, eppure a stretto contatto e sotto l’influenza dei grandi centri del mondo di allora – perché Palmira era una città commerciale e si trovava su un importante asse di comunicazione –, in questa strana interazione a Palmira si sviluppò una cultura a se stante, con abiti, lingua, religione e divinità specifiche, un nuovo stile edilizio, un particolare tipo di tombe. Tutto ciò fu il prodotto di molteplici mescolanze, espressione dell’era in cui Roma guardava sempre più verso Oriente e durante la quale, come risultato di un lungo avvicinamento ostile misto ad attrazione tra Roma e la Grecia, tra la Grecia e l’Oriente, si diffuse l’ellenismo. Nella misura in cui Palmira – il nuovo nome nacque a quell’epoca – prese parte a queste trasformazioni elaborò le proprie peculiarità. È facile distinguere un busto funerario palmireno da opere simili contemporanee.
Ma questa storia non sarebbe così notevole, se non si collocasse nei secoli della grandezza politica e della lenta decadenza culturale dell’impero romano. Le province orientali, a eccezione della Giudea, persero progressivamente la loro autonomia e ben presto anche le loro caratteristiche specifiche. Nel 64 a.C. quando la Siria seleucide divenne una provincia romana, Tadmor-Palmira ottenne l’indipendenza, ma già settanta anni dopo, all’epoca di Adriano, cominciò a fornire all’imperatore i suoi famosi arcieri e all’incirca dal 200 d.C. divenne a sua volta una provincia romana. Poco più tardi troviamo un Odenato di Palmira, un senatore romano che verrà giustiziato come ribelle, e il cui figlio Erodiano viene chiamato «principe di Palmira» in alcune iscrizioni. Con il titolo di console romano, un secondo Odenato sconfigge il persiano Sapore e viene premiato con il titolo di imperator dall’imperatore Gallieno. Senza negare il potere sovrano di Roma, fonda un regno che include tutto il Vicino Oriente, eccetto l’Asia Minore e l’Egitto. La sua vedova è Zenobia, che per tutelare il titolo del figlio minorenne dichiara guerra all’Urbe. Dopo alcune grandi vittorie Aureliano le deve fare tutte le concessioni che lei ha chiesto. L’ambizione di Zenobia cresce. Suo figlio si fa chiamare Augusto e fa coniare monete con la propria effigie e quella della madre. Ma, come nella favola del pescatore e di sua moglie, alla fine l’arroganza viene punita e Zenobia, vinta, è condotta in catene a Roma. Siamo nel 272 d.C. Poco dopo i palmireni si sollevarono ancora una volta contro il potere centrale, ma la rivolta fu soffocata, le mura e le fortificazioni distrutte. Si trattò di un evento tragico che segnò la fine della storia della città. In seguito furono nuovamente erette mura, ma meno possenti. Giustiniano teneva una guarnigione nell’oasi e gli arabi costruirono un castello in cim...