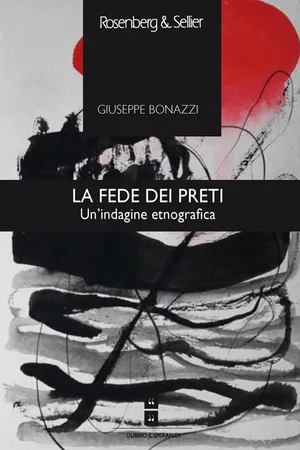PREMESSA
Io non sono credente. A quattordici anni mi imbattei in una massima di Voltaire che mi folgorò: Dio si interessa degli uomini sulla Terra allo stesso modo come un armatore si interessa dei topi nella stiva della sua nave. In materia religiosa quella massima è divenuta la stella polare della mia vita. In un universo infinitamente più grande e sconosciuto di quel che immaginavano i nostri avi, soprattutto in un universo non statico ma percorso da incessanti catastrofi galattiche, la sorte del genere umano su un minuscolo pianeta di un trascurabile sistema solare ha la stessa irrilevanza di una colonia di insetti in una eruzione vulcanica. Ritengo perciò una presuntuosa assurdità (più benevolmente, una favola consolatoria) la narrazione di un Dio Padre Onnipotente (quale fantasioso antropomorfismo!) che privilegia il genere umano di un amore talmente infinito e misericordioso da inviare addirittura suo Figlio in Terra per redimerci dal peccato e indicarci la via per la salvezza eterna. In coerenza con il mio scetticismo da oltre sessant’anni non mi accosto ai sacramenti.
Da queste premesse dovrebbe discendere la mia indifferenza per le vicende della Chiesa, se non persino il compiacimento per i suoi affanni. Invece non è così. A quella narrazione si lega un gigantesco progetto etico centrato sul comandamento «ama il prossimo tuo come te stesso»: parole di vertiginosa problematicità perché ammoniscono che il presupposto per amare il prossimo è amare sé stessi, impresa tra le più difficili e ambigue. Qui entra in gioco la fede. Nel corso della mia vita ho conosciuto tante persone, laici e presbiteri, cosi pervase di fede da sentirsi sospinte verso impegni totalizzanti di vita, dalla contemplazione mistica alla dedizione eroica di sé nell’aiuto del prossimo. È il potere della Grazia santificante, dono divino, dicono i credenti.
Su queste cose ho sempre amato disputare con sacerdoti illuminati. Laicamente, ricorro al rasoio di Ockham, secondo cui è scorretto invocare un’ipotesi maggiore quando un’ipotesi minore è in grado di spiegare lo stesso fenomeno. Non c’è bisogno di postulare l’esistenza di Dio per spiegare estasi mistiche e dedizioni eroiche. Nei processi stocastici che si sviluppano nel nostro patrimonio genetico è possibile ricercare una spiegazione naturalistica di tutte le vocazioni: musicale, matematica, commerciale, politica e anche religiosa. Un giorno, quando la scienza avrà pienamente esplorato la mente umana potremo conoscere con maggior precisione le dinamiche genetiche che portano alla formazione dei vari talenti. Tutto allora ci apparirà naturale, così come oggi sappiamo che un fulmine è una scarica elettrica e non un moto d’ira di Dio. Per ora siamo solo tenuti al massimo rispetto per qualsiasi vocazione umana, compresa quella religiosa. Dobbiamo accostarci a un credente pervaso dalla passione di Dio esattamente come ci accostiamo a un musicista con la passione per il violino o a un capo carismatico teso a combattere le ingiustizie sociali: ben sapendo che tutte le passioni vanno coltivate con libera scelta e che a seconda delle circostanze possono condurre a esiti diversissimi.
Queste considerazioni suggeriscono un approccio alla sociologia della religione molto diverso da quello comunemente praticato. Anziché assumere la religione come un fenomeno sociale di massa in cui si indaga sui macro-fattori che favoriscono o scoraggiano la sua persistenza in una data società, si parte dall’interiorità dei singoli (di norma un piccolo numero) e se ne esplorano dubbi e certezze, svolte e persistenze, scelte di campo e prudenze. Una vocazione, qualunque essa sia, non è data una volta per tutte ma è un processo, spesso tormentato, che accompagna una persona lungo tutta la vita, e che talvolta può dolorosamente appassire. La ricerca sui parroci che qui presento è un esempio concreto di questo modo di intendere lo studio di una vocazione umana in un mondo che cambia.
prima parte
LA DISCESA SUL CAMPO
1. Storia della ricerca
La ricerca è nata quasi per caso dall’incontro con l’amico Giovanni Ferretti, affermato filosofo e teologo.
Ferretti è fautore della “svolta ermeneutica” nella ricezione delle verità di fede e pertanto di una lettura critica sia del Vecchio che del Nuovo Testamento. Il racconto di molti miracoli riportati nel Vangelo, egli sostiene, non sono resoconti di cronaca storica ma midrash, ossia elaborazioni letterarie per comunicare le verità di fede in modo narrativo-simbolico. Quindi non è sempre facile, per noi così lontani dalla cultura di quel tempo, riuscire a distinguere il nucleo storico tramandato dal suo rivestimento letterario. Di fronte al mio dubbio che le sue tesi siano recepite nel pensiero corrente della Chiesa cattolica, Ferretti replica che i suoi numerosi interventi in convegni di studio sono sempre accolti con interesse e favore. Ma quanto di quelle idee circolano nel basso clero impegnato sul territorio, gli obietto, tra i parroci a quotidiano contatto con un mondo divenuto indifferente alle problematiche religiose, eppure percorso da movimenti minoritari variamente impegnati nella rinascita di una presenza cristiana? Non sono io il sociologo, fa tu, è la sua risposta.
È così che sorse l’idea di compiere una ricerca esplorativa su un piccolo campione di parroci operanti nella diocesi di Torino. Mi resi subito conto che sarebbe stato uno spreco limitare la ricerca alle convinzioni teologiche dei parroci, essa offriva l’occasione di affrontare molti altri aspetti della loro condizione umana ed esistenziale. Inserii così le questioni teologiche in una più ampia traccia di colloquio, che inizia con domande sulle caratteristiche, i problemi e le iniziative presenti nelle parrocchie; prosegue chiedendo l’opinione degli intervistati su alcuni problemi aperti e sul futuro della Chiesa; tocca le questioni teologiche e si conclude con una serie di domande sulle loro pratiche pastorali. Si affrontano temi delicati che richiedono da una a due ore di colloquio, qualche volta organizzando un secondo incontro per approfondire aspetti e problemi emersi nel primo. Ne deriva un processo conoscitivo a spirale, dove i temi da indagare si precisano e si arricchiscono strada facendo.
Nulla nel mio lavoro era più lontano dal codificare le risposte secondo schemi predefiniti. Non sapevo dove sarei giunto, ma ero consapevole di affrontare un’impresa mai prima tentata, dal momento che precedenti ricerche italiane e straniere, tutte di impronta quantitativa, indagano sulla composizione sociale sul clero o su specifici problemi connessi alla condizione sociale dei sacerdoti, ma non hanno mai esplorato luci e ombre della fede e delle pratiche pastorali.
Come avrei scelto i parroci da contattare? Escluso il campionamento casuale sulla totalità dei parroci presenti nella diocesi di Torino, dovevo preoccuparmi che per lo meno i principali orientamenti esistenti tra di loro fossero presenti nei soggetti prescelti. Non importava che il campione fosse rappresentativo della totalità, importava che lo spettro dei casi a mia disposizione mi consentisse di esplorare i diversi modi di argomentare. Adottai così un metodo step by step, in conformità ai criteri suggeriti dalla Grounded Theory (Glaser 2001). Un mio amico ben introdotto in curia mi suggerì i nomi di alcuni parroci con l’indicazione del loro orientamento teologico. Fidandomi del mio fiuto telefonai a caso anche in altre parrocchie di città o di provincia; talvolta su mia richiesta furono gli stessi intervistati a indicarmi altri parroci lontani dalle loro posizioni e che contattai per equilibrare il campione. Venni anche a sapere che in alcune parrocchie esisteva un dissidio tra parroci e viceparroci. I primi, già maturi o anziani, si erano formati nel clima innovatore del concilio Vaticano II mentre i secondi, tutti ordinati di recente, erano, forse per reazione generazionale, su posizioni conservatrici. L’occasione mi parve troppo ghiotta per trascurarla e decisi di includere un paio di quei parroci nel mio campione, con la riserva di estenderlo ai loro viceparroci (cosa che poi non avvenne).
Sapevo che i colloqui sarebbero stati in salita, perché ...