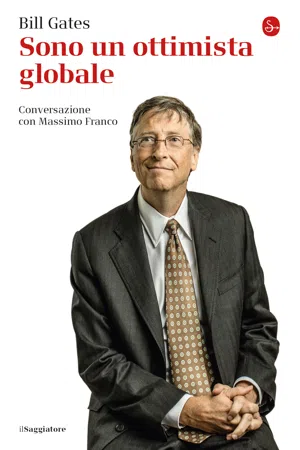![]()
L’INTERVISTA
![]()
Signor Gates, la sua fondazione chiede aiuto anche all’Italia per i Paesi poveri dell’Africa. In un momento di crisi e di paura, come si fa a convincere l’opinione pubblica che è conveniente, oltre che giusto?
Esiste un problema umanitario, in parti del mondo nelle quali le popolazioni non hanno cose che in Occidente sono date per scontate. Noi occidentali, italiani, americani, diamo per acquisito che i nostri figli siano destinati a sopravvivere, a ricevere una buona istruzione. Quindi direi che l’argomentazione morale dopotutto sia la più forte, per invocare un aiuto dall’estero da parte di Paesi che, molto generosamente, donano lo 0,7 per cento del proprio Prodotto interno lordo: una percentuale molto piccola che però può avere un enorme impatto. Ci sono però anche altri benefici. L’Italia si trova essenzialmente alla frontiera con l’Africa, da cui la separa il mare Mediterraneo. Aiutare questi popoli nei loro Paesi, renderli autosufficienti e in grado di moderare il tasso di crescita demografica che è altissimo, può aumentare la loro capacità di nutrire e istruire. E ridurre di conseguenza la pressione migratoria.
Ha detto: «moderare la crescita demografica»?
Esatto. In Africa la popolazione continua a crescere molto rapidamente, e questo aumenta la pressione migratoria, se il continente continua a non avere la capacità di garantire ai suoi abitanti cibo sufficiente e l’opportunità di una vita migliore.
Vede minacce alla stabilità dell’Europa nei prossimi anni, provenienti dall’interno o dall’immigrazione?
Ritengo che il rischio di una destabilizzazione, da qualunque punto di vista lo si guardi, sia piuttosto basso. Se dovessi analizzare un insieme di fatti che potrebbero destabilizzare il mondo, tenderei a rispondere che si tratterebbe di un’epidemia, di un virus, come una febbre molto pericolosa o qualcosa di simile… Il rischio peggiore che intravedo è che si scateni un’epidemia di qualche genere, così grave da provocare dieci milioni di morti. Adesso mi aspetto che la gente, dopo avere visto che cosa accade quando si presentano infezioni come Ebola e Zika, si concentri molto di più sulla ricerca e sul modo di farsi trovare preparati di fronte a potenziali epidemie. C’è un buon livello di conoscenza scientifica sui vaccini, su come metterli a punto più rapidamente, e su come organizzare le risorse per affrontare questo genere di problemi. Per questo penso che di qui a dieci anni saremo pronti, investiremo sulle risorse giuste per affrontare simili emergenze. Una volta eliminate certe malattie… Una guerra mi appare come una fonte di instabilità meno probabile. Credo che abbiamo superato questo tipo di orribili calamità.
La guerra è il passato? Lo pensa davvero?
Ci sono state la guerra nei Balcani e l’Ucraina, certo. E l’Africa non ha ancora superato alcune situazioni di conflitto che sono in corso ancora oggi. Ma in realtà molti si sorprendono nell’apprendere che in Africa oggi ci sono meno conflitti che nel passato, perché è aumentata la consapevolezza delle loro implicazioni. Credo che per lasciarsi alle spalle i conflitti violenti, che in effetti sono un rischio non da poco, l’Africa abbia bisogno ancora di una trentina di anni.
Quindi, a suo avviso, la grande minaccia alla sicurezza è un’epidemia?
Se debbo pensare a qualcosa di veramente preoccupante, sì. Non sto dicendo che c’è un’alta probabilità che accada. Sono in contatto con molti governi e se ne discute, a livello di G8 e di Organizzazione Mondiale della Sanità. Ho avuto modo di scrivere su alcuni di questi temi e proprio perché sono coinvolto dico: «Cerchiamo di ridurre al massimo la possibilità che accada». Non voglio causare allarme nell’opinione pubblica, ma ribadisco, se la domanda è quale possa essere lo scenario davvero nefasto, la mia convinzione è che dobbiamo migliorare le nostre capacità di rispondere a questo genere di minaccia.
Si ha sempre più l’impressione che l’immigrazione sia un problema strutturale, non un’emergenza. E questo crea paura e ostilità in Europa. Lei è in grado di prevedere quanto durerà questo esodo in direzione del nostro continente?
Posso farle l’esempio dell’accordo sul libero commercio fra Stati Uniti e Messico. Fu varato in un periodo di massiccia immigrazione verso gli USA attraverso il confine meridionale: c’è stato un momento in cui l’esodo dei messicani aveva assunto proporzioni impressionanti. Poi, grazie all’aiuto finanziario offerto al Messico, il fenomeno si è riassorbito. E negli ultimi tre o quattro anni l’immigrazione dal Messico negli USA si è praticamente azzerata, perché si sono create condizioni migliori per chi vive in quel Paese. D’altronde, è un trauma lasciare il posto dove sei cresciuto, abbandonare la tua cultura e la tua lingua.
Qualcuno torna in Messico, qualcuno continua a entrare negli USA, ma il flusso netto è stato uguale a zero. Dunque ci sono diversi casi nei quali è possibile creare occasioni per rimanere nel Paese d’origine, quello del quale si condividono la cultura e la lingua. Quando infatti la migrazione si verifica in modo controllato, con percentuali non troppo alte di migranti, può portare benefici. Se invece avviene in modo caotico, senza controlli, con numeri esorbitanti, spesso causa sofferenza a chi si trova ad affrontare il viaggio, e pone una sfida al luogo che li riceve, che può reagire anche con contraccolpi negativi. In Medio Oriente, mi riferisco alla Siria e allo stesso Iraq, vediamo un esodo alimentato dalla guerra. Ritengo che nello spazio di cinque, dieci anni dovrebbe esaurirsi. Per quanto riguarda l’Africa, credo che occorrerà un ventennio almeno affinché si creino condizioni tali da scoraggiare le persone dal cercare opportunità in luoghi diversi dai loro Paesi. Ma la situazione in Africa sta migliorando. Il caso dei rapporti tra Stati Uniti e Messico è molto istruttivo.
L’Africa è molto diversa dal Messico, non crede? Esistono interlocutori affidabili nei governi africani? Quelle nazioni sono in grado di controllare il loro territorio? Spesso si tratta di Paesi destabilizzati, con governi fragili se non falliti.
L’Africa si trova in una situazione non omogenea. L’Etiopia ha avuto una terribile guerra e una spaventosa carestia, ma negli ultimi dieci anni ha fatto ottimi progressi nell’agricoltura e nel sistema sanitario. Il risultato è che la mortalità infantile si è ridotta della metà in Africa, e in Etiopia è diminuita di due terzi. Abbiamo casi di Paesi che nel passato avevano un estremo bisogno di aiuti per combattere la mancanza di cibo, mentre oggi riescono a trovare al proprio interno la maggior parte delle risorse necessarie. E questo perché la loro produttività agricola è cresciuta, soprattutto nelle aree meno gravemente colpite dalla siccità. Significa che sono in grado di affrontare da soli gran parte dei propri problemi. Di recente hanno avuto a che fare con l’arrivo dei rifugiati dalla Somalia, e sono loro, gli etiopi, a gestire i campi di accoglienza. Dunque, oggi l’Etiopia contribuisce alla stabilità dell’Africa. E se la popolazione continua a progredire, la crescita demografica rallenterà, mentre ci auguriamo che l’esempio positivo offerto dagli etiopi si estenderà ad altri Paesi.
Ci sono altri casi nei quali da una situazione terribile, di genocidio, si è passati a un miglioramento dovuto all’istruzione, alla partecipazione delle donne, sebbene siano ancora molto povere. Dal punto di vista politico, ci sono Paesi come la Libia che hanno governi almeno formalmente in carica. Ma la Somalia è molto debole: in quello Stato ci troviamo di fronte a una situazione conflittuale che ricorda il Sudan del Sud. E il governo è debole anche nella Repubblica Centrafricana. D’altronde, non è verosimile che cinquantaquattro nazioni si rimettano in sesto in un baleno; eppure il trend verso un miglioramento della stabilità politica e dei sistemi di governo ha enormemente favorito la salute e l’istruzione.
È piuttosto straordinario che persone che si limitano a leggere i titoli dei giornali possano non accorgersi di questi miglioramenti progressivi, anno dopo anno. Credo che la maggior parte della gente, apprendendo quanto è cresciuta l’alfabetizzazione in Africa, o quanto è diminuita la mortalità infantile, direbbe: «Ehi! Questa non l’avevo mai sentita!». Per...