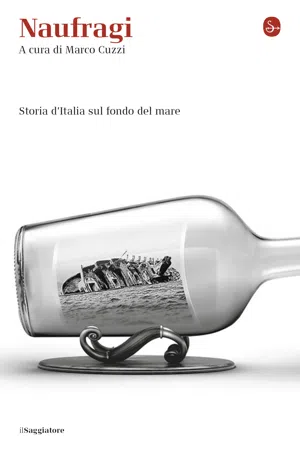![]()
15 aprile 1912, gli italiani del Titanic
claudio bossi
La White Star Line, società marittima britannica, venne fondata a Liverpool nel 1845. In quell’epoca nessuno poteva immaginare che sarebbe passata alla storia per il peggior naufragio, in tempo di pace, che la storia umana abbia mai raccontato: quello del Titanic.
Queste sono le vicende di una coppia italiana, marito e moglie, che per coronare il sogno d’amore e formare una nuova famiglia sono saliti a bordo del gigante dei mari.
Lui, Sebastiano Del Carlo, classe 1883, è un bell’uomo, alto, con baffi sontuosi arricciati all’insù. Lei, Argene Genovesi, classe 1887, è una donna avvenente, un po’ più bassa del consorte.
Entrambi sono originari della provincia di Lucca: lui di Capannori, lei di Montecarlo.
Appena maggiorenne, Sebastiano era partito per l’America in cerca di fortuna. E un po’ di fortuna doveva averla trovata davvero, se poteva permettersi di tornare spesso in Italia. Si racconta che tornava per cercarsi una moglie, perché la voleva del proprio paese, con le sue stesse tradizioni e princìpi. Dopo un po’ di viaggi individua la donna che cercava in Argene, una bella ragazza che abita nel paese vicino. I due cominciano a scriversi, e al successivo viaggio di Sebastiano in Italia viene organizzato l’incontro ufficiale. Così scoprono di essere fatti l’uno per l’altra. «Vista e presa» raccontava Argene quando parlava di quel fidanzamento. Nel giro di qualche settimana i due si sposano e sono pronti a partire per la lontana America, dove lui vive e lavora, e lei ha due sorelle già emigrate da tempo.
Sebastiano è un impiegato statale, e quando una mattina gli arriva un dispaccio che gli chiede di rientrare in anticipo, va subito in un’agenzia marittima per acquistare i biglietti. In quel periodo, però, tutti i bastimenti in partenza dall’Italia sono già stracolmi, perciò l’agente marittimo propone ai due giovani la rms Titanic, la nuova ammiraglia della compagnia inglese White Star Line.
Il transatlantico partirà il 10 aprile 1912 da Southampton, in Inghilterra. Però prima di fare rotta verso Occidente sono previste due fermate: in Francia, a Cherbourg, e in Irlanda, a Queenstown, per imbarcare altri passeggeri.
La nave è nuova e innovativa, a detta di tutti è unsinkable, inaffondabile, e questo è il suo viaggio inaugurale: a disposizione dei passeggeri di prima classe ci sono una piscina, una palestra, un bagno turco, un campo di squash e anche la stazione radio. Questa meraviglia della tecnica, dovuta al genio di un italiano, Guglielmo Marconi, avrebbe consentito ai passeggeri più facoltosi di tenere i contatti con la terraferma e avere aggiornamenti sui listini di borsa, oppure i risultati degli avvenimenti sportivi.
Riuscire a partire con il Titanic per Sebastiano rappresenta davvero un gran colpo di fortuna. Ma bisogna poterselo permettere. Problemi non ne hanno di sicuro i ricconi di prima classe, dove il biglietto per una suite costa ottocentosettanta sterline, un prezzo alla portata solo degli uomini più ricchi dell’epoca. La normale cabina di prima costa sulle trenta sterline. Poi ci sono le rispettabili cabine di seconda che costano poco meno della metà. In terza classe, le tre sterline del biglietto sono una somma niente male per gli emigranti che spesso non possiedono denaro abbastanza per mettere insieme il pranzo con la cena. Ma quel sogno di nave, quel viaggio verso la fortuna e una vita migliore, nell’immaginario di ognuno dei passeggeri vale tutti i sacrifici possibili.
Nelle cabine di prima classe non c’è più posto, dicono a Sebastiano, che quindi prenota in seconda. Di ritorno dall’agenzia di viaggi, Sebastiano non manca di comunicare alla sua Argene la soddisfazione di aver avuto l’opportunità di prenotare il tragitto verso l’America su quel meraviglioso bastimento. Le riferisce anche ciò che scrivono i giornali a proposito del Titanic: una nave inaffondabile, ha la chiglia con un doppiofondo esteso per tutta la lunghezza e vanta ben sedici compartimenti stagni, con porte a tenuta ermetica che, in caso di incidente, possono essere chiuse anche elettricamente.
Sebastiano riferisce alla moglie anche quanto gli ha detto l’impiegato dell’agenzia: per il viaggio inaugurale del transatlantico si intende attirare la miglior clientela possibile mantenendo basso il numero dei passeggeri a bordo, cosicché ognuno sia coccolato e servito come a casa propria. Argene può stare tranquilla: sarà uno splendido viaggio.
I due sposi, giunti a Cherbourg al tramonto del 10 aprile 1912, salgono a bordo del Nomadic, la barca che traghetta i passeggeri di prima e seconda classe dalle banchine al Titanic, per imbarcarli sul grande transatlantico ormeggiato in rada. Alla vista del gigante, Argene rimane sbalordita per via degli enormi fumaioli. Sebastiano le riferisce quello che ha sentito dire: ai tre realmente funzionanti ne è stato aggiunto un quarto, del tutto fittizio, per conferire un’idea di maggiore potenza e velocità: i fumaioli dipinti giallo ocra e nero non potevano passare inosservati, svettando sui mari anche da molto lontano.
A Cherbourg si imbarcano anche molti dei bei nomi del tempo, che non vogliono perdersi quel mondanissimo primo viaggio del Titanic. Ci sono i coniugi John Jacob e Madeleine Astor, eredi di un impero immobiliare, di ritorno da una lunghissima luna di miele; c’è Benjamin Guggenheim, magnate del rame; c’è la giovanissima attrice Dorothy Gibson, di cui Argene ha letto sui giornali. Tra i passeggeri che stanno per salire a bordo, Argene vede una prosperosa e ciarliera signora. Si chiama Margaret Tobin, sposata Brown: una simpatica americana che ha conosciuto le difficoltà dell’esistenza e che ha deciso di fare della filantropia la sua ragione di vita. Argene nota anche un’altra signora americana, Charlotte Wardle Cardeza, ma fa caso soprattutto al bagaglio che porta con sé: ha fatto caricare ben ventitré bauli stracolmi di vestiario di ogni genere. Corre voce che per quel breve viaggio di una settimana abbia portato con sé settanta abiti! Fra i tanti nota anche un vivace fanciullo, Robert Douglas Spedden, che il giorno dopo vedrà giocare con la trottola, sotto l’occhio vigile della bambinaia, sul ponte di passeggiata. E poi, non può fare a meno di osservare l’imbarco di una giovanissima coppia con due piccole creature: la famiglia Laroche. Soprattutto osserva l’uomo, l’unico passeggero afroamericano presente a bordo. E infine – ulteriore meraviglia – vede anche l’unico passeggero giapponese del Titanic, Masabumi Hosono, un funzionario statale di Tokyo. Insomma per la giovane sposa toscana si preannuncia una splendida luna di miele, con molta gente interessante con cui fare amicizia.
Ma Argene e Sebastiano in realtà non sono soli, nel grembo della donna già si fa largo una nuova vita: una splendida famigliola in rotta verso un futuro tutto da creare. Cosa si può chiedere di più alla sorte benigna? Il viaggio non sarà certo noioso. E poi, il mare ad Argene piace e il Titanic non è certo una nave qualsiasi. Sarà un viaggio indimenticabile.
La nave, pensa Sebastiano guardandosi intorno, è davvero enorme, è pulita e ha il buon odore della vernice fresca. È stata progettata per accogliere 3547 persone tra equipaggio e passeggeri, portandoli in poco meno di una settimana da una costa all’altra dell’Atlantico tra lussi considerevoli e grandi comodità sia in prima sia in seconda classe; a bordo vi sono 3560 giubbotti e 16 scialuppe di salvataggio, più 4 canotti, come richiesto dalle norme dell’epoca per le navi superiori alle diecimila tonnellate di stazza.
Il fatto che il Titanic di tonnellate ne conti quasi cinque volte tanto non sembra preoccupare nessuno, tantomeno Sebastiano. L’uomo è affascinato dal fatto che il transatlantico possa vantare una potenza di quarantaseimila cavalli, ottenuta dalla messa in funzione di ben ventinove mastodontiche caldaie. A pieno regime, si calcola che arrivi a consumare 725 tonnellate di carbone ogni ventiquattro ore. Vi sono inoltre colossali motori che muovono due enormi eliche laterali e l’elica centrale. Le tre eliche, spinte al massimo – è scritto sull’opuscolo consegnato ai passeggeri all’imbarco – possono assicurare al bastimento una velocità di 24 nodi (oltre 45 chilometri all’ora, stupefacente per quel tempo). Sul ponte, poi, Sebastiano ha notato anche le gigantesche ancore: un ufficiale gli ha raccontato che l’ancora principale pesa quindici tonnellate e mezzo, e per il suo trasporto dalla fabbrica ai cantieri navali ci sono voluti venti cavalli da traino. E che dire quando viene a sapere che ciascuna maglia delle catene delle ancore raggiunge il peso di ben 385 chili? Il Titanic, pensa Sebastiano, è veramente una montagna d’acciaio!
A Queenstown, il giorno dopo la partenza dalla Francia, una volta portate a termine le operazioni di imbarco dei passeggeri – mentre all’interno del transatlantico la gente si sposta per raggiungere i propri alloggi –, Sebastiano, al pari di altri curiosi, viene attratto da qualcosa di insolito: l’apparizione in cima a un fumaiolo di una presenza diabolica. In realtà, verrà a sapere poi, si trattava di un fuochista che aveva voluto giocare uno scherzo agli amici che lo seguivano e si era affacciato da uno dei camini. Sebastiano, da uomo pratico, poco incline a credere alle profezie, non fa caso alle parole di chi vede in quell’episodio un cattivo auspicio.
In quei giorni di viaggio ha modo di leggere il giornalino che viene stampato e distribuito a bordo, l’Atlantic Daily Bulletin, dove apprende fra l’altro che il Titanic trae il suo nome dai Titani, potenti figure mitologiche che avevano regnato sull’universo fino a che, dopo una sanguinosa lotta, non avevano dovuto soccombere a Zeus e alla sua corte. Alla loro disfatta, il nuovo re dell’Olimpo li condannò a precipitare nelle profondità della terra e a restare per sempre banditi nelle tenebre. Nel giornale si racconta che Joseph Bruce Ismay, il direttore della White Star Line, e Thomas Andrews, il principale progettista dei cantieri Harland & Wolff di Belfast – dove il Titanic è stato costruito e allestito –, hanno creato qualcosa di meraviglioso, superiore alla gemella Olympic: le innovazioni a bordo rendono la nuova ammiraglia diversa da tutto ciò che si era visto prima.
Per Argene e Sebastiano il tempo trascorre sereno, e in più a lei, incinta e soggetta a continue nausee, un po’ d’aria di mare non può che fare bene. Se, nei momenti di svago, Argene desse un’occhiata nella biblioteca di seconda classe, troverebbe un volumetto, un romanzo del 1898 intitolato Futility. Non un è gran libro, è solo letteratura di evasione, una lettura leggera adatta magari per passare qualche ora prendendo il sole su una sdraio. Se Argene lo leggesse, scoprirebbe la storia, immaginaria, di un’altra nave. L’autore, Morgan Robertson, scrive di un transatlantico chiamato Titan che finisce in rotta di collisione con un iceberg nel Nord Atlantico e affonda in poche ore, in una notte d’aprile, portando con sé quasi tutti i suoi passeggeri. Il Titan del romanzo, descritto quando il Titanic doveva ancora essere concepito, ha vari elementi in comune con la quasi omonima nave reale: una lunghezza e una stazza simili, la velocità, il numero di eliche, il fatto di portare a bordo una dotazione di salvataggio insufficiente e di essere definito inaffondabile.
Ma con ogni probabilità, alla giovane donna, fresca di matrimonio e già incinta di due mesi, il volumetto scritto quattordici anni prima non susciterebbe alcun interesse. Neanche Sebastiano perderebbe tempo a leggere Futility e, se anche lo leggesse, non si lascerebbe di certo impressionare. Non è uomo che crede al soprannaturale, alle profezie o ad altre sciocchezze simili: è pragmatico. Se invece i vertici della White Star Line avessero letto Futility, avrebbero avuto di che riflettere, tanto quel romanzetto da due soldi suonava come una terribile profezia per il loro gigante del mare.
In quei giorni spensierati di navigazione, con tempo buono e mare calmo, i due sposini fanno conoscenza anche degli altri italiani che viaggiano in seconda classe: uno di loro, Emilio Portaluppi, di Arcisate, nel comasco, è un signore in gamba e l’ha dimostrato arrivando a pagarsi la cabina di seconda classe sul Titanic grazie al frutto del proprio lavoro. Sta ritornando in America e, con i risparmi messi insieme – un discreto gruzzoletto –, intende trasferirsi definitivamente nel Nuovo Mondo con la certezza di potercela fare.
I coniugi Del Carlo a bordo conoscono anche un fiorentino, Emilio Mangiavacchi, classe 1864. Reduce da un soggiorno in Italia, Mangiavacchi sembra contento: può finalmente iniziare il viaggio di ritorno dalla sua Nella, che aspetta un bambino. Da toscanaccio verace, Emilio si lascia andare e confida ai due lucchesi che c’è qualcosa nell’aria che non lo fa sentire tranquillo. Però non sa cosa: lui non teme il mare, tanto meno considerando la nave poderosa sulla quale si trova. Ma è una sensazione che ha cominciato a provare appena messo piede sulla passerella ed è aumentata a mano a mano che si inoltrava nel bastimento In poche parole, Emilio prega che quel viaggio finisca presto.
Sebastiano e Argene apprendono che sul Titanic viaggiano altri trenta connazionali: i camerieri imbarcati dal manager, anche lui italiano, Gaspare Antonio Pietro Gatti, originario di Montalto Pavese, responsabile del fastoso ristorante di prima classe À la carte. Essere stati scelti dal Gatti per servire sul Titanic significa avere in mano una carriera sicura. Inoltre, per quelli più bravi, c’è anche la possibilità di essere notati da qualche milionario americano che potrebbe assumerli per una delle proprie dimore, con tutti gli agi che un simile lavoro comporta.
A bordo del Titanic sono imbarcati i più importanti esponenti dell’alta società americana. Il nostro Sebastiano potrebbe avere l’opp...