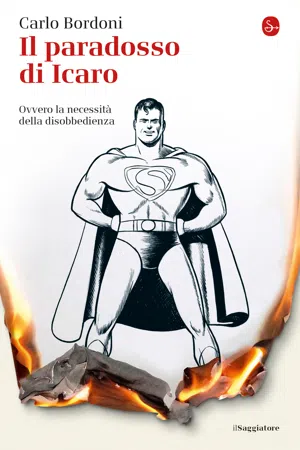![]()
1. Hybris. Dal mito alla modernità
Prima ancora di essere Homo sapiens, creatura che pensa, l’uomo è una creatura che spera.
ZYGMUNT BAUMAN
I. L’idea di cultura
Si dice che l’uomo sia un animale sociale. Ed è vero, perché non saprebbe vivere senza la presenza dei suoi simili. Può stringere o allentare i legami, fino a renderli impalpabili o simbolici, grazie agli strumenti più sofisticati della comunicazione, ma non può farne a meno, poiché la sua identità, assieme alla coscienza di sé, si mantiene solo in rapporto all’altro, lo specchio in cui riflettersi.
Tuttavia è anche un animale culturale: esigenza altrettanto forte e indispensabile alla sopravvivenza. La cultura nasce come l’insieme delle pratiche e dei riti (appunto, il «culto») che l’uomo celebra in onore degli dèi, verso i quali prova deferenza e timore per il loro potere sovrumano, e che osserva e tramanda di generazione in generazione per assicurarsene e mantenerne il favore. Cultura non è solo il sapere o il bagaglio di conoscenze accumulato attraverso lo studio e l’esperienza, ma soprattutto le forme del comportamento, delle convinzioni e delle finalità della vita umana che coinvolgono l’etica, l’estetica e la percezione sensuale. Già da questa prima rudimentale definizione dell’ambito della cultura si comprende come essa sia strettamente legata al sociale e ne costituisca l’ossatura. Non c’è relazione sociale che non implichi la cultura e non c’è cultura che non dipenda dalla società.
La cultura si manifesta pertanto nella «definizione» – proprio nel senso di inquadramento e limitazione dei confini (da qui la sua funzione di controllo sociale) – dei canoni di giustizia, fattibilità, necessità, speranza, bellezza, bontà. Il kalos kai agathos (bello e buono) dei greci comprende, in primo luogo, i princìpi su cui si fonda la vita umana, e quindi la religione, l’etica più primitiva, assieme alla tradizione, cioè a tutto l’insieme delle esperienze accumulate.
A differenza degli altri esseri viventi, l’animale uomo è l’unico in grado di trasmettere ad altri la propria cultura e di farne un patrimonio sociale. Una capacità straordinaria che gli deriva dallo sviluppo di un cervello pensante, da una memoria complessa e da una manualità duttile (il famoso pollice opponibile) che gli permette di prendere, fare, costruire. Il solo pensare, senza il saper fare, non sarebbe stato sufficiente: è la loro compresenza e interazione ad aver determinato lo sviluppo umano.
Sicché cultura è tutto ciò che l’uomo ha messo insieme con il suo saper pensare e il suo saper fare. Un insieme che può essere caratterizzato da una materialità consistente (l’edificazione e la trasformazione del territorio, la realizzazione di manufatti e strumenti), ma che non prescinde da un enorme significato simbolico. Una grande costruzione simbolica articolata, complessa e diversificata, a seconda dei luoghi e dei tempi, che nasce dalla finalità di controllo di sé e del mondo. Dare una lettura culturale del mondo che ci circonda significa connotarlo, riconoscergli un senso a misura della comprensibilità umana; magari anche giustificarlo. In ogni caso assegnandogli regole che possono essere conosciute, poiché la conoscenza è essenzialmente una forma di potere.
Ne consegue una conferma decisiva del «bisogno» sociale dell’uomo, della sua esigenza vitale di essere ri-conosciuto, giustificato e valorizzato come persona. Per sopportare la sua marginalità, la sua immensa solitudine cosmica, si è dato regole, cultura e conoscenza: un lungo e doloroso processo autoreferenziale finalizzato a dominare lo spazio e il tempo della sua esistenza. Un processo che deve essere continuamente messo in discussione, riformulato e aggiornato a mano a mano che gli orizzonti si ampliano e l’evidenza dell’occasionalità e della limitatezza umana si fa più stringente. Riconferma la sua innata hybris, che qui appare, più che un peccato di superbia, una necessità biologica che consente l’evoluzione.
L’idea della vita come continua trasgressione delle regole può apparire socialmente minacciosa, giustificare l’eversione, l’aggressività, la distruzione dell’ordine costituito, il disprezzo delle regole della civile convivenza. Si tratta invece, a ben guardare, di due livelli diversi che non possono essere confusi, né generalizzati. Il rispetto delle regole civili, assieme alla cultura e all’ordine sociale, ha una funzione di mantenimento e di contenimento/controllo sul medio periodo, rapportabile alla durata della vita umana nell’arco di più generazioni. È quello che fa percepire la continuità ordinata della quotidianità, la cui alterazione è oggi avvertita come «liquida» e perciò insoddisfacente ai nostri occhi.
La creatività, la hybris, la disobbedienza sono invece concezioni evolutive sul lungo periodo, di cui l’uomo spesso non ha una precisa percezione, se non dopo che si sono avverate e attestate, poiché concretizzate in tempi che, per la loro estensione, sono sottratti all’azione diretta di uno o più individui, ma riguardano l’intera specie.
Sono, per così dire, eventi «biologici» o «strutturali», che maturano per accumulo di concause diverse e si realizzano soltanto se si verificano certe condizioni. L’evoluzione, come hanno dimostrato la biologia in campo scientifico e l’antropologia in quello culturale, procede per «casualità necessarie»: non è predefinita, né unidirezionale.
Per questo l’idea di progresso è un’illusione destinata a infrangersi contro la realtà di un futuro imperscrutabile, mentre denuncia la sua matrice intrinsecamente culturale. Ciò non toglie che ci siano eventi nella storia (e nella preistoria) dell’uomo che possono essere considerati significativi e preparatori di un mutamento epocale; siano essi lo sterminio dei nati con la prevalenza dell’emisfero destro del cervello, da cui il mito di Erode e della strage degli innocenti, oppure il volo di Icaro, la Rivoluzione francese o le odierne grandi migrazioni.
Ogni indizio socialmente significativo è il segnale di un possibile cambiamento, ma non è garantito che produca qualcosa di diverso nel nostro futuro: molto più probabile che resti un evento isolato e che ciò che invece produrrà mutamenti sconvolgenti, vere conseguenze di una hybris indomita, passi inosservato.
II. Una presunzione infinita
La storia dell’uomo è la storia di una hybris sconfinata. Fin dalle origini il suo desiderio di migliorare incessantemente lo spinge a muoversi, conoscere, sfidare, sperimentare. All’inizio è una questione di sopravvivenza: proteggersi dal freddo, trovare cibo per alimentarsi, lasciare i luoghi divenuti inospitali, difendersi dall’aggressione degli animali e degli altri uomini. Poi si traduce in una pratica abituale, una ragione di vita: perde le motivazioni effettive e si sublima, facendosi una questione di principio, un «modus vivendi» perpetuato nel tempo.
Principalmente sono due le cause di questo comportamento: la prima è che l’uomo è l’animale più fragile, indifeso e debole esistente in natura. «L’animale non ancora stabilmente determinato», come lo definisce Friedrich Nietzsche, ma era una verità ben nota fin dai primordi. La seconda è che per una serie di motivi, non ancora indagati sino in fondo, ha sviluppato la capacità di pensare. Una capacità particolare che lo distingue dagli altri esseri viventi e ne fa un privilegiato nel mondo che conosciamo.
Un processo che tuttavia non è avvenuto immediatamente. Sono dovute passare decine di migliaia di anni perché l’uomo si rendesse conto di questa capacità, e solo dopo oltre un millennio dall’introduzione della scrittura – la più raffinata tecnologia di sviluppo della conoscenza – ha potuto affermare, quasi con stupore, attraverso le parole di un abitante del XVII secolo, René Descartes, «Penso, dunque sono». Si tratta della presa di coscienza di un’antica abilità acquisita – almeno per quanto sappiamo del mondo occidentale – attraverso un lungo processo evolutivo che ha portato alla prevalenza dell’emisfero sinistro del cervello rispetto a quello destro, centro delle attività emotive e istintuali.
Prima di allora l’uomo non era distinguibile dagli altri animali: si muoveva in branco, mosso dall’istinto di sopravvivenza, incapace di pensare e di pensarsi come essere distinto dagli altri esseri viventi. Tutt’uno con i suoi simili e col mondo che lo circondava. Viveva in uno stato di incoscienza perenne: quello stesso stato a cui si può tornare artificialmente anche adesso, facendo uso di droghe o alcolici, cioè di inibitori della coscienza di sé. Una regressione verso una condizione «pacificatrice», dalla quale l’uomo è costantemente attratto – quasi affascinato dall’annullamento del proprio essere – e che equivale, sul piano psicologico, alla «pulsione di morte» (la Todestrieb di Freud), sia pure limitatamente alla perdita dello stato di coscienza e non certo riferita alla morte fisica.
Una condizione di equilibrio naturale, perfettamente riproducibile all’infinito, se qualcosa non avesse modificato le sinapsi, magari solo accidentalmente, e non avesse acceso la luce che ha portato a distinguere sé dall’altro; a sentirsi «uno» rispetto ai molti; a percepire la propria individualità, primo barlume d’intelligenza.
La presa di coscienza individuale è un allontanamento dal mondo, una presa di distanza; il primo nucleo di una riflessione interiore. Il parlare a se stessi, successivamente alla pratica di comunicare con gli altri. Il che dimostra come la comunità, l’insieme indistinto e condiviso di tutti gli esseri, preceda l’individualità, momento più avanzato o stadio della coscienza evolutiva.
Gli studi più recenti collocano questa evoluzione in un tempo abbastanza prossimo a noi, se consideriamo la lunga traccia della presenza umana sulla terra, che continua a spostarsi a ritroso: la formazione della coscienza è databile tra i duemila e i tremila anni prima di Cristo. Quindi non più di quattro-cinquemila anni dal presente, da quando l’uomo ha cominciato a sentirsi individuo e a «pensare». Da quando ha cominciato, cioè, a distinguersi dagli altri e dal mondo che lo circondava, la natura, di cui fino a quel momento si era sentito parte integrante.
L’idea di appartenenza dell’uomo alla natura ha origini antiche. Risale alla primigenia condizione d’incoscienza, stante la quale non era percepibile la differenza tra sé, il soggetto, e il mondo esterno. Tutto era visto come immanente, assoluto e continuamente presente. L’incapacità di distinguere se stesso dall’altro, da qualsiasi altro essere vivente o oggetto esterno può essere considerata – e lo è stata per lungo tempo – una condizione «animalesca», dato che si è sempre ritenuto l’animale incapace di maturare una consapevolezza di sé.
Più recentemente è stata accolta la tesi secondo la quale anche gli animali sono esseri «senzienti»: capaci non solo, quindi, di provare emozioni e dolore (cosa già ampiamente dimostrata), ma anche di percepirsi come esseri distinti gli uni dagli altri e quindi di «pensarsi», in forma ovviamente diversa da quella umana, in una sorta di «cogito» in versione relativizzata, che tuttavia ha una sua dignità e una struttura psicologica di tutto rilievo.
La condizione di assoluta «indifferenza» propria dell’uomo delle origini può allora essere ben definita «pre-animalesca», poiché ancora non aveva raggiunto l’attuale sviluppo degli animali superiori che conosciamo. Ed è in questa condizione che si annida il germe dell’animismo, cioè il convincimento che, in sostanza, non esistano distinzioni tra gli esseri viventi e il mondo naturale, uniti inscindibilmente dalla stessa partecipazione alla materia, e che, in secondo luogo, grazie a questa fratellanza universale, vi sia una corrispondenza, una relazione di sensi che, come ogni rapporto, necessita di rispetto, attenzione, correttezza. Ne può dipendere un senso di protezione e di conforto, ma anche effetti indesiderabili in caso di offesa arrecata alla natura (nemesis).
Le prime osservazioni sono avanzate dai greci: si parla di «animismo» per sostenere la presenza di uno spirito (pneuma) nella materia. Per Talete tutto è «animato» poiché possiede il principio del movimento e per Democrito l’anima è anche nelle pietre. Gli stoici pensano a un’animazione universale, mentre a Platone si deve l’estensione dell’«anima del mondo» agli astri, concetto ripreso da Virgilio e Cicerone e poi trasmesso al Medioevo.
Introdotto dall’antropologo inglese Edward Burnett Tylor (Primitive Culture, 1871) nell’ambito del paradigma evoluzionista per giustificare le differenze razziali, il termine «animismo» si segnala per aver definito la cultura come un insieme di valori acquisiti e trasmessi attraverso le generazioni successive. È ciò che viene comunemente inteso come «tradizione», anche se la tradizione, cioè la conoscenza trasmessa attraverso le generazioni, in cui si accumulano e si sedimentano nozioni, credenze, informazioni che, per il motivo stesso di appartenere al passato, vengono accettate acriticamente, può – se mal interpretata – costituire un problema. Non è un caso che alla tradizione si riferiscano sempre i movimenti reazionari, i quali, nell’incapacità di guardare al futuro, alle sue incognite e alle sue innovazioni (pericolose, perché rischiano di mettere in discussione i diritti acquisiti) si rifanno ai valori del passato, in quanto dati oggettivi indiscutibili e considerati necessariamente positivi.
Sulla tradizione si sono sempre basate le religioni e in genere tutti i movimenti confessionali, ma purtroppo anche le ideologie autoritarie e gli stati totalitari, confidando nel principio irrazionale che ciò che è stato in passato possa essere interpretato nel presen...